 |
|
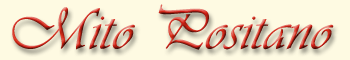 |
|
ROMA ARCAICA
|
|
|
|
ROMA ARCAICA - STORIA,
FILOSOFIA E LETTERATURA |
LA TRADIZIONE LETTERARIA Le narrazioni sulle fasi più antiche della storia di Roma vennero svolgendosi,
nel quadro della storiografia romana, dalla fine del III secolo
a.C. all’età augustea con un processo di continuo arricchimento,
fino ad un punto di arrivo che per noi è rappresentato dalle opere letterariamente
costruite ed atteggiate di Tito Livio e Dionigi d’Alicarnasso.
Differenti negli intenti storiografici e politici ed anche nella
tecnica compositiva e per taluni aspetti anche nell’uso di fonti e di
documentazione precedenti, esse non pertanto rappresentano lo stadio
finale di una lunga rielaborazione di molti e svariati materiali tradizionali
che, al di là delle loro prime traduzioni in forma letteraria
con Fabio Pittore e Cincio Alimento, rimontavano ad opere di storici
greci, che in vario modo avevano considerato Roma ed il mondo
italico: più indietro ancora esse si rifacevano a filoni di notizie trasmesse
oralmente, o ricavate da documenti e da monumenti, notizie
che talora non erano neppure di origine romana.
Da tempo si è guadagnato il principio teorico, che può e deve
diventare canone di metodo interpretativo, che studiare nelle sue varie
fasi storiche il farsi di questo complesso patrimonio tradizionale,
nelle sue varie motivazioni ed in rapporto al mutare delle circostanze,
significa propriamente esaminare lo stesso svolgimento della storia
di Roma, nei suoi aspetti politici, istituzionali, culturali. L’indagine
deve procedere a ritroso, risalendo dal più conosciuto e dal più sicuro
verso quanto è più incerto e più oscuro. Sembra molto probabile
che l’età fra il IV e il III secolo a.C. possa essere indicata come quella
che ha visto crearsi in forma abbastanza definitiva, nelle sue linee generali,
la struttura, che diverrà poi tradizionale, della rappresentazione
della storia di Roma arcaica.
1. Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica 14
Le due opere di Livio e di Dionigi presentano narrazioni dalle
origini fino all’incendio gallico molto difformi per estensione e organizzazione
dei materiali, che derivano dalle differenti premesse di
metodo critico dei due autori, dal loro diverso programma storiografico
e letterario; tuttavia entrambi hanno rielaborato in fondo lo
stesso materiale offerto dall’annalistica romana (nelle sue pur distinte
fasi di sviluppo) e ad entrambi è presente un’idea abbastanza simile
della storia della città, del suo sviluppo, del suo quadro istituzionale.
La molto maggiore ampiezza della narrazione dionisiana dipende essenzialmente
dall’intento di fornire a lettori greci un’iniziale ricostruzione
etnografica del popolo romano e poi dalla precisa volontà di
offrire fin nei dettagli quello che si riteneva che avrebbe dovuto essere
lo svolgersi effettivo di episodi storici, taluni considerati di valore
epocale, alla ricerca di una verisimiglianza che nel pensiero dello
storico greco finiva per divenire una sorta di verità inerente agli episodi
stessi, al di là dell’aderenza alle evidenze reali offerte dalle testimonianze.
È questo un processo storiografico erroneamente definito talora
come retorico, anche per la larga presenza di discorsi collocati là
dove l’episodio li doveva di necessità presumere (si deve prescindere
naturalmente dall’ovvio impiego di strumenti retorici nell’attuazione
di questo programma). Il procedimento risponde invece alla concezione,
basilare, di un ripetersi della storia per la costante coerenza
della natura umana. Già Tucidide da questo rilievo traeva la conclusione
della validità anche pratica della sua opera per i politici del futuro,
ma anche ne ricavava la possibilità, altrettanto pratica, di ripensare
e di ricostruire il passato. Nel caso romano si aggiungeva la immaginata
continuità istituzionale, con la conseguenza di una probabile
e possibile ricostruzione del passato sull’esperienza della realtà
del presente. Di qui non soltanto la possibilità di ritrovare nel passato
problemi politici contemporanei, ma anche di immaginare lo stesso
passato, e di ricostruirlo concretamente, in termini inevitabilmente
attualizzanti e deformati, in quanto si applicavano modelli interpretativi
ricavati dalla vicenda politica contemporanea. È innegabile che lo
stesso “conflitto degli ordini” risente, nelle sue motivazioni e nei suoi
modi di svolgimento, quali ci sono presentati nelle tarde opere storiche,
di caratteri tratti dai contrasti politici del II e I secolo a.C.
A fondamento di questa continuità e coerenza storiografica e politica
stava la concezione di uno sviluppo lineare e “statale” della vicenda
storica romana, che, al di là di Livio e di Dionigi, e di Cicerone,
risale alle origini della storiografia romana e agli stessi ripensamenti
Livio
e Dionigi
1.3. Drammaturgia 15
strutturali che l’avevano preceduta.
Sembra che vi sia un accordo generale nel ritenere che la prima
storiografia romana sia sorta verso la fine del III secolo a.C. nel quadro
e secondo i principi della storiografia “locale” greca, ma con intenti
politici, dimostrati dallo stesso impiego iniziale della lingua greca,
rivolti soprattutto al mondo magnogreco e siciliano e poi, più generalmente,
greco, in vista di un accoglimento di Roma in una comunità
culturale e politica riconosciuta superiore. Fabio Pittore non esitava
a servirsi di fonti greche, e a citarle, per la stessa storia arcaica
della sua patria.
Questa esigenza di avvicinamento al mondo greco andò crescendo,
anche a livello storiografico, pur con un cambiamento di tono, in
concomitanza con l’espansione imperialistica romana, fino a quando,
attenuatasi la necessità di autogiustificazione anche di fronte alle ricorrenti
accuse di barbarità originaria, si verificò un deciso cambiamento.
La storiografia romana dalla metà del II secolo, e anzi già con
le Origines di Catone, pur conservando una particolare attenzione
alle vicende delle origini e alla presenza in quella fase di fattori
nobilitanti di grecità (mentre importavano molto meno quelli di una
pur ammessa presenza etrusca), andò piuttosto rivolgendo i propri
interessi ai problemi della politica interna della città, fino a divenire
nel I secolo a.C. uno strumento nell’ambito di un più complesso
scontro ideologico, il che favorì quel processo di attualizzazione della
storia del passato, ora accennata e sul quale si avrà occasione di
ritornare.
Questo precisarsi e modificarsi di interessi politici legati al fatto
storiografico ebbe significativi riflessi sulla stessa struttura narrativa
delle opere storiche dalla fine del III secolo all’età augustea. Non è
difficile immaginare che un processo analogo avesse subìto anche la
formazione della tradizione storica nelle età precedenti, reso più
complicato dal carattere prevalentemente orale della trasmissione
delle notizie e della ricostruzione storica.
Orbene la più antica annalistica è così descritta in un passo famoso
di Dionigi, 1.6.2, che, parlando di Fabio Pittore e di Cincio Alimento,
dice: «l’uno e l’altro di costoro, gli avvenimenti ai quali essi stessi
parteciparono, narrarono con precisione per la conoscenza diretta
che ne avevano, ma i fatti antichi, quelli accaduti posteriormente alla
fondazione della città, li scorsero per sommi capi». Il passo si presta
ad interpretazioni in parte divergenti a seconda che si intenda il termine
ktisis, secondo esempi greci, con un valore più ampio che non
la vera e propria “fondazione” della città, e comprendente il periodo
Storiografia
in lingua
latina
1.1. La tradizione letteraria
1. Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica 16
connesso alle origini (nel caso in questione, l’età regia), oppure con
un significato più ristretto. In ogni caso l’evidenza fornita dai magri
frammenti sopravvissuti conduce all’accordo su taluni punti.
Vi è un certo carattere unitario della più antica storiografia romana,
da Fabio Pittore a Catone, a Calpurnio Pisone (console nel 133
a.C.) e comune anche agli Annales di Ennio (un poema epico dalle
origini della città agli inizi del II secolo a.C.): l’interesse prevalente
degli autori per l’età contemporanea e per quella più prossima a questa
(grosso modo a principiare dalle guerre sannitiche), e quindi una
loro narrazione più ampia, sembrano essersi accompagnati ad una
tradizione relativamente ricca per il periodo delle origini e per l’età
regia. Per contro i racconti tradizionali, che per la fase di trapasso
dalla monarchia alla repubblica sono caratterizzati da un tono particolarmente
ricco di fantasia e di colore, si presentano molto più scarni
per il V secolo, ed anzi le notizie a disposizione degli storici sembrano
ancora diminuire lungo la seconda metà del secolo.
Questa disposizione non può essere casuale. In linea generale, si
può pensare che per il periodo delle origini e anche per quello dei re
vi sia stato già nella storiografia greca, dalla fine del IV secolo, un
diretto interesse a richiamare la storia di Roma nell’alveo di quella
greca; questo interesse è connesso direttamente con l’affacciarsi di
Roma in Campania e in Magna Grecia. Il convergente interesse dei
Romani in quella stessa direzione è testimoniato dall’accettazione
supergiù in quello stesso periodo del mito di Enea, che tuttavia deve
aver combattuto, o convissuto, per qualche tempo con quello di
Odisseo. Le più antiche notizie, nel patrimonio mitico e leggendario
greco, riconducibili direttamente o indirettamente a Roma, e meglio
all’area laziale dove poi sarebbe sorta la città, sono legate alle tradizioni
della colonizzazione greca in Occidente (Teogonia di Esiodo:
prima metà VI sec.; Ellanico: fine V sec.).
I riferimenti crebbero nel tempo: essi si inseriscono senza nessuna
particolare rilevanza nella tipica rielaborazione etnografica greca
relativa alle popolazioni barbare con le quali i coloni greci venivano
in contatto. Queste notizie (alcune delle quali, più antiche, si riferiscono
in realtà al mondo etrusco, col quale i greci avevano più strette
relazioni) si collocano quindi all’interno di un processo culturale legato
alla colonizzazione greca. La localizzazione in Occidente di miti
greci, soprattutto connessi con la guerra di Troia e il ritorno degli eroi
da essa, fu opera di mercanti e coloni greci e rappresentò per essi un
fattore legittimante e nobilitante. Per questa via le popolazioni indigene
a contatto con i greci recepirono e fecero propri miti e leggende
Grecia
e Roma
1.3. Drammaturgia 17
dei quali erano venuti a conoscenza e si creò quindi una sorta di patrimonio
comune, nel quale non è facile riconoscere la parte spettante
alle tradizioni locali. Si venne creando un complesso di tradizioni,
genealogie e leggende per i popoli e le città dell’Occidente. In questo
lungo e lento processo di localizzazione, ricezione e utilizzazione di
miti Roma non ebbe per molto tempo nessun ruolo di speciale preminenza,
tale da richiamare una particolare attenzione della storiografia
greca.
Non è chiaro né come né quando né per quali ragioni le origini
romane vennero collegate con la fuga in Occidente di Enea e dei suoi
Troiani. Sicuramente diverse furono, ad un certo momento, le intenzioni
con le quali da parte greca fu proposto quel collegamento e
quelle con le quali da parte romana la connessione fu accettata. L’accettazione
certamente mirava a stringere sempre più i rapporti fra
Roma e il mondo greco suditalico, e a sganciare Roma dagli Etruschi:
siamo nel IV secolo. Nella seconda metà del secolo Roma è oramai
presente in Campania. L’accoglimento del mito eneico creava problemi
complicati di cronologia e fu necessario colmare lo iato fra l’arrivo
di Enea e la “fondazione” della città con la serie dei re Albani, i quali
sono già noti alla storiografia greca prima di Fabio Pittore. Ancora più
singolare deve essere considerato l’accoglimento in Roma della leggenda
di Romolo e Remo, probabilmente di origine locale, ma
rielaborata anch’essa nel IV secolo, forse in connessione con eventi
politici contemporanei. È molto importante che questo mito dei gemelli,
ricco di aspetti non precisamente positivi, sia stato abbastanza
rapidamente accettato anche come patrimonio popolare (si è pensato
come tramite alle manifestazioni teatrali in occasione dei ludi).
Quando, di fronte all’incredibile avanzata dei Romani, popolazione
semibarbara, in Italia e nel Mediterraneo, con le vittorie su
Pirro e su Cartagine, il mondo greco cominciò seriamente, con Timeo,
ad interessarsi a Roma, l’attenzione si rivolse, più che alla storia
arcaica della città, alle sue istituzioni politiche e militari, nelle quali
presto si riconobbe una delle ragioni della superiorità romana; questa
attenzione si concluse con il VI libro delle Storie di Polibio.
Vanno fatte alcune precisazioni. Connessioni di Roma con l’ambito
suditalico risalivano già con sicurezza agli inizi del V secolo (introduzione
del culto di Ceres, Liber e Libera), e dovevano essere propriamente
ben attestate anche sul piano documentario, per esempio
a Cuma. Inoltre, se si accetta l’idea che Fabio Pittore avesse davanti a
sé una tradizione già ampiamente elaborata e ricca di elementi greci,
o suggeriti da storici greci (da ultimo da Timeo), non si deve affatto
1.1. La tradizione letteraria
1. Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica 18
credere che questa tradizione non abbia a sua volta valorizzato elementi
antichi, trasmessi tradizionalmente nello stesso ambito romano,
che puntavano nella stessa direzione: basti pensare alle antiche,
variegate versioni sulla storia di Demarato e di Tarquinio.
Ad ogni modo va ribadito con forza da un punto di vista metodologico
che la presenza, messa in chiara evidenza dalla più recente
ricerca archeologica, di reperti greci a Roma per i secoli VII e VI,
come anche il possibile rapporto comparativo di monumenti greci e
romani, e pur l’altrettanto probabile derivazione greca di vocaboli latini,
rappresentano dati documentari non comparabili con quelli offerti
dalla tradizione letteraria e quindi, in definitiva, da non chiamare
in supporto all’attendibilità della medesima. Le teorie della presenza
di componenti greche nella tradizione storica di Roma arcaica hanno
origini differenti di carattere ideologico e politico ed approderanno
alla fine alla suggestiva proposta di Dionigi di un’originaria
grecità dei Romani e quindi ben anteriore alla penetrazione culturale
greca nell’età successiva alla guerra annibalica. Quella teoria, anche
se talora elaborata su materiali antiquari e con acuti ragionamenti
antropologici e comparatistici, rispondeva ad una precisa esigenza
politico-culturale contemporanea dello storico ed era stata costruita
per questa funzione.
La più tarda rielaborazione annalistica dei racconti sui re ha accentuato
e arricchito anche questi anteriori elementi di ascendenza
greca. Basti citare i tratti caratteristici della propaganda antitirannica
che si sono sovrapposti alla tradizione su Tarquinio il Superbo e si
sono inseriti nella narrazione relativa a Spurio Cassio: essi nella versione
dionisiana richiamano direttamente la pubblicistica greca su
quel tema e le polemiche del I secolo a.C. a Roma. Anche la storia
“politica” del V secolo è stata rifatta dall’annalistica del II e del I secolo
fino a rendere difficile sceverare i pochi dati attendibili. Per esempio,
tutta la problematica relativa alle contese sull’ager publicus è
completamente anacronistica ed è esemplata sulle condizioni proprie
dei secoli III e II. Dell’ager publicus, sia caso o meno, non vi è
neppur cenno nelle Dodici Tavole per quanto ci è noto, e si può anzi
aggiungere che tutto il problema agrario quale è delineato da Livio e
da Dionigi dall’età di Romolo in avanti, nel quadro della società romana,
si viene svolgendo con una lineare coerenza per fare da premessa
a quelle che saranno le vere questioni agrarie, nate dopo le
ampie acquisizioni di terra in Sabina agli inizi del III secolo. Il che
non vuole naturalmente dire che si abbia a respingere la più che probabile
spiegazione che nel conflitto fra patriziato e plebe entrassero
Ricostruzioni
dell’annalistica
1.3. Drammaturgia 19
anche aspetti sociali ed economici: soltanto che essi sono stati stravolti
ed offuscati dall’attualizzazione operata nell’età della tarda repubblica.
Come è stato anche di recente ribadito, spunti per lo studio
della più antica società agraria romana e italica possiamo recuperarli
dal calendario Numano.
Il caso della legge delle Dodici Tavole pare ancor più emblematico.
È indicativo che la nostra tradizione storico-letteraria non dica
praticamente nulla dei contenuti della legge, che noi cerchiamo di ricostruire
sulla base di citazioni e di riferimenti forniti dall’antiquaria
e da testi giuridici, se si eccettuano qualche confronto in Dionigi con
il testo delle presunte leggi regie e il divieto del connubium, mentre
ci si dilunga sulla improbabile “storia esterna” dell’episodio. È più
che legittimo in questo caso, non già negare la collocazione alla metà
del V secolo della codificazione o la validità del testo trasmessoci
(come torna oggi ad essere proposto), ma mettere in discussione il significato
della legge intera intesa come esito di una pressione dal
basso. L’esame comparativo condotto dall’Eder (nel volume edito dal
Raaflaub: vd. Bibliografia) con codificazioni aristocratiche sembra
suggerire piuttosto che la legge debba essere vista come prodotto
della volontà di autoregolamentazione dei gruppi aristocratici e come
fissazione di una situazione già in essere (il che fra l’altro è affermato
da Dionigi). Anche le norme limitative del lusso funerario e del
lutto riconducono alla monumentalizzazione dei sepolcri, tipico
modo aristocratico di affermazione e di contrasto in società arcaiche.
E non vi è alcuna ragione di pensare ad influenza di analoghe norme
soloniane. Fra l’altro la tradizione di un’imitazione di leggi greche
nelle Dodici Tavole, tramite un’ambasceria inviata ad Atene o in Magna
Grecia o la collaborazione di Ermodoro, è con ogni probabilità
tarda invenzione annalistica, con intento nobilitante. L’interpretazione
“popolare” della legge si colloca notoriamente come conclusione
di quella visione lineare e progressiva della storia politica di Roma.
Un ragionamento non diverso va fatto a proposito delle ricostruzioni
“costituzionali” di Romolo e di Servio Tullio, coerenti nella loro
consequenziarietà, specialmente evidente nell’ampio discorso dionisiano.
Ma le coincidenze con il testo ciceroniano del De re publica
(del 52 a.C.) e in più la presenza in Dionigi, anche a livello verbale, di
concezioni sociali e politiche derivate dalla Politica di Aristotele dimostrano
che ci si muove nel quadro ideologico e politico postsillano.
Naturalmente anche in questi casi la rielaborazione tardoannalistica
ha potuto sfruttare, selezionandoli, elementi talora di
molto più antica risalenza e attendibilità, riconducibili per esempio a
1.1. La tradizione letteraria
1. Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica 20
Fabio Pittore, alcuni dei quali si intrecciarono anche a filoni storici
non romani (etruschi, nel caso ben noto di Servio Tullio).
Un ragionamento analogo può essere fatto anche a proposito di
Numa Pompilio, alla cui caratterizzazione concorrono materiali già
elaborati dalla storiografia magnogreca del IV secolo, e tendenti a
prospettare una Roma dell’età regia socialmente e politicamente
avanzata. L’idea di un discepolato di Numa presso Pitagora durò a
lungo a Roma, anche quando oramai se ne era dimostrato l’anacronismo.
L’interesse per questa remota acculturazione era comune alla
Magna Grecia e a Roma.
Questo ragionamento non deve assolutamente meravigliare. Si
pensi al caso di Atene culturalmente tanto più progredita di Roma.
Eppure alla fine del V secolo le conoscenze che si avevano di storia
costituzionale di un passato non poi troppo remoto (l’età di Solone)
erano, anche sul piano propriamente documentario, assolutamente
carenti. Appunto l’opera politica e legislativa soloniana era scarsamente
nota al punto che si poteva imbastire una storia politico-costituzionale
della città secondo la prospettiva, ideologicamente costruita,
di una progressiva democraticità da Teseo a Teramene: questa
costruzione elaborata dalla pamphlettistica politica della fine del secolo
V è passata tramite le Atthides nell’Athenaion Politeia aristotelica.
Il caso romano è analogo.
È possibile che si riesca a guadagnare questo primo risultato nel
cammino a ritroso nella storia della tradizione storica su Roma arcaica.
Il momento successivo all’entrata romana in Campania e fino alla
guerra con Pirro pose su basi molto più ampie e complesse i rapporti
fra Roma e la Magna Grecia, soprattutto nel senso di scambi culturali
che possono anche essersi configurati come recezione in Roma di
istituti giuridico-politici (si pensi alla civitas sine suffragio, vale a dire
al riconoscimento della qualità di cittadino, ma senza il diritto di
voto). Si è già detto come sia venuto crescendo l’interesse magnogreco
per i romani, fino al tentativo di accaparramento pitagorico di
Numa Pompilio. Ripetiamo che è fra IV e III secolo che viene accolto
a Roma il collegamento delle origini cittadine con Enea, che diverrà
presto strumento di politica interstatale. Anche la leggenda dei gemelli
si consolida in quel tempo con apporti greci. Sarà infine Timeo
a collocare Roma e la sua storia nel quadro della grecità di Occidente,
anche sfruttando tradizioni anteriori, indigene e greche.
È importantissimo notare che è agli inizi del III secolo che si venne
precisando la tradizione sul ruolo di Bruto nella caduta della monarchia,
come può dimostrare la risalenza a quella data della statua
1.3. Drammaturgia 21
capitolina. Intorno al 300 si data anche la lupa degli Ogulnii sul
Palatino, e in generale sono da riportare alla stessa cronologia le statue
dei re davanti al tempio di Giove Capitolino, indizio di un consolidamento
della tradizione. Si possono agevolmente supporre motivazioni
politiche che si collocano nel quadro delle grandi trasformazioni
nella società romana e nello stato che si ebbero dalla seconda
metà del IV secolo. Il precisarsi della tradizione storica con l’accentuazione
degli elementi greci delle origini comportò verisimilmente
una riduzione del ruolo dell’Etruria per quella stessa età e in quella
della monarchia, proprio nel momento in cui gli Etruschi sostenevano
fino a Sentino la principale opposizione alternativa all’egemonia
di Roma.
1.2. I DATI DELL’ANTIQUARIA
Sui modi nei quali la tradizione sia andata organizzandosi si può prospettare
qualcosa di più che un’ipotesi. Alla base vi era già di sicuro
quell’idea di uno svolgimento lineare e progressivo dello stato romano
che si ritroverà poi sempre in seguito, anche se si ammetteva con
Catone (secondo la citazione di Cicerone, De re publica, 2.2) uno sviluppo
costituzionale con successivi apporti di generazioni; punto finale
di arrivo sarà la “costituzione” di Romolo. L’idea di “statalità”
sembrava acquisire concretezza con la proiezione nell’età regia di
istituti politici e giuridici perché così acquistassero, con la vetustà,
una maggiore legittimazione e avvalorassero l’idea di uno stato già
precisamente organizzato fin dalle origini: si pensi a questo proposito
anche al problema delle leges regiae (norme religiose e costituzionali
che una tarda tradizione attribuiva ai re). Si aggiunga la teoria di
una regolare fondazione della città, secondo il modello coloniario
greco (poi messa in discussione da storici greci antiromani), e inoltre
l’insistenza sul ruolo degli auspicia (vd. § 9.13) che, al di là delle interpretazioni
e sistemazioni antiquarie ed augurali del I secolo a.C.,
rappresentavano concretamente l’importanza, nelle mani dei patrizi,
della religione e dei riti tradizionali, in campo politico e la loro funzione
storica fin dai principi. La stessa storificazione dei miti e delle
origini sembra comportare consapevoli interventi di ordine religioso
e politico.
Questa delineazione complessa ed articolata dell’età regia veniva
necessariamente a condizionare anche il momento del passaggio dal-
1.2. I dati dell’antiquaria
1. Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica 22
la monarchia alla repubblica, nel senso che lo stacco poteva venire
“riempito” con una teoria (solo in parte nuova), quella di una progressiva
acquisizione di “libertà” fino al Decemvirato.
Il criterio della “statalità”, inteso come metodo ricostruttivo della
storia romana più antica, può prestarsi a suggestive nostre ricostruzioni
di quella storia. Chi nel IV secolo ripensava la storia più antica
della città e ne ricostruiva la tradizione avrà immaginato lo stato del
VI e V secolo in termini non molto difformi da quelli del suo tempo,
se pur su di una base territoriale più ridotta. Un punto pare, ad ogni
modo, di particolare rilevanza: la pratica dell’assimilazione e dell’integrazione
a tutti i livelli entro la cittadinanza romana propriamente
esercitata dal IV secolo in poi permetteva agevolmente di immaginare
una società altrettanto aperta nella Roma dell’età regia e protorepubblicana,
e quindi di recuperare nel quadro lineare ed unitario
componenti etniche di diversa provenienza con le relative tradizioni
storiche. Anche quello che è per noi il fenomeno importantissimo di
una mobilità, non soltanto delle élites, fra VI e V secolo nell’area etrusco-
laziale, attestato anche da tradizioni non romane, veniva riportato
nella cornice costituzionale di un apparato statale. Noi oggi insistiamo
maggiormente su di un altro aspetto di questo processo di assimilazione,
quello linguistico: pur significative presenze etrusche
nella Roma dell’età regia e pur significativi e antichi contatti con il
mondo greco (con la conseguenza di prestiti dal greco ben anteriori
all’età ellenistica) non hanno mai portato a condizioni di bilinguismo,
né scalfito il carattere latino della città.
La tipicità romana di questa ricostruzione della tradizione secondo
il criterio dello “stato” veniva a contrapporsi a differenti modi di
intendere e di rappresentare la storia. Si pensi agli affreschi della
Tomba François di Vulci (vd. § 2.1), come documento della storiografia
etrusca nella seconda metà del IV secolo, relativo a fatti storici
in diverso modo presenti anche nella tradizione romana. Pur considerando
che il mezzo pittorico della trasmissione ha imposto certe
regole, la ricostruzione ideologica antiromana di eventi storici comparati
ad analoghi dell’età dell’epica greca (il che, fra l’altro, sembra
dimostrare già avanzata l’equivalenza Troiani-Romani) appare sganciata
da un contesto “statale” e collocata in un’atmosfera mitica e simbolica.
Al di sotto della formazione della tradizione storica secondo il
criterio della “statalità” operavano molto probabilmente, ad un livello
profondo, parametri ricostruttivi di tipo ideologico-strutturale. Secondo
le teorie recentemente riformulate da Enrico Campanile e da
1.3. Drammaturgia 23
Enrico Montanari, è possibile che la coerenza del quadro tradizionale
sia anche dovuta alla continuità della presenza di un nucleo originario
di elementi culturali indoeuropei, che naturalmente non può contenere
dati storici attendibili, ma opera, ha operato, nel senso che i
ricordi degli accadimenti sono riferiti ed inseriti in un «preciso sistema
di valori, di usi e di esigenze». La mentalità indoeuropea deve essere
concepita soltanto come specifico modo di analizzare il reale, di
organizzare concettualmente la realtà. Questa mentalità sembra indubbiamente
apparire tanto nella funzione della regalità e quindi
nella rappresentazione della peculiare posizione sacrale dei re (specialmente
dei primi tre re di Roma), quanto e più nell’organizzazione
e nella comprensione del patrimonio religioso più antico inserito in
una prospettiva storificata. Ne deriverebbe non già una garanzia di
attendibilità per il discorso storico, ma una validità storica inerente al
modo di presentazione degli accadimenti.
In ogni caso questa tappa nella formazione della tradizione, verso
la fine del IV e gli inizi del III secolo, deve aver visto una forte selezione
dei dati storici trasmessi oralmente ed anche da fonti documentarie:
selezione nel senso che anche molti materiali che sono a
noi pervenuti per il tramite dell’antiquaria, e che quindi erano certamente
già allora noti, non sono mai stati trasferiti a livello storiografico.
Elementi preziosi di contenuto giuridico, economico, sociale,
culturale dei secoli V e IV sono stati lasciati da canto dall’annalistica e
prima d’essa dalla tradizione che ne fu alla base. Le ragioni di questa
trascuranza possono essere varie; fondamentale la loro marginalità o
estraneità al quadro politico lineare che si intendeva proporre. Ne
deriva, sembra, una conseguenza di metodo di grande importanza.
Noi non siamo legittimati ad inserire questo materiale nel racconto
tradizionale, magari al posto di dati che possono apparire incongruenti.
Essi devono essere trattati a parte: facciamo un esempio. Cicerone
nel De legibus (2.45-53) introduce un’ampia, interessante discussione
sulla successione dei culti domestici e sul passaggio dal diritto
pontificale al diritto civile laico (vd. § 9.9). È evidente che Cicerone
descrive consapevolmente delle differenti fasi nello svolgimento
della società romana. Problemi di questo genere sono estranei alla
tradizione storica trasmessa in forma letteraria. L’attenzione di quest’ultima
privilegia accadimenti politico-militari e si incentra sul contrasto
fra patriziato e plebe visto nelle sue manifestazioni esteriori; lo
sviluppo di una società non faceva parte della narrazione degli
accadimenti.
Livio nel famoso capitolo iniziale del libro sesto si rendeva conto,
Antiquaria
1.2. I dati dell’antiquaria
1. Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica 24
anche se ricavava da altri l’osservazione, dell’oscurità, e quindi
dell’incertitudine, della storia della città dalla fondazione all’incendio
gallico. La spiegazione era indicata nella carenza di un tradizione letteraria
risalente a quei tempi, sola custodia fedele del ricordo degli
accadimenti, e nella distruzione dei commentari dei pontefici e di altri
monumenta pubblici e privati avvenuta durante l’incendio gallico
della città. Senza tornare ad analizzare questo testo, non si può però
non notare che la prima osservazione avrebbe dovuto mettere in
guardia Livio sulla validità e sulla attendibilità di larghi squarci narrativi
che egli tuttavia riporta. Anche in seguito Livio, per esempio a
proposito della seconda sannitica (8.40), riferisce talora incertezze
topografiche e cronologiche e sa di possibili falsificazioni dovute alle
vanterie nobiliari, ma non sembra aver nessun dubbio sulla storicità
della complicata e complessa tradizione sull’episodio delle Forche
Caudine, che egli riporta per esteso, e che in questa forma è evidentemente
molto tarda. Né si comprende come egli intendesse che la
documentazione pontificale, e altra conservata in pubblico e in privato,
potesse servire a rimpolpare e a chiarire quelle fasi oscure della
storia della città.
In età augustea erano a disposizione gli Annales Maximi, in 80
libri, che contenevano la stesura delle annotazioni che il pontefice
massimo veniva registrando nel corso dell’anno sulla tabula dealbata
esposta al pubblico sulle pareti della sua residenza, la Regia. Le annotazioni,
accanto ai nomi dei magistrati, dovevano essere prevalentemente
di carattere pratico e sacrale, ma vi saranno stati registrati
anche avvenimenti importanti. La ricopiatura nei commentari avrà
assunto una qualche forma letteraria. Si ritiene di norma che gli
Annales Maximi siano stati pubblicati verso il 130 a.C., durante il
pontificato di P. Mucio Scevola, ma altri pensano invece ad una edizione
proprio di età augustea ad opera dell’erudito Verrio Flacco. Sarebbe
molto importante sapere a quando risalivano le registrazioni
pontificali: difficilmente ad un’età anteriore all’incendio gallico, sebbene
non si possa escludere che dopo quell’evento i pontefici abbiano
cercato di ricostruire la documentazione andata distrutta; certamente
ad un certo momento venne premessa una sorta di introduzione,
relativa alle origini della città e all’età monarchica, che risentiva
di chiara influenza greca. Ad ogni modo, per quel che si può arguire
dalle rare citazioni, gli Annali dei pontefici non dovrebbero aver avuto
molto peso sulla storiografia annalistica, se non, appunto, sull’impianto
annuale della stessa. Lo schema di questa narrazione era dato
dalla lista dei magistrati annuali eponimi, i Fasti Consolari. Questa li-
Annales
Maximi
Fasti
Consolari
1.3. Drammaturgia 25
sta, che noi ricostruiamo appunto dalla tradizione letteraria e dalla
copia fatta incidere da Augusto, è stata riconosciuta sostanzialmente
sicura nella sua autenticità con l’eccezione dei primi collegi all’inizio
della repubblica. Essa è un documento di valore eccezionale per la
storia più antica della città. Ma per tornare alla già ricordata riflessione
liviana a 6.1, essa è anche erronea. Lo storico non si è accorto che
al fondamento dei dati su certi avvenimenti stava un’inferenza legata
alle dediche di molti templi (dunque un materiale epigrafico), dei
quali dovevano essere conosciute la datazione e l’occasione: di qui
era stato possibile risalire al fatto che era stato all’origine della costruzione.
Questo stesso ragionamento può valere per altre grandi
opere pubbliche, alcune delle quali venivano rinviate, non senza ragione,
all’età regia e devono aver contribuito a dare all’azione di alcuni
re una precisa connotazione.
Altri dati erano forniti dalla trasmissione orale. Il problema dell’autenticità
di questi dati si pone in modo diverso. Ottime indagini
recenti consentono importanti precisazioni. I quesiti principali paiono
essere i seguenti: chi trasmette e che cosa viene trasmesso e per
quale scopo; e poi quanto è passato dalla trasmissione orale, tramite
un filtro selezionatore, nella ricostruzione storica. Le tradizioni orali
sono molteplici a seconda degli usi e del milieu sociale che le conserva,
le elabora e le trasmette: le tradizioni gentilizie sono molto differenti
da quelle appartenenti agli strati popolari. Formule e materiali
giuridici e contenuti legislativi (a cominciare dallo stesso testo della
legge delle Dodici Tavole) hanno avuto un loro impiego e una loro
vita indipendente, estranea alla tradizione storica vera e propria (valga
qui l’esempio del passo ciceroniano; per la fase orale della giurisprudenza
romana pontificale si può rinviare all’opera di Aldo
Schiavone su giuristi e nobili: vd. Bibliografia). Un buon numero di
dati relativi a fatti storici devono essere stati trasmessi nell’ambito
delle famiglie nobili; essi possono essere stati connessi alla lista dei
consoli e quindi ad una cronologia abbastanza sicura. Il pericolo della
deformazione non è da sottovalutare, come già sapevano gli antichi,
ma va anche considerato che la trasmissione avveniva sotto il
controllo del gruppo sociale. La costruzione di ascendenze regali
sarà stata almeno in parte un fatto pertinente alla gens, ma abbastanza
generalmente accettato se è poi potuto penetrare nella tradizione
annalistica già per tempo. Tali ascendenze presuppongono già esistente
un patrimonio di notizie sui re ed avranno, per altro, anche
contribuito ad accrescerlo.
Dati relativi alla religione e ai riti si potevano appoggiare alla sor-
1.2. I dati dell’antiquaria
1. Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica 26
vegliata continuità della ripetizione ed anche a documentazione templare,
e la loro trasmissione era certamente vincolata e meno deformabile.
La loro incidenza sulla formazione della tradizione non è
da sottovalutare, dato che quel processo di formazione è certamente
avvenuto ad opera di senatori e pontefici.
Possono forse sembrare più dubbie le nozioni relative ad istituti
politici e a procedure costituzionali per la tendenza, che sarà già stata
in atto nel V e IV secolo, a spostarli all’indietro nel tempo e a concentrarli
in certi periodi. Monumenti, statue, anche iscrizioni, toponimi,
dei quali si era anche in parte perso il ricordo delle origini e delle
cause, devono aver alimentato interpretazioni e tradizioni leggendarie,
anche a livello popolare, collocate però in momenti storici che si
pensavano precisi.
Infine, al momento fra IV e III secolo nei quali tutti questi svariati
materiali furono selezionati per entrare a formare il corpo storico,
che sarebbe poi stato trasmesso alla prima annalistica, sarà stato agevole
organizzarli anche tenendo conto di confronti con quanto si sapeva
dello svolgimento storico e istituzionale di città greche ed etrusche.
È probabile che si possano ricercare anche in questa situazione
le origini di quella concezione di una koiné italica, che è divenuta,
pur con molte varianti, per opera della moderna storiografia, uno dei
canoni interpretativi della storia di Roma fra VII e V secolo, togliendola
così dal suo isolamento lineare e consequenziale. Che un regime
monarchico potesse assumere tono popolare e antiaristocratico,
che talora finisse nella tirannide e che questa venisse rovesciata dall’aristocrazia,
la quale a sua volta sarebbe venuta a contrasto con il
popolo, rappresentava uno schema che, al di là della sua aderenza
alla realtà romana, doveva essere ben conosciuto.
Va comunque ribadito il concetto che filoni diversi di diversa
documentazione debbono essere tenuti distinti nell’analisi e non
comparati a sostegno vicendevole di notizie o di dati, o anche giustapposti
o semplicemente inseriti in un contesto non loro. È preferibile
creare quadri disgiunti, elaborati con le oramai raffinate tecniche
metodologiche per i differenti tipi di documentazione; soltanto
allora sarà possibile e utile un confronto che non dovrà poi mai significare
conciliazione ad ogni costo e ricostruzione unitaria.
2. L’età arcaica 34
2.2. LA ROMA DEI TARQUINII
Un saggio memorabile di Giorgio Pasquali – La grande Roma dei
Tarquinii, pubblicato nella «Nuova Antologia», 16 agosto 1936, pp.
405-416 – ha rappresentato un momento epocale nello svolgimento
della ricerca moderna sulla Roma del VI secolo a.C., nell’età della
monarchia etrusca. Come era inevitabile, la visione e l’interpretazione
prospettate nell’articolo hanno suscitato, e continuano a suscitare,
una serie infinita di discussioni; ed è singolare che il grado di assenso,
molto più alto soprattutto in Italia che non il dissenso, non sia mai
diminuito, sebbene alcuni degli argomenti principali portati dal Pasquali
a sostegno della sua tesi siano oramai apparsi insostenibili.
Questo favore permanente è in larga parte dipendente dalla diffusa
teoria che l’indubbio amplissimo progresso di conoscenze legato alle
scoperte archeologiche abbia portato ad una conferma sostanziale
della tradizione storico-letteraria. Non per niente l’enfasi sulla Grande
Roma dei Tarquinii è stata accentuata da ricche mostre archeologiche.
Si pone, in questo caso e in primo luogo, un delicato problema
epistemologico sulla possibilità di comparare serie documentarie diverse,
lontane nel tempo e da affrontarsi con metodologie proprie. Il
criterio stesso della conferma è in se stesso equivoco. In realtà il rischio
di cadere e la frequentissima caduta in un ragionamento circolare
vizioso sono evidenti: dati della tradizione letteraria e conferme
archeologiche si sorreggono a vicenda nel senso che prima il dato
archeologico è valutato, implicitamente o esplicitamente, in un quadro
generale offerto dalla tradizione letteraria; questa è poi “confermata”
dall’evidenza archeologica così interpretata. Inoltre il dato archeologico
viene spesso generalizzato e quindi enfatizzato. Ad ogni
modo, senza rifare qui la storia dell’idea pasqualiana nei successivi
sessant’anni (tanto più che essa è già stata esaminata da Ampolo con
sostanziale approvazione, e da Kuhoff con un approccio nuovo al
problema: vd. Bibliografia), è necessario ricordare che per il Pasquali
la Roma della monarchia etrusca si presentava come città ampia e
ricca, con spiccato carattere grecanico, nelle manifestazioni artistiche
e culturali e nella stessa struttura politica di fondo, con carattere mercantile
e attività industriose. A questa fase alta sarebbe seguita alla
fine del VI e all’inizio del V secolo una generale decadenza, durata a
lungo, inevitabile conseguenza proprio della caduta della monarchia
etrusca.
Nel complesso quadro delineato entravano, come è stato detto,
1.3. Drammaturgia 35
taluni elementi di per sé non nuovi, altri frutto di recentissime indagini
e non da tutti accettati, che venivano ripensati in modo unitario e
apparentemente coerente. Come è affermato nella frase finale del
saggio, il quadro portava nella propria unità la garanzia della propria
verità. L’affermazione potrebbe mascherare un’intrinseca debolezza,
appunto perché parecchi degli elementi del quadro erano già allora
(e tanto più lo sono ora) insicuri e, se presi di per sé, non indicativi.
Nello stesso anno 1936 Giorgio Pasquali aveva pubblicato il
volumetto Preistoria della poesia romana, nel quale sosteneva che la
creazione del saturnio recitativo risaliva alla fase finale dell’età regia
per diretta influenza greca, probabilmente da Cuma. La teoria di per
sé non traeva seco di necessità implicazioni politiche, non più per
esempio dell’adozione greca dell’alfabeto fenicio. Essa era inquadrata
nella prospettiva di una vasta penetrazione culturale greca in Roma
nel VI secolo, che era sorretta da altri elementi più decisamente sviluppati
nell’articolo della «Nuova Antologia».
Questi fattori congruenti erano: l’ampia presenza di frammenti di
terracotte architettoniche, di ispirazione ionica, appartenenti verosimilmente
ad edifici monumentali; resti di una muraglia probabilmente
risalente all’età serviana, delimitante una vasta area urbana e il ricordo
di templi riferiti alla fine dell’età regia e dedicati a divinità greche;
la prosperità economica connessa ad un’attività di traffici commerciali,
e specialmente del legname: essa era confermata dalla menzione
di artigianati e mestieri (i collegia opificum venivano fatti risalire
dalla tradizione al re Numa Pompilio); il latino era interpretato, di
conseguenza, come un idioma più di ceto mercantile e artigiano che
non rurale; l’ordinamento timocratico centuriato attribuito al re
Servio Tullio (che avrebbe spezzato il dominio delle gentes e che presupponeva
una società evoluta) era ritenuto ispirato dalle analoghe
costituzioni greche, anche nei suoi aspetti militari: la falange oplitica
sarebbe stata importata dalla Grecia. Il Pasquali accettava con entusiasmo
l’interpretazione che Plinio Fraccaro dava dell’identità strutturale
fra le centurie della fanteria pesante della legione romana e le
centurie dei iuniores delle prime tre classi dell’ordinamento
centuriato, ne condivideva la risalenza all’età serviana e quindi l’attribuzione
all’inizio dell’età repubblicana, per la presenza di due consoli,
del raddoppio dei quadri legionari con il dimezzamento degli
organici. In questa prospettiva la presenza dell’elemento etrusco era
decisamente minoritaria, malgrado il dominio esercitato da re etruschi.
Tuttavia l’accoglimento della datazione polibiana del primo trattato
romano-cartaginese al primo anno della repubblica (509 a.C.)
2.2. La Roma dei Tarquinii
2. L’età arcaica 36
induceva a ritenere che Cartagine avesse considerato Roma come
una delle città etrusche con le quali, come sappiamo da Aristotele
(Politica, 3.1280a.36), aveva stipulato trattati.
Molte delle componenti questo quadro, con le relative argomentazioni,
sono incertissime. Non discuto di proposito della risalenza al
VI secolo della creazione del saturnio e di quanto attiene alla storia
linguistica (è andata sempre più accentuandosi la ricerca di vocaboli
di origine greca nel latino arcaico), in quanto non sembrano elementi
essenziali per una interpretazione globale della Roma di VI secolo. I
punti di forza sono altri. Il fattore archeologico fondamentale era rappresentato
dalla preesistenza, rispetto al muro “serviano” di IV secolo,
di una muraglia di VI secolo, la cui estensione permetteva calcoli
sull’area urbana e sulla popolazione, e confronti con altre città contemporanee.
Di fatto, come riconosce lo stesso Pallottino, di questo
eventuale muro dell’età regia non si sa nulla. Dubbi molto forti sono
stati avanzati, a ragione, anche a proposito di altri grandi manufatti e
complessi edilizi, fatti risalire ai re etruschi, e che avrebbero dovuto
fornire una prova archeologica per la tradizione annalistica (tempio
di Giove Capitolino, cloaca maxima, circo massimo). Pare chiaro che
le terracotte architettoniche, fra l’altro presenti in varie altre località
laziali, non possano reggere da sole l’onere della dimostrazione richiesta
all’evidenza archeologica.
Un altro pilastro della costruzione del Pasquali era rappresentato
dall’accoglimento delle teorie del Fraccaro su La storia dell’antichissimo
esercito romano e l’età dell’ordinamento centuriato, che diedero
luogo negli anni trenta ad un’accesa discussione, che è continuata, su
di un tono più pacato, anche in seguito. Il problema coinvolgeva
aspetti politico-costituzionali, militari ed economici, in quanto suggeriva
una visione “modernizzante” della società romana. L’osservazione,
o meglio la scoperta (come riconobbe il De Sanctis) del
Fraccaro riguardava l’identità strutturale fra le 60 centurie delle fanterie
di linea della legione romana e le centurie degli iuniores delle prime
tre classi del cosiddetto ordinamento serviano (40+10+10 = 60).
Anche le 25 centurie degli armati alla leggera dell’ordinamento
serviano corrispondevano agli altrettanti veliti assegnati ad una legione
(2400). La coincidenza sembra dimostrare che in un certo momento
storico le classi serviane formavano la legione, l’intero esercito romano,
di circa 6000 opliti (100 per centuria). Era stata evidentemente
superata la fase anteriore “romulea” dei 3000 armati forniti dalle tre
tribù genetiche, e dei 300 cavalieri. In età sicuramente storica una legione
comprendeva una media di 50 uomini per centuria, vale a dire
L’antichissimo
esercito
romano
1.3. Drammaturgia 37
un totale di circa 3000 fanti. E poiché ogni esercito constava di norma
di due legioni, sembra naturale ricavare la conclusione che erano stati
raddoppiati i quadri della singola legione precedente, per formarne
due, e che era stato diviso fra le due legioni il contingente totale di
6000 fanti. Questo raddoppio era messo in relazione dal Fraccaro con
l’istituzione dei due consoli all’inizio della repubblica, al posto del
precedente unico comandante, il re o un suo delegato. Premessa e
conseguenza del ragionamento del Fraccaro era la risalenza serviana
dell’ordinamento serviano, quale ci è descritto dalla tradizione letteraria,
anche se nella discussione con il De Sanctis, che seguì alla sua
scoperta, egli riconobbe che l’ordinamento stesso, e quello della legione,
potevano aver subito mutamenti e adattamenti nel tempo (per
esempio la distinzione fra iuniores e seniores). Una spiegazione, ipotetica
ma non priva di un certo grado di probabilità, è quella prospettata
da vari studiosi, e fondata su di un passo di Catone riferito da
Gellio (Noctes Atticae, 6.13), che l’originario ordinamento “serviano”
comprendesse, accanto agli equites, la classis, forse non solo composta
da uomini della prima classe di censo, corrispondente alla legione
di 6000 fanti, e gli infra classem, cioè truppe armate alla leggera e
anche non combattenti. I punti problematici restano parecchi, e in
sostanza possono essere così formulati: quale possa essere l’eventuale
risalenza di questo ordinamento con le sue implicazioni politiche e
rispetto al quadro generale, sociale ed economico, che esso presuppone.
Inoltre quali sono state le fasi di svolgimento attraverso le quali
si sarebbe passati per arrivare allo schema finale dell’ordinamento
centuriato, sia sul piano socio-economico, sia militare e politico.
Che lo schema dell’ordinamento serviano a noi descritto dalla
tradizione letteraria, cinque classi di censo e 193 centurie, pur prescindendo
dai valori monetari che avrebbero contraddistinto le stesse
classi, non possa risalire alla metà del VI secolo è ora abbastanza generalmente
ammesso. Questa struttura presuppone una complessa
articolazione della società e una consistenza di capacità economiche
non ammissibile neppure per l’ultima età regia. L’idea di Roma nella
fase dei re etruschi come di una città di sviluppate attività artigianali
e commerciali era connessa anche all’accoglimento, pressoché acritico,
dei dati tradizionali sulla risalenza al re Numa dei collegia
opificum (passo fondamentale Plutarco, Numa, 17), e su una pretesa
conferma archeologica di quei dati (che i collegia siano presupposti
nelle Dodici tavole è infondato).
Nessuno dubita, e anzi abbiamo spesso ripetuto, che Roma abbia
avuto una sua centralità per i traffici connessi con il Tevere e il suo
L’economia
di Roma
arcaica
2.2. La Roma dei Tarquinii
2. L’età arcaica 38
attraversamento, e che debba a questa sua posizione il ruolo rilevante
che essa andò assumendo, ma la situazione economica della Roma
etrusca era ancora legata all’agricoltura e dominata da gruppi gentilizi.
In altri termini, come indica bene il caso ateniese, si può pensare
per il VI (e il V) secolo, nel quadro di forme economiche premonetarie,
ad una società gentilizia, che aveva al suo interno differenziazioni
economiche, non ad una città politicamente organizzata
su vari livelli di censo. In questo modo potevano venire valorizzate
differenti capacità economiche ai fini della milizia, ma si era ben lontani
da quella teorizzazione ideologizzata dell’ordinamento centuriato
(capacità economiche-servizio militare-diritti politici), che ci offre
l’immagine di un corpo civico globalmente e coerentemente integrato
nello stato, e che non è se non l’interpretazione dell’esito finale
di un processo storico svoltosi a lungo nel tempo. È stato da più parti
rilevato che questo processo deve aver conosciuto un momento decisivo
fra V e IV secolo, in relazione ad una precisa contingenza, quando
durante l’assedio di Veio la tradizione colloca l’istituzione dello
stipendium e del tributum (vd. più avanti). Sulla scia della tradizione
annalistica si attribuisce di norma all’ordinamento serviano un preciso
significato statale cittadino, con una valenza più propriamente
“popolare” (sebbene nella storiografia antica sia presente anche
quella opposta, sfruttata dalle valutazioni politico-ideologiche dell’età
postgraccana). Ma anche sugli aspetti propriamente tecnico-militari
dell’ordinamento serviano è necessario presentare delle precisazioni.
L’ordinamento oplitico, con il suo tipico armamento, la tecnica
del combattimento e soprattutto i suoi presupposti sociali ed economici,
si andò sviluppando lentamente nel mondo greco dalla metà
dell’VIII secolo, in una società di guerrieri aristocratici, senza nessun
particolare riflesso politico, anche quando nel VII e VI secolo la struttura
politica cittadina si andò allargando a più vasti strati di proprietari
terrieri. Ancora alla metà del V secolo il «Vecchio Oligarca» (come
viene spesso chiamato l’autore della pseudo-senofontea Costituzione
degli Ateniesi) considera legittimamente gli opliti a fianco degli aristocratici
e in opposizione al demos. Il modello greco degli opliti
fu introdotto in Etruria, a quel che sembra, non prima della metà del
VII secolo, lentamente e gradualmente fra quella data e la metà del VI
secolo. Fu adottato da una società oligarchico-gentilizia senza che ne
derivassero, per quel che si sa, mutamenti al suo interno e senza che
si possa pensare ad una qualsiasi scansione timocratica, anche se,
evidentemente, i militi saranno provenuti dalla classe subalterna, la
Ordinamento
oplitico
1.3. Drammaturgia 39
quale, tuttavia, nelle città etrusche di età classica non pervenne mai
ad elevarsi a quella posizione cittadina e a quella coscienza civica
che contraddistinsero, poi, l’esercito centuriato romano.
D’altra parte è difficile poter determinare come si sia andata formando
la peculiare struttura della società etrusca, caratterizzata da
domini e da servi, non privi di una certa autonomia economica anche
se politicamente dipendenti (oltre che da schiavi). Essa certamente
non ebbe origine in situazioni confrontabili con il mondo greco, nel
quale forme di servaggio furono l’effetto della sottomissione di popolazioni
preesistenti a nuclei di conquistatori sopraggiunti dal di fuori.
Almeno dal III secolo fu poi nell’interesse del governo romano mantenere
il più possibile inalterato il tipico carattere della società delle
città etrusche.
Il sistema oplitico-falangitico con il relativo armamento passarono
dall’Etruria a Roma fra il VI e il IV secolo: una precisa cronologia è
naturalmente impossibile da determinare. La derivazione etrusca era
riconosciuta dalla tradizione romana (Diodoro, 23.2; Ineditum Vaticanum,
III), alla quale non interessava la remota risalenza ellenica.
Anche se questa introduzione dovesse essere collocata nell’età della
monarchia etrusca, non c’è nessun motivo per credere che essa abbia
tratto con sé, immediatamente, una diversa struttura della società romana,
e un differente valore politico. Si era pur sempre in un contesto
gentilizio, e sarà più tardi che l’ordinamento serviano venne assumendo
quel valore politico, che sarà proiettato all’indietro alle sue
pretese origini. Ancora nei primi decenni del V secolo le armate
gentilizie erano formate dai membri delle gentes e dai loro clienti.
Il problema storico fondamentale sta proprio nel diverso sviluppo
che, all’interno di una struttura comune alle città etrusche, ebbero
in Roma le forze della classe subalterna (plebe). Ma Roma non era
mai stata una città etrusca; era più aperta ad esperienze e influenze
culturali esterne; era socialmente più vivace. La progressiva valorizzazione
militare degli strati inferiori, necessaria per una politica di
pur modesta espansione, e anche di difesa, portò con sé conseguenze
politiche e istituzionali che mutarono l’intero impianto cittadino.
La struttura statale andò acquistando consistenza e organicità; la stessa
classe aristocratica dominante dovette darsi un’autoregolamentazione
per mantenersi al potere.
Se si accetta l’idea che lo schema dell’ordinamento centuriato
“serviano” sia andato completandosi nelle sue cinque classi nel corso
del V secolo, proprio riflettendo la sempre più vasta utilizzazione
nella milizia di elementi inferiori cresciuti economicamente, si po-
2.2. La Roma dei Tarquinii
2. L’età arcaica 40
trebbe ipotizzare che la magistratura dei tribuni militum consulari
potestate, che dal 444 al 367 a.C., in numero variabile da tre a otto,
sostituirono in molti anni i consoli, potrebbe aver corrisposto ad aumenti
della forza bilanciata romana. In tal caso potrebbe risalire alla
fine del V – inizi del IV secolo il rapporto fra ordinamento serviano
concluso e la struttura della legione individuato dal Fraccaro. In questo
caso il raddoppio dei quadri della legione potrebbe essere riferito
al ripristino definitivo dei due consoli, uno dei quali obbligatoriamente
plebeo, nel 366 a.C.
Dunque anche l’ordinamento serviano, del quale è anche discutibile
la derivazione greca, non può avvalorare la ricostruzione della
Roma regia proposta dal Pasquali, ed è significativo che l’Ampolo,
nel suo ripensamento del lavoro pasqualiano, abbia praticamente lasciato
cadere questo argomento. Resta, e certamente problema di
non poco conto, il primo trattato fra Cartagine e Roma, che Polibio
datava al 509 a.C., con tutte le sue implicazioni politiche, prima fra
tutte il riconoscimento da parte di Cartagine di un controllo romano
sulla costa tirrenica dalla foce del Tevere a Terracina. Per affermazione
esplicita di Polibio la stessa clausola ricorreva anche nel secondo
trattato, che viene normalmente riferito a circa centocinquant’anni
dopo (Polibio, 3.22-23). La data del primo trattato è stata, ed è, oggetto
di una discussione senza fine. Le difficoltà sono principalmente
dovute al modo con il quale Polibio riporta, non propriamente il testo,
ma il contenuto del trattato (lo stesso vale anche per il secondo),
riferendolo in modo frazionato e intercalando commenti e spiegazioni
proprie, che dimostrano la confusione e l’insicurezza, non soltanto
dipendenti dalle difficoltà dell’arcaico linguaggio testuale, con le
quali lo storico e i suoi esegeti romani avevano affrontato i documenti.
Accogliendo la datazione al primo anno della repubblica avremmo
un’altra prova dell’interesse di Cartagine a stringere rapporti con
città etrusche della costa, per quanto il già ricordato passo di Aristotele
che attesta condizioni di isopoliteia fra Cartagine e Etruschi
(qualcosa di analogo è previsto anche nel finale del secondo trattato
polibiano) non consenta una collocazione cronologica sicura. Le tavolette
auree con iscrizioni fenicie e etrusche rinvenute a Pyrgi, porto
di Caere, databili agli inizi del V secolo, e che contengono una dedica
“bilingue”, da parte di chi in Caere deteneva il potere, alla divinità
fenicia Astarte, confermano, non la datazione del trattato al 509,
come si suole ripetere dai più, ma quei rapporti certamente di carattere
mercantile. L’aspetto principale dei due trattati, non sempre te-
Trattati
romanocartaginesi
1.3. Drammaturgia 41
nuto nel debito conto nelle analisi critiche, è la profonda diseguaglianza
fra i due contraenti, che spiega anche il dissimile carattere dei
loro impegni. Roma è in netta condizione di inferiorità. Al di là di alcune
clausole di apparente reciproca parità, sicuramente tralatice, le
limitazioni nei movimenti marittimi imposte a Roma appaiono gravissime
e senza contropartita. È chiaro che i Cartaginesi possono invece
sbarcare militarmente nel Lazio e agirvi come meglio credono. In
questa prospettiva, anche ammettendo che nel 509 Roma controllasse
la costa laziale, o meglio si impegnasse anche a nome di località
costiere, non si può certamente parlare di Roma come di una città
potente. La Roma dei Tarquinii non era grande. E comunque la struttura
urbana cittadina non era, anche in questo caso, conferma di stabilità
politica.
2.3. Roma e i Latini
81
4.3. LE DINAMICHE ECONOMICHE E LA PRIMA MONETAZIONE
Il primo esito economico delle guerre vittoriose fu la grandiosa espansione
del territorio romano: si calcola che tra il 338 a.C. e il 264
a.C. passò da circa 5.500 a quasi 27.000 km2 e venne redistribuito attraverso
la fondazione di colonie (ne vennero fondate una ventina
nelle aree centromeridionali) e l’assegnazione di terre ai cittadini.
Probabilmente già in questo periodo si poté assistere alla prima formazione
della grande proprietà terriera, che tendeva ad espandersi a
spese della piccola proprietà.
Le leggi Liciniae Sextiae, che limitavano l’uso, cioè il possesso e
non la proprietà, dell’ager publicus (vd. § 2.6) a 500 iugeri di terra
(ca. 125 ha), sono più verosimili in questo periodo di grande espansione
territoriale che non nella prima metà del IV secolo a.C., secondo
la datazione tradizionale. Su queste grandi tenute agricole vennero
impiegate sempre più intensamente le masse schiavili catturate in
guerra, impostando rapporti di lavoro che in Italia domineranno per
alcuni secoli. La città di Roma ricomiciò a ingrandirsi, a popolarsi, ad
ornarsi di grandi templi e monumenti finanziati con il bottino di guerra
e a divenire lo spazio urbano di alcune importanti attività artigianali.
Il sarcofago di Scipione Barbato e la cosidetta Cista Ficoroni, un
cofanetto di bronzo firmato dal suo artefice con il nome romano di
Novius Plautius, sono tra gli esempi più noti di questo artigianato romano.
Nell’ambito della produzione più di massa, la ceramica a vernice
nera venne esportata non solo in Italia, ma anche in Gallia, Spagna,
Sicilia e Africa cartaginese. Del resto Roma sarà sempre una città
importatrice di grano e di beni alimentari, che deve in qualche modo
ripagare con altri tipi di esportazione.
L’allargarsi degli scambi rese oggettivamente necessario aumentare
e qualificare i mezzi di scambio attraverso l’adozione della moneta,
che era stata inventata in Grecia già attorno al VI secolo a.C.
Venne superata l’antica forma di pagamento attraverso barre di rame
indistinte e senza iconografia che valevano secondo il loro peso (aes
grave). Si introdussero lingotti di rame fuso contraddistinti da immagini
diverse: il maiale, l’elefante (dopo Pirro), l’ancora navale ... Il
loro standard ponderale era definito intorno ai 1625 gr ed il loro va-
Moneta
4.3. Le dinamiche economiche e la prima monetazione
4. La conquista dell’egemonia in Italia 82
lore nella circolazione e negli scambi doveva essere superiore a quello
del loro peso: cominciava cioè la civiltà della moneta.
Del resto, già dai primi anni del III secolo a.C. i Romani avevano
cominciato ad imitare le monete della Magna Grecia, facendo coniare
didracmi di argento con diverse raffigurazioni e legende. È difficile
spiegare come potessero coesistere forme di pagamento così diverse
come l’ancor primitivo aes signatum e le belle doppie dracme di tipo
greco: probabilmente circolavano in aree diverse e differentemente
evolute. Alla fine del secolo (tra il 214 e il 211 a.C.) i Romani introdussero
un loro particolare sistema monetario che, attraverso innumerevoli
evoluzioni, giungerà a dominare tutta l’ecumene. Il sistema
originario che rapidamente si evolse a causa di una serie di riduzioni
ponderali può essere così schematizzato.
PESI
Libbra di circa 325 grammi
Oncia di 1/12 di libbra (ca. 28 gr.)
Scrupolo di poco più di 1 gr.
MONETA DI RAME
Denominazione Peso Segno valore Immagine Immagine
Diritto Rovescio
Asse 12 once I Giano Prua nave
Semiasse 6 once (1/2) S Giove »
Triente 4 once (1/3) .... Minerva »
Quadrante 3 once (1/4) ... Ercole »
Sestante 2 once (1/6) ... Mercurio »
Oncia 1 oncia (1/12) . Bellona »
MONETA D’ARGENTO
Denario: da un iniziale 1/72 di libbra passa a 1/84 e poi, con Nerone, a 1/96. Il
suo segno di valore è inizialmente X (= 10 assi) e, dalla metà del secondo secolo
a.C., diviene XVI, siglato in forma di asterisco X (= 16 assi).
Quinario = 1/2 denario, sigla V
Sesterzio = 1/4 di denario, sigla HS
MONETA D’ORO
Dopo tre emissioni tra il III e il II secolo le coniazioni vennero abbandonate
fino a Silla e ripresero in grande stile solo con l’Impero e le sue ampie coniazioni
di Aurei.
Ma il denario di argento costituì a lungo il perno del sistema: era
una moneta di circa 4 grammi dal valore di circa 4 dollari. Le coniazioni
furono subito massicce e, a volte, ci è possibile calcolarle: nel-
83
l’89 a.C. vennero coniati più di 39 milioni di denari, soprattutto per
pagare le spese belliche e le opere pubbliche.
Originariamente il valore del metallo e quello della moneta erano
molto vicini, ma era interesse dello stato divaricare il più possibile
questi valori. Dal III secolo d.C. il valore del metallo divenne un’infima
percentuale del valore attribuito forzosamente dallo stato alla
moneta. Grande fu il guadagno per le casse dello stato, che poteva
produrre moneta al costo di 1 e venderla virtualmente a 100. Ma l’artificio
finanziario contribuì ad innescare un’inflazione vertiginosa,
con un aumento incontenibile dei prezzi. Nel IV secolo d.C. il problema
venne risolto tornando ad una moneta dal valore corrispondente
al peso del metallo che la componeva (quindi una non-moneta).
Questa volta il metallo sarà l’oro dal fascinoso colore giallo rilucente.
La moneta si chiamerà solidus, da cui il nostro «soldo».
4.4. La frontiera settentrionale: i Galli e le prime colonie
8.
L’ECONOMIA TRA LA FINE
DELLA REPUBBLICA E L’IMPERO
L’incessante successione di guerre civili, esterne, rivolte schiavili, pulizia
dei mari contro i pirati, mutò apparentemente i connotati dell’economia
romana. Ampi spazi si aprirono a fornitori degli eserciti,
mercanti, banchieri, usurai, finanziatori di leaders politici in lotta. Il
capitale finanziario sembrava assumere un ruolo emergente rispetto
all’economia agraria fondamentale. Inoltre l’immanenza della guerra
incideva sulla forma e distribuzione della ricchezza, sulla metamorfosi
della struttura fondiaria, sull’articolarsi e il definitivo espandersi
dei mercati su scala intercontinentale (Europa, Asia, Africa). L’ineludibile
necessità di pagamento delle legioni accelerò i ritmi produttivi
delle zecche, gonfiò i flussi finanziari aumentando la massa monetaria,
ma concentrando la liquidità nelle scelte mani di persone che simultaneamente
potevano essere banchieri, speculatori, appaltatori di
opere pubbliche e rifornimenti per l’esercito. Mentre costoro potevano
succhiare l’enorme liquidità messa in circolazione dallo Stato, i
tradizionali rappresentanti della ricchezza terriera, assieme al popolo
minuto, potevano contemporaneamente soffrire di carenza di mezzi
di pagamento (inopia nummaria). Per questo si doveva ricorrere a
banchieri-argentarii anche per acquisti e crediti di minima entità.
Nel 92-91 a.C. si cercò – con la lex Papiria – di svalutare la moneta
spicciola di rame al fine di aumentarne il volume, ma il cambio tra
le monete divenne così instabile che si dovette stabilizzarlo d’imperio.
Anche gli interventi sul problema dei debiti e dei tassi di interesse
si moltiplicarono. In questo contesto assunse un ruolo emergente
il capitale finanziario (o usuraio) che si accaparrava la liquidità, in un
sistema in cui il ruolo delle banche è circoscritto e limitato da tecniche
bancarie che lentamente si affineranno ma non giungeranno mai
propriamente all’impiego di strumenti come l’assegno con girata.
Paradigmatica è la figura di Rabirio Postumo. Figlio di un poten-
8. L’economia tra la fine della repubblica e l’impero 150
tissimo pubblicano, dominò il settore degli appalti pubblici, probabilmente
ancora nel 46 a.C., quando Cesare lo incaricò dei rifornimenti
della Sicilia. Prestò denaro a nazioni e re, come Tolemeo Aulete di
Egitto. Nel 55 a.C. si fece nominare ministro delle finanze del regno di
Egitto per recuperare i suoi crediti: un finanziere assume una figura
istituzionale per salvaguardare i propri interessi. Non diversa appare
la figura di Bruto, il tirannicida. Nel 56-50 a.C. aveva prestato enormi
cifre alla città di Salamina di Cipro al tasso esorbitante del 48% annuo,
facendosi convalidare l’operazione da ben due deliberazioni del senato
e, davanti alla difficoltà nel riscuotere il credito, ottenne l’invio
di alcuni squadroni di cavalleria per assediare la sede del senato di
Salamina, nella quale cinque consiglieri morirono di fame.
Il circuito zecca-esercito-lavori pubblici-appaltatori aveva polarizzato
la ricchezza mobiliare nelle mani di un’oligarchia finanziaria
che – come sempre sotto il sole – dopo avere prosciugato la liquidità,
si trovava a sua volta in difficoltà a recuperare i crediti concessi a tassi
di interesse così esorbitanti da dovere essere ridotti per legge. Tuttavia
la politica monetaria dello stato sostenne attivamente una tale
domanda di liquidità. La massa monetaria in circolazione si faceva
enorme, anche se nei momenti di guerra aumentava il numero dei
tesori monetari sotterrati e non recuperati, fenomeno che incise sulla
liquidità contraendola sensibilmente. Noi ci possiamo approssimare
al suo ordine di grandezza calcolando il numero dei conii impiegati e
moltiplicandolo per il presumibile numero di monete che ogni conio
può produrre: dagli anni 90 ai 50 a.C. circolarono più di 400 milioni
di monete romane d’argento (oltre a quelle in oro e rame). Comunque
i circuiti di circolazione di questa massa monetaria erano quelli
imposti dalle esigenze di rifornimento ed equipaggiamento degli
eserciti, così da determinare l’inaridimento monetario di intere regioni:
è eloquente il fatto che, dopo che Pompeo ottenne il diritto di attingere
alle risorse finanziarie dell’Asia per pagare la guerra asiatica e
quella contro i pirati che infestavano i mari, il governatore della provincia
di Ponto-Bitinia del 61-59 a.C., Papirio Carbone, abbia dovuto
rimonetizzare la regione facendo funzionare ben otto zecche.
8.1. DALL’ECONOMIA DEL BOTTINO AL FISCO IMPERIALE
Con l’esaurirsi dell’espansionismo militare non fu più possibile gestire
le finanze dello stato con gli enormi bottini conquistati ai popoli
151
vinti. Si rese necessario coordinare un sistema fiscale e tributario che
convogliasse un flusso regolare di risorse a Roma, da dove venivano
redistribuite secondo le necessità imperiali.
Se il tributo è un premio alla vittoria, deve dunque essere pagato
dai popoli vinti. I cittadini romani, esentati dall’imposta patrimoniale
dopo Pidna, pagavano solo il 5% sulla manomissione degli schiavi e
sull’eredità, oltre alle imposte indirette (dazi, dogane, ...). Per gli altri
abitanti dell’impero la categoria fiscale era quella dell’imposta inversamente
proporzionale: la quota fiscale è più alta quanto più è basso
lo status socio-giuridico. Ma il sistema non era omogeneo su scala
imperiale. I conquistatori si limitarono ad ereditare e perfezionare le
fiscalità precedenti, organizzate con particolare cura durante il periodo
ellenistico. L’imposta più gravosa, quella fondiaria, veniva riscossa
come 1% del valore monetario in Siria e Cilicia, mentre in altre province
si pagava una sorta di decima sulla produzione. A queste imposte
centrali se ne aggiungevano svariate altre, diverse da provincia e
provincia: sull’artigianato (che in epoca tardo-antica comprese anche
la prostituzione), sui cambi monetari, dazi, dogane, corvées, imposte
del registro ...
Rapidamente mutò il modo di riscossione: un severo controllo
sugli appalti aveva nientificato i peccati speculativi dei pubblicani,
che vennero sostituiti da burocrati o da persone fiscalmente vincolate
alla riscossione (munera personalia). Nel giro di pochi decenni la
morsa fiscale si fece più acuta: a metà del I secolo d.C. province come
la Gallia e l’Egitto dovevano pagare un tributo circa dieci volte superiore
a quello che inizialmente avevano dovuto pagare a Cesare e
Augusto (Frank).
È impossibile ricostruire l’entità delle entrate fiscali. Utilizzando
fonti incerte e imprecise ed elaborando estrapolazioni statistiche si
possono approssimativamente valutare queste entrate in 1,4 miliardi
di sesterzi in epoca flavia e un PIL di 6 miliardi di sesterzi. Ma una
buona parte di questa quota veniva impiegata per il mantenimento
dell’esercito, che però spendeva i propri stipendi nelle diverse province
dove era stanziato, attivando una domanda solvibile che sollecitava
positivamente le economie locali. Veniva messo in moto così
un processo di accentramento dei surplus estorti e di redistribuzione
parziale degli stessi che induceva importanti dinamiche economiche.
Un complesso meccanismo di redistribuzione permette di differenziare
tra province importatrici di imposte e province che attraverso
il fisco subivano un salasso di ricchezze. Le élites dominanti
insediate a Roma non si limitavano a consumare risorse procurate at-
8.1. Dall’economia del bottino al fisco imperiale
8. L’economia tra la fine della repubblica e l’impero 152
traverso lo sfruttamento fiscale delle province, ma le ripartivano ad
altre élites provinciali che divenivano protagoniste di una riuscita
economica che permetteva di uscire da uno spazio periferico per divenire
centri nuovi in espansione. È il caso della Gallia Belgica. Lo
stanziamento permanente di consistenti forze armate romane la trasformò
in un polo di attrazione di ricchezze e quindi di opportunità
per i proprietari terrieri, prevalentemente Celti, che nel rifornimento
degli eserciti romani trovarono il modo per ottimizzare i profitti.
8.2. IL MONDO DELLE MERCI
Già da secoli l’economia romana aveva superato il limite di una produzione
e di un commercio tesi quasi esclusivamente all’esigenza
primaria dell’approvvigionamento alimentare, dentro un orizzonte
dove l’acquisizione di oggetti preziosi e voluttuari presentava i preminenti
connotati simbolici e di prestigio che caratterizzano una società
antropologicamente primitiva. Ormai, malgrado le reiterate leggi
contro il lusso, la domanda di beni sontuosi (marmi, opere d’arte,
vestiti preziosi, cibi esotici, abitazioni alla greca, schiavi colti, ...) si
costituiva come un circuito economico quantitativamente circoscritto
alle élites, ma qualitativamente significativo a causa dell’alto valore
aggiunto di queste merci provenienti dalle lontananze di ogni punto
cardinale. L’economia del lusso delle classi agiate appariva simmetrica
all’economia di sussistenza di larga parte della popolazione.
Ovunque emergeva una borghesia municipale che – anche nei centri
periferici come Aquileia – abitava case invidiabili ornate di mosaici
ellenistici e che si concedeva il lusso raffinato di gemme, ambre del
Baltico, vetri preziosi, ceramiche fini, ora importate dall’Oriente, ora
di produzione locale, perché anche in Italia stava nascendo un artigianato,
talvolta di dimensione manifatturiera, sempre più autonomo
dal legame con l’agricoltura e aperto – ovviamente più al centro che
alla periferia – alla suggestione dei nuovi gusti ellenistici.
Strutturalmente la dimensione del commercio doveva essere ampia,
sia per il trasporto delle tasse in natura, sia per la domanda della
massa dei contadini che, pur ai limiti di sussistenza, domandavano
vestiti, strumenti di lavoro e occasionali oggetti di lusso, almeno per
le feste rituali e per i matrimoni. È stato valutato che, se il 10-15%
della popolazione dell’Impero viveva in città, questo comportava un
commercio di oltre un milione di tonnellate di grano (o equivalente)
153
solo se la popolazione urbana avesse consumato un minimo vitale di
circa 220 chili di grano. Le carestie ricorrenti sollecitano questi flussi
commerciali (vd. anche § 14.2). I rifornimenti all’esercito ne gonfiavano
sensibilmente il volume: quattro legioni al consumo di un litro di
vino giornaliero pro capite richiedono un commercio di settecentomila
ettolitri l’anno. E nei momenti cruciali le legioni saranno alcune
decine.
Gli scambi si intrecciavano anche al di là delle frontiere romane.
Già nel II secolo a.C. una fitta trama di traffici connetteva Roma con
la Gallia meridionale. Il vino, di cui i Celti erano inesausti bevitori,
costituiva una delle prime voci delle esportazioni italiche, tanto più
che una norma protezionistica impediva ai transalpini di impiantare
vigneti (Cicerone, De re publica, 3.9.16). I guadagni per i mercanti
dovevano essere cospicui, ma ancora superiori erano le entrate doganali
che allora potevano arrivare al 300% del prezzo del prodotto. Su
tutto il mondo conquistato dilagavano i commercianti, anche i rappresentanti
dei senatori, cui la lex Claudia del 219/218 a.C. pur interdiceva
il grande commercio. Fin dall’inizio delle guerre mitridatiche i
Greci in rivolta contro l’oppressione romana trucidarono migliaia di
questi avventurosi commercianti. Se le cifre trádite di ottantamila o
centocinquantamila italici uccisi sembrano, come al solito poco credibili,
forniscono tuttavia un ordine di grandezza drammatico del fenomeno.
Il porto franco di Delo diventò il centro ombelicale di questi
scambi e si specializzò nel commercio – spesso gestito da ex-schiavi
– di schiavi, venduti su quel mercato prevalentemente da pirati che
avevano fatto razzie nelle città della costa asiatica. Se la cifra iperbolica
fornita da Strabone (14.5.2) di decine di migliaia di schiavi
venduti quotidianamente pare ancora una volta incredibile, tuttavia è
certo che la probabile sede di questo mercato (l’agorà des Italiens) di
uomini e donne poteva contenere fino a diciottomila persone. Gli
schiavi erano del resto una delle merci più ricercate. In Roma stessa
esisteva un mercato degli schiavi (venalicium: Cicerone, Orator,
232.6; equivalente allo statarion greco) situato nella zona dell’Aventino
e gestito da commercianti specializzati, i magistri Capitolini.
Ma i mercanti non si costringevano entro i limiti dell’impero. Già
prima della conquista traianea (vd. § 12.6) la Dacia era percorsa da
negotiatores alla ricerca di prodotti locali come il miele e il sale, ma
soprattutto per acquistare schiavi per il cui pagamento veniva accettata
la moneta romana d’argento, la quale godeva di un tale apprezzamento
da dare origine a massicce imitazioni barbariche. Ma tra il I
secolo a.C. e il I secolo d.C. i commerci italici segnarono un declino.
8.2. Il mondo delle merci
8. L’economia tra la fine della repubblica e l’impero 154
Un’analisi condotta sull’importante mercato di Ostia indica una rapida
crescita delle importazioni dalla Spagna, Gallia e Africa. Simmetricamente
la ceramica del tipo di Arezzo (dopo un grande successo sui
mercati) cominciava a sparire dalle frontiere germaniche, mentre più
tardi l’intera produzione ceramica italica sembrò soppiantata dalle
officine galliche e africane.
Con la fine delle guerre civili, il costituirsi dell’Impero e l’instaurarsi
della pax augusta l’economia raggiunse una dimensione mondiale.
«L’Europa è totalmente autonoma: possiede una massa inestinguibile
di uomini per la guerra, per lavorare la terra, per amministrare
le città. Un’altra delle sue superiorità sta nel fatto che produce i frutti
migliori e necessari alla vita, oltre a tutti i minerali utili; importa dall’esterno
solo profumi e pietre preziose la cui scarsezza o abbondanza
non aggiunge niente al benessere della vita. Allo stesso modo l’Europa
fornisce una grande abbondanza di animali, mentre sono scarse
le bestie feroci» (Strabone, 2.5.26).
Si era formata un’economia-mondo: dall’Europa e da tutto il
mondo conquistato e pacificato giungevano a Roma, la metropoli-capitale,
merci di ogni tipo, che ne ostentavano la ricchezza e il predominio.
Difatti, come noterà Appiano, l’impero romano aveva esteso
le proprie conquiste e i propri confini come mai nessun impero precedentemente.
Nell’Oceano erano soggetti ai Romani la maggior parte
dei Britanni. Superate le Colonne d’Ercole comandavano su tutte le
isole e le terre del Mediterraneo: i Mauritani, i Numidi, i Libici, i Cirenaici,
i Marmaridi, gli Alessandrini che abitavano la grande città fondata
da Alessandro Magno, e tutto l’Egitto fino all’Etiopia erano soggetti
a Roma. Più ad Oriente il dominio si estendeva su Siria, Palestina,
parte dell’Arabia, fino a Palmira e al deserto che circonda il fiume
Eufrate; comprendeva tutta l’Anatolia fino al Mar Nero e alle regioni
nordiche della Mesia e della Tracia. Dentro lo stesso impero erano la
Grecia, la Tessaglia, la Macedonia e l’Illiria, la Pannonia e l’Italia stessa
con le sue popolazioni nordiche di Celti e le popolazioni celtiche
della Gallia, fino ai Celtiberi di Spagna. I confini dell’Impero erano
dunque segnati a sud da Mauretania ed Etiopia, ad est dalla Russia
meridionale e in Europa dalla linea Reno-Danubio. Ma anche oltre
questi confini numerosi popoli erano sotto il protettorato di Roma,
che non li annetteva perché «poveri, senza profitto e inutili».
Nella prefazione dell’ultimo libro, perduto, della sua Storia Romana
Appiano avrebbe fornito una contabilità dettagliata delle entrate
e delle uscite complessive. Questo tipo di unificazione politica
di ampie regioni di Europa, Africa ed Asia non chiudeva però il mon-
Economiamondo
155
do romano in se stesso. Le frontiere erano militarmente controllate,
ma non impedivano sempre più intensi scambi con le più lontane terre
oltre frontiera. Gli scambi attraverso il confine del fiume Reno con
la Germania più orientale e fino alla Scandinavia (oggetti di vetro e
metallici, monete e vino contro animali, sapone, carri e vestiti) furono
intensi e contribuirono all’evoluzione di tipo feudale delle tribù
germaniche. Dalle regioni baltiche l’ambra grezza raggiungeva via
terra i centri di lavorazione specializzati come Aquileia ed Alessandria
d’Egitto, da dove si diffondeva per tutto il Mediterraneo. Colonia
alle foci del Reno divenne un centro di produzione vetraria, con
esportazioni in tutto il nord-ovest europeo. Verso l’Africa gli enormi
depositi di anfore attorno al porto di Alessandria e ancora al confine
meridionale dell’Egitto (Kasr Ibrim) mostrano l’intensità dei rapporti
con il regno di Meroe e con l’Etiopia.
Nemmeno l’Estremo Oriente restò fuori da quest’orbita: Greco-
Romani si insediarono in India, dove acquistavano avorio, stoffe preziose
e spezie in cambio di monete d’oro e d’argento, mentre nel tardo
impero gli scambi con lo Sri-Lanka avvenivano soprattutto attraverso
monete di bronzo. Il commercio della seta cinese procedeva sia
via terra, attraverso l’Afghanistan, sia passando in India e proseguendo
via mare sino al Golfo Persico e al Mar Rosso. Fonti cinesi come
gli Annali Han menzionano l’arrivo alla corte di un ambasciatore dell’imperatore
Marco Aurelio, intenzionato a stabilire rapporti diretti
con la Cina, evitando l’intermediazione della Persia. Secondo questo
testo i Romani «sono onesti nelle loro transazioni e non fanno due
prezzi ... Il bilancio si basa su un tesoro ben provvisto».
Solo l’estremo confine occidentale, segnato dall’Oceano Atlantico,
rimase insormontato (ma un accampamento romano è stato trovato
anche in Irlanda). In tutte le altre direzioni l’immenso e spopolato
spazio dell’impero fu solcato da una trama fitta di relazioni che lo
posero al centro di un orizzonte mondiale. Sotto questa vivacità degli
scambi agiva però il limite strutturale dei costi di trasporto, in particolare
via terra. I rapporti di costo fra trasporto via mare, via fiume,
via terra nell’impero romano sono (dato 1 il mare): 1:4,9:28. Gli stessi
rapporti nelle zone impervie oltre la frontiera del Reno diventano:
1:5,9:62,5. Nell’Inghilterra del XV-XVI secolo abbiamo invece
1:4,7:22,6, con una sensibile riduzione dei costi di trasporto via-terra.
Nel mondo romano accadeva così che molte merci a basso valore
aggiunto raddoppiassero il prezzo nel giro di poco più di duecento
chilometri, mentre in tutto il Trecento italiano il trasporto anche a
lunga distanza di fustagni e panni avrà un’incidenza sul costo com-
L’Oriente
8.2. Il mondo delle merci
8. L’economia tra la fine della repubblica e l’impero 156
plessivo tra l’8 e il 28%.
Un’iscrizione in greco e in latino della prima età imperiale trovata
in Turchia fornisce un’informazione ravvicinata sui problemi del trasporto
via terra (Gara 1994, pp. 86-87). È una regolamentazione dell’impiego
dei mezzi di trasporto nella zona di Sogolassus. Viene fissato
un tariffario per tali mezzi di trasporto e si elencano le categorie di
persone che ne potevano usufruire (militari, procuratori, senatori,
...). Ogni carro deve costare 10 assi (circa 2 dollari) all’ora, 4 assi
un mulo, 2 un asino. Sono dati rilevanti: «due assi per un carico di 70-
80 kg (carico di un asino) per un’ora di percorso, [sono] una cifra non
irrisoria, soprattutto considerando che il territorio di Sogolassus è
montagnoso e la distanza coperta in un’ora non poteva essere rilevante
» (Gara 1994). L’editto conferma dunque che il prezzo del trasporto
non veniva calcolato in base al valore della merce (ad
valorem), ma in base al peso: merci pesanti e a basso valore aggiunto
venivano penalizzate rispetto a quelle più leggere e preziose.
1.3. Drammaturgia 255
9.15. LE ASSEMBLEE POPOLARI
I Romani impiegavano tre parole per indicare un’assemblea legittima,
con(ven)tio, comitia, concilium, che etimologicamente rinviano all’azione
di venire, andare o chiamare a raccolta.
La contio si tiene per «parlare al popolo senza sottoporre alcuna
proposta al suo voto» (Gellio, 13.16.3). In ciò si distingue nettamente
dalle altre due forme, che hanno funzione deliberativa (e delle quali
sole, perciò, fa menzione una legge di fine II secolo, la lex Latina
tabulae Bantinae, ed. Roman Statutes, nr. 7, lin. 5, nel disporre la
perdita del diritto di voto a carico del trasgressore: «Qualunque magistrato
terrà i comitia o il concilium, non gli consenta di esprimere il
suffragio»). Lo scopo primario della contio era, quindi, la comunicazione
al pubblico delle ordinanze magistratuali, che avevano perciò
il nome di edicta, sebbene spesso la loro complessità ne imponesse
la pubblicazione anche per iscritto. La contio, tuttavia, rappresentava
anche la principale arena in cui si formavano gli orientamenti politici
della massa urbana, specialmente a partire dall’età dei Gracchi, con
una progressione che raggiunse l’apice con la tattica popolare di
Publio Clodio Pulcro all’inizio degli anni cinquanta. Vi potevano avere
luogo, infatti, anche veri e propri dibattiti, come, ad esempio, a
favore (suasio) o contro (dissuasio) una proposta di legge da sottoporre
ai comitia o al concilium. Tali dibattiti, per la verità, erano più
simili a moderne conferenze stampa che alle assemblee greche, dominate
dalla libertà di parola: «Tutti gli affari pubblici dei Greci sono
amministrati dall’audacia di un’assemblea che siede per deliberare»
9.15. Le assemblee popolari
Contio
9. Il diritto e la costituzione in età repubblicana 256
(Cicerone, Pro Flacco, 16). La contio romana, infatti, era confinata
politicamente in uno stretto spazio istituzionale, dominato dai tribunali,
dai magistrati e dal senato (Cicerone, Pro Flacco, 57) ed era sottoposta
a rigidi controlli nel suo svolgimento. Era «convocata da un
magistrato o da un sacredote pubblico per mezzo di un araldo» (Festo,
Pauli excerpta, p. 34.1 L.) e spettava al presidente concedere il
permesso di parlare. Di fatto, ottenerlo era pressoché impensabile
per chi non fosse attualmente un magistrato o non lo fosse stato. Basti
dire che, nell’ultimo secolo della repubblica, sono stati contati
solo cinque individui che salirono alla tribuna senza esserlo; è emblematico,
inoltre, che un cittadino impegnato e oratore facondo
come Cicerone non abbia preso la parola in una contio prima d’avere
quarant’anni e la carica di pretore. Perciò a Roma, sebbene chi aspirasse
a fare carriera politica dovesse essere un buon oratore, per parlare
in una contio occorreva avere già fatto carriera. Ciò dimostra,
ancora una volta, che l’avanzamento nelle magistrature dipendeva,
innanzitutto, dall’estrazione familiare e l’arte della parola, piuttosto
che nell’oratoria politica (riservata, semmai, ai dibattiti nel chiuso del
senato), si esercitava soprattutto nelle arringhe giudiziarie, che rappresentavano,
come s’è accennato, una delle strade maestre per dare
prova di essere all’altezza degli antenati (§ 9.4). In definitiva, nella
contio esponenti del gruppo dirigente si rivolgevano alla plebe urbana
per sollecitare una qualche mobilitazione a sostegno delle proprie
politiche: i limiti di quest’assemblea sono bene definiti dal frequente
paragone di essa con i giochi e gli spettacoli gladiatori, come momenti
di socializzazione.
Comitium, al singolare, è parola che indica un luogo «così detto a
coeundo, cioè “andare insieme”» (Festo, Pauli excerpta, p. 34.13 L.).
A Roma è l’area nella quale si prolunga la parte settentrionale del
Foro; la sua prima pavimentazione, che testimonia la definizione
d’uno spazio politico, è assegnata agli anni intorno al 625 a.C. Al plurale,
la parola è passata a designare l’assemblea.
Fra i comitia, la forma più antica era quella dei comitia curiata,
che risalgono all’età monarchica (Varrone, De lingua Latina, 5.32:
«Comitium è così detto dal fatto che vi “andavano insieme” per i
comitia curiata e per le liti»). Erano la riunione delle curiae, divisioni
della popolazione che avevano probabilmente origine in aggregati
parentelari addirittura precivici (la parola deriva forse da *coviriae,
luoghi di riunione dei viri; cfr. osc. covehria). Le trenta curie dei tempi
storici, i cui nomi erano in parte toponimi, in parte antroponimi,
erano inquadrate per dieci nelle tre tribù genetico-territoriali dei
Comitium
e comitia
Comitia
curiata
1.3. Drammaturgia 257
Tities, Ramnes e Luceres, anch’esse radicate in organizzazioni preurbane
(vd. § 2.1). Quando scrive Polibio, i comizi per curie sono un relitto
d’altri tempi e, del resto, i loro compiti furono sempre disomogenei
rispetto a quelli d’un’assemblea repubblicana. I comitia calata
(sintagma che designa l’assemblea con riferimento al rito di convocazione,
detto calare, che per le curie era affidato a littori, mentre per le
centurie a sonatori di corno, come spiega il giurista Labeone presso
Gellio, 15.27.2) assistevano per curie all’inaugurazione dei flamini e
del rex sacrorum, figura quest’ultima nella quale si vedeva la continuazione
del re nella sua veste di sacerdote; il rito si svolgeva in conformità
alla decisione del collegio dei pontefici. Inoltre, arbitri ancora
i pontefici, le curie deliberavano sull’adrogatio, cioè l’adozione di
un pater familias da parte di un altro capofamiglia. Le curie emettevano,
infine, una lex, detta appunto curiata, che era un atto d’investitura
dei magistrati che seguiva l’elezione vera e propria effettuata nei
comizi centuriati o tributi. Benché vi fosse una sicura relazione fra
questa lex curiata e l’esercizio del comando militare (si sa, oltretutto,
che i consoli interessati presiedevano a questo scopo essi stessi i comizi,
cui assistevano gli àuguri), sembra tuttavia non fosse richiesta
solo per le magistrature cum imperio, ma per tutte quelle «patrizie» –
esclusi cioè, i tribuni e gli edili plebei (vd. § 9.13) – con la sola eccezione
della censura (Cicerone, De lege agraria II, 26-27; Marco
Messala, Liber de auspiciis, in Gellio, 13.15.4). L’estraneità dell’assemblea
per curie al gioco politico e, al tempo stesso, il tenace attaccamento
dei Romani alla tradizione sono segnalati dal fatto che la lex
curiata, nella tarda repubblica, pur continuando a essere emanata,
perché ritenuta indispensabile sotto il profilo degli auspicia, veniva
votata dai trenta littori curiati in rappresentanza delle trenta curie.
Per avere un quadro vivace delle assemblee nelle quali, invece, a
quel tempo si svolgeva la partecipazione politica dei cittadini si può
leggere il discorso che Livio, 39.15.11, attribuisce al console del 186
a.C. Spurio Postumio Albino. Deplorando le illegittime riunioni notturne
degli adepti dei culti bacchici, in gran parte donne, il console
affermava: «I vostri antenati vollero che neppure voi [ossia, i cittadini
di sesso maschile] vi riuniste alla rinfusa e senza motivo, bensì solo
quando, innalzato il vessillo sull’Arce, l’esercito fosse stato condotto
fuori per i comitia oppure quando i tribuni avessero indetto un
concilium per la plebe oppure uno dei magistrati avesse chiamato
alla contio. E ovunque vi fosse un assembramento, ivi ritenevano dovesse
esserci anche un capo legittimo della folla». Il testo, che appunto
passa sotto silenzio i comitia curiata, allude, per così dire in ordi-
9.15. Le assemblee popolari
9. Il diritto e la costituzione in età repubblicana 258
ne decrescente di solennità, ai comitia centuriata, al concilium plebis
e alla contio (nell’ambito della quale Sp. Postumio teneva il suo discorso).
S’è già osservato che quest’ultima si differenzia dalle prime
due perché non ha funzione deliberativa. La differenza fra comitia e
concilium, invece, sta nel fatto che i primi comprendono «il popolo al
completo», «in ogni sua parte e in tutti i suoi ordini», il secondo «una
parte», ossia la plebe; infatti, «non vi sono comprese le genti patrizie
dei cittadini». La differenza è concettualmente netta, come precisano i
giuristi Capitone e Lelio Felice con le parole appena riportate (Gellio,
10.20.5; 15.27.4) e come tale è rispettata, con poche eccezioni, anche
nel lessico non specialistico: resta a ricordare, come una ferita mai
rimarginata, i tempi della lotta fra gli ordini. Tuttavia, nell’epoca di
cui discorriamo, ridottisi demograficamente i patrizi a un piccolo
campione e, di conseguenza, divenuta di fatto quasi omogenea la
composizione personale delle due forme assembleari, a tenerle distinte
valevano molto di più i sistemi di voto che vi si praticavano. A
essi – e all’iter legis, con le suasiones, le dissuasiones e la promulgatio
– allude efficacemente un brano di Cicerone, il quale pure, come poi
Livio, ne attribuisce l’ideazione agli antenati, personificando la natura
tradizionale delle istituzioni romane: «Quei nostri concittadini pieni
di saggezza e di virtù ... vollero che le delibere della plebe o i comandi
del popolo fossero approvati o respinti solo dopo che fosse
stata sciolta la contio, previa distribuzione delle unità di voto, avendo
distinto per tribù e per centurie gli ordini, le classi, le età, dopo avere
ascoltato pareri autorevoli e lasciata a lungo affissa in pubblico la
proposta, perché se ne potesse prendere conoscenza» (Pro Flacco,
15).
I comitia centuriata, come ricorda il discorso consolare immaginato
da Livio, sono un’assemblea cui il popolo prende parte inquadrato
militarmente (exercitus). Le unità di voto, come precisa per parte
sua Cicerone, sono le centurie, che costituiscono anche le unità di
base dell’ordinamento oplitico-falangitico (sostituite nel IV secolo
dal manipolo: vd. § 3.5), le unità di leva (soppiantate nel III secolo
dalle tribù) e i quadri di prelievo tributario (che fu sospeso nel 167
a.C.). A ricordare l’origine militare di questi comizi restava, fra l’altro,
la terminologia, il rituale e il luogo di convocazione. Anche in funzione
politica, l’exercitus era convocato al suono delle trombe militari,
in un’area dedicata a Marte esterna al pomerio, cioè allo spazio inaugurato
che circondava le mura cittadine e poneva termine all’auspicium
urbanum.
Nella forma più antica a noi conosciuta, che la tradizione attribui-
Comitia
centuriata
Centurie
Classi
1.3. Drammaturgia 259
sce al re Servio Tullio, ma che si perfezionò verosimilmente solo verso
la fine del V secolo – a seguito dell’introduzione a Roma dall’Etruria
della tattica oplitico-falangitica, che si compì probabilmente
fra VI e V secolo, e in connessione con l’introduzione della legione di
sessanta centurie (vd. § 2.2) – le centurie di fanteria erano distribuite
in cinque classi di censo: ottanta nella prima, venti nella seconda,
nella terza e nella quarta, trenta nella quinta. Entro ciascuna classe le
centurie erano ripartite per età, in uguale numero, fra iuniores, cioè
adulti atti alle campagne militari esterne e seniores, lasciati a difesa
della città. L’attribuzione ad una certa classe di censo determinava
anche l’armamento di cui ciascun fante si doveva provvedere, che
andava dalla panòplia oplitica della prima classe (elmo, scudo,
schinieri e corazza, tutti in bronzo, lancia e gladio) alle fionde e pietre
della quinta (le centurie dei iuniores delle prime tre classi corrispondono,
per numero e armamento, all’originaria legione unica di
sessanta centurie di cento uomini). Quattro centurie aggiuntive erano
destinate ai servizi non armati: due erano composte da falegnami e
da fabbri (assegnati alle macchine da guerra) ed erano aggregate ai
fini del voto alla prima o alla seconda classe, due da sonatori di tuba
e sonatori di corno, aggregate alla quarta o alla quinta. Fra i cittadini
più abbienti erano reclutate, invece, diciotto centurie di cavalieri, che
militavano su cavalli forniti a spese pubbliche; altri cittadini dotati
del medesimo censo equestre, ma non insigniti dell’equus publicus e,
pertanto, iscritti nella prima classe di fanteria, potevano essere chiamati
per esigenze belliche a integrare le file dei cavalieri, militando
su cavalli acquistati e mantenuti a spese proprie. Completava il sistema
un’ultima centuria, nella quale confluivano i cittadini che non
raggiungevano la soglia patrimoniale minima ed erano perciò censiti
solo in quanto persone (capite censi) ed erano esclusi anche dalla
milizia di fanteria (ad essi attinse, invece, Mario: vd. § 7.1). Il totale è
di centonovantatré centurie (Livio, 1.43.1-11; cfr. Dionigi, 4.16-18;
7.59). Nel corso del III sec. a.C. una riforma pose il sistema in relazione
con le tribù territoriali, le quali, con l’istituzione della Quirina e
della Velina, avevano raggiunto nel 241 a.C. il numero definitivo di
trentacinque. I particolari di questa riforma sono oscuri (e sono stati
solo di riflesso illuminati dalla lex Valeria Aurelia epigrafica, che riguarda
i comizi d’età augustea e tiberiana: ed. Roman Statutes, nr.
37). Di certo sembra esserci solo che il numero delle centurie della
prima classe fu ridotto a settanta, sì che, almeno entro di essa, ciascuna
centuria di iuniores e ciascuna centuria di seniores veniva a essere
collegata biunivocamente con una delle trentacinque tribù, tanto da
9.15. Le assemblee popolari
Riforma del
III sec. a.C.
9. Il diritto e la costituzione in età repubblicana 260
poter essere chiamata «parte d’una tribù» (Cicerone, Pro Plancio, 49;
vd. anche Livio, 24.7.12, del 215 a.C.).
Come si è detto, il principio costitutivo di quest’ordinamento è
quello censitario. È incerto se all’origine la sola forma di ricchezza
stimata fosse quella immobiliare. In astratto, è possibile che si tenesse
conto fin dall’origine anche della ricchezza mobiliare e in particolare
(pre)monetaria, forme della quale affiorano già all’epoca cui la
tradizione fa risalire l’introduzione del reclutamento su base censitaria,
come attesta a livello numismatico l’aes signatum del tipo più
antico, lingotti contrassegnati dall’emblema del «ramo secco». Tuttavia,
a parte le illazioni che si possono trarre da termini come adsidui
e proletari (§§ 2.1, 9.6), è significativo il rilievo che il criterio della
proprietà immobiliare possiede ancora nei censimenti del II secolo
a.C., come sembra ad esempio emergere da Livio, 45.15.2, relativo all’iscrizione
dei libertini nelle tribù. Ad ogni modo, secondo un’interpretazione
persuasiva, Livio, 1.43.2-7, consente di conoscere i limiti
inferiori di censo per l’iscrizione nelle cinque classi in vigore nel III
secolo, cioè, rispettivamente 10.000, 7.500, 5.000, 2.500 e 1.100 assi
librali ridotti, di dieci once (limiti che Livio moltiplica per dieci, per
tradurli nella moneta circolante nella tarda repubblica, l’asse unciale,
1/12 di libbra). Non si conoscono con sicurezza i successivi ritocchi
subiti in conseguenza della riduzione del peso dell’asse a un sesto di
libbra, verificatasi al tempo della guerra annibalica. Tuttavia, sembra
che nel corso del II secolo la distanza fra la prima e la quinta classe si
sia accentuata in termini reali, come riflesso normativo della forbice
che s’apriva sempre più fra ricchi e poveri e, al tempo stesso, della
proletarizzazione dell’esercito (cioè l’estensione del reclutamento ai
ceti meno abbienti, cui si provvedeva abbassando la soglia d’ingresso
nei proletari, nozione il cui significato tecnico resta peraltro discusso:
vd. anche § 3.5). Quanto al censo equestre, in origine non sembra sia
stato esplicitamente distinto da quello della prima classe, ma fu poi
fissato in una somma pari a dieci volte tanto intorno al 150 a.C.
Fino a quando fu mantenuta, la coincidenza fra i quadri di combattimento,
di leva, tributari e di voto da una parte e la distribuzione
in essi della cittadinanza in base alla ricchezza dall’altra facevano sì
che la misura degli oneri militari e tributari e dei diritti politici spettanti
a ciascun cittadino fosse funzione della ricchezza. Poiché da
ogni centuria era reclutato un uguale numero di soldati e levato il
medesimo tributo complessivo e poiché gli appartenenti alle singole
centurie della prima classe erano meno numerosi di quelli delle altre,
i più abbienti dovevano servire più spesso e pagare una quota d’im-
Censo
Proporzionalità
di oneri e
diritti politici
1.3. Drammaturgia 261
posta più elevata. Cicerone, De re publica, 2.40, afferma addirittura
che una sola centuria delle classi inferiori alla prima conteneva quasi
più individui dell’intera prima classe, anche se il riferimento cronologico
a questa situazione è impreciso; per Dionigi, 4.18.2, la centuria
dei capite censi era da sola più numerosa della somma delle restanti.
La contropartita è la proporzionalità dei diritti politici. Poiché ogni
centuria esprimeva un voto, determinato dalla maggioranza dei suffragi
espressi al suo interno, il voto dato in una centuria meno affollata
pesava più di quello dato in una centuria stipata. Inoltre, la maggioranza
nei comizi centuriati era costituita da novantasette voti e,
quindi, prima della riforma del III secolo a.C., poteva essere raggiunta
con il voto compatto delle centurie dei cavalieri e della prima classe
(novantotto in totale) e, dopo la riforma, con la semplice accessione
di nove centurie delle altre classi. Inoltre, l’ordine di chiamata –
almeno, dopo la riforma del III secolo – era congegnato in modo tale
che una centuria della prima classe estratta a sorte votasse per prima
(praerogativa) e il risultato fosse proclamato immediatamente, perché
fungesse da autorevole indicazione di voto per tutte le altre. Cicerone
notava che «una sola centuria praerogativa ha tanta autorità
che non è mai capitato che un candidato sia riuscito il più votato da
essa e non sia stato poi eletto console, in quegli stessi comizi o almeno
in quell’anno» (Pro Plancio, 49). Può darsi che si riferisse a un
superamento di questo privilegio Dionigi d’Alicarnasso, 4.21.3, quando
parlava, per esperienza diretta, d’una trasformazione in senso democratico
dei comizi, ottenuta senza alterarne la struttura, ma solo,
appunto, modificando l’ordine di chiamata.
L’ordinamento centuriato, nel suo riflesso politico, aveva dunque
carattere spiccatamente timocratico, secondo una valutazione esplicitamente
teorizzata nel I sec. a.C. (per la precisione, anche gerontocratico,
perché, a paragone delle centurie dei iuniores, costituite da
adulti fra i 17 e i 45 anni, quelle dei seniores, comprensive della fascia
d’età fra i 46 e i 60 anni, erano naturalmente meno affollate),
controbilanciato dai maggiori oneri militari e finanziari che gravavano
sui più abbienti. Tuttavia, nel giudicare il sistema politico romano,
non bisogna trascurare che, nel tempo, questa simmetria andò perduta,
lasciando sul piatto della bilancia solo gli onori: la percezione del
tributum, come s’è accennato, fu sospesa dal 167 a.C. e il principio
del reclutamento censitario, dopo essere stato progressivamente
eroso, fu abbandonato, anche se non abolito, nel 107 a.C. (vd. § 7.1).
La struttura centuriata sopravvisse, tuttavia, nei comizi: Mario che arruolò
i capite censi volontari, eludendo la leva basata sulle classi, fu
9.15. Le assemblee popolari
Principio
timocratico
e gerontocratico
9. Il diritto e la costituzione in età repubblicana 262
eletto console per cinque volte consecutive da comizi in cui continuava
a vigere il principio timocratico.
Nel concilium, l’assemblea della plebe, le unità di voto sono le
tribù, vale a dire divisioni della popolazione in base al luogo ove si
trovava la proprietà immobiliare o la residenza (sul numero e gli incrementi:
vd. § 2.4). L’annalistica data al 471 a.C. l’istituzione del voto
per tribù, riferendolo tuttavia apparentemente ai comitia, non al
concilium. Ad ogni modo, in età meglio documentata, il concilium
plebis svolse un ruolo cruciale nel conflitto fra gli ordini, assicurando
il reclutamento dei tribuni e la formulazione delle politiche plebee.
La definitiva conclusione del conflitto coincide con il riconoscimento
della portata vincolante delle sue delibere per l’intero popolo, inclusi
i patrizi, riconoscimento che, nonostante le incertezze della tradizione,
non può essere stato anteriore alla fine del IV secolo e forse venne
solo intorno al 287 a.C., dopo una secessione sul Gianicolo, con
una lex Hortensia. Ciò che può ammettersi è che, anche prima di allora,
i tribuni usassero i loro poteri per evitare che gli scita plebis restassero
lettera morta.
Per completare la panoramica delle assemblee romane, occorre
accennare ai comitia tributa, assemblea deliberante di tutto il popolo
organizzato per tribù. La loro storia è misteriosa (si ricordi la tradizione
annalistica sulle sue origini nel 471 a.C.) e si è quindi addirittura
dubitato della loro esistenza – essi, del resto, mancano anche nel
quadro tracciato dal console Postumio nel suo discorso in Livio – e si
è stati indotti pensare che si tratti d’una semplice mutazione del concilio
plebeo, reso accessibile ai patrizi. Tuttavia, ciò sembra da escludere,
considerato il formalismo dei Romani. D’altra parte, la difficoltà
che talora si incontra a differenziarli dai comizi centuriati dipende dal
fatto che, come s’è accennato, con la riforma del III secolo era stata
istituita una connessione fra il sistema delle tribù e l’organizzazione
centuriata, almeno nella prima classe, così che non è raro che talvolta
nelle fonti s’incontri menzione delle tribù dove ci si aspetterebbero le
centurie. Tuttavia, nonostante queste interferenze, un passo come
questo di Cicerone, De legibus, 3.44: «Il popolo diviso per censo, ordini,
età vota con maggiore riflessione di quello convocato in massa
per tribù», rende certo che vi fosse una precisa differenza fra comitia
centuriata e tributa e quindi questi ultimi siano da considerare un’assemblea
generale dotata di un’autonoma identità. La contiguità fra le
due forme comiziali, ma al tempo stesso la loro differenza, è testimoniata
dalla disinvoltura con cui Cesare, nel 44 a.C., all’annuncio della
morte di uno dei consoli, convertì nel giorno stesso del voto i comitia
Concilium
plebis
Comitia
tributa
1.3. Drammaturgia 263
tributa convocati in Campo Marzio per l’elezione dei questori nei
comitia centuriata per eleggere un sostituto del console morto (Cicerone,
Ad Familiares, 7.30.1: quel consul suffectus era destinato a restare
in carica poche ore, essendo ormai passato il mezzogiorno dell’ultimo
dell’anno; perciò Cicerone poté redigere un sarcastico rendiconto
della sua magistratura, nello stile degli elogia, segnalando che,
durante la carica di questo console, nessuno pranzò).
È evidente – per passare ora a una comparazione delle varie forme
– che l’equiparazione del plebiscitum alla lex e la convocazione a
comizio del popolo per tribù, produssero, almeno a partire dal III
secolo, una sia pur incompleta concorrenza fra i comitia centuriata
da una parte e il concilium plebis e i comitia tributa dall’altra, in cui si
praticavano, tuttavia, sistemi di voto divergenti. Un sistema topografico,
quello del voto per tribù, entrava cioè in concorrenza con il
sistema timocratico del voto per classi e centurie, in astratto minacciando
la preponderanza dei ceti abbienti che quest’ultimo assicurava.
La differenza fra i diversi meccanismi è ben presente, ad esempio,
a Cicerone, nel passo del De legibus (3.44) citato poco sopra, dove
contrappone il voto più «meditato» dei comizi centuriati a quello dei
tributi (vd. anche Dionigi, 7.59). Tuttavia, la “minaccia” rappresentata
dal voto per tribù non dev’essere enfatizzata. Da una parte, infatti,
come s’è detto, alcune decisioni rimanevano formalmente attribuite
ai comizi centuriati (prima di tutte, l’elezione dei magistrati più elevati)
e, comunque, il potere di convocazione e di proposta alle varie
assemblee era pur sempre nelle mani della magistratura, la quale –
compresi i tribuni della plebe – era soggetta a vari vincoli, sia pure
d’intensità diversa nella varie fasi storiche. D’altra parte, anche nell’organizzazione
per tribù, come in quella per centurie, non tutti i
voti avevano il medesimo peso. Il voto emesso dai cittadini iscritti
nelle tribù rustiche contava più di quello emesso nelle urbane, che
erano più affollate, come lo erano le centurie della classi inferiori rispetto
a quelle della prima. Il maggiore affollamento dipendeva dall’obiettiva
maggiore densità della popolazione urbana, ma anche dal
fatto che i censori vi iscrivevano, a prescindere dalla loro sede, i
liberti, i quali, intorno al 230 a.C., furono distribuiti nelle quattro tribù
urbane, per essere poi, con poche eccezioni, concentrati addirittura
in una sola da Tiberio Sempronio, padre dei Gracchi (i tentativi
di redistribuirli nelle trentacinque tribù che furono compiuti nel I secolo
a.C., da Publio Sulpicio Rufo a Clodio, non passarono o ebbero
vita breve). Più in generale, i censori vi relegavano gli individui e i
gruppi che volevano emarginare per il loro modo di vita, come, ad
9.15. Le assemblee popolari
Confronto
fra sistema
centuriato
e tributo
9. Il diritto e la costituzione in età repubblicana 264
esempio, gli attori (esclusi quelli di atellanae). Perciò, il fulcro del
concilium era comunque la classe dei contadini. Di fatto, poi, la partecipazione
al voto nelle tribù rustiche doveva essere piuttosto bassa,
se si considera la maggiore distanza dal luogo dell’assemblea rispetto
alle urbane. Questo fa supporre che l’esito del voto fosse determinato
dai proprietari che erano iscritti nelle tribù rustiche, ma risiedevano
a Roma e da quanti potevano comunque permettersi di abbandonare
la propria occupazione e recarsi più volte l’anno nell’urbe per
esercitare il diritto di voto, cioè, ancora una volta, dai più abbienti.
Delineata la struttura delle assemblee deliberanti, occorre precisare,
riprendendo un tema già sfiorato, che comizi e concilio si riunivano
e deliberavano esclusivamente per iniziativa di un magistrato
che ne avesse il diritto. L’exercitus, ovviamente, era convocato a comizio
da un magistrato cum imperio; lo stesso valeva per le tribù; il
concilio plebeo era indetto da tribuni e edili della plebe; inoltre, il
censore convocava l’exercitus centuriatus per procedere alla chiusura
quinquennale del censimento e il questore, sporadicamente, per
processi criminali, scopo per cui l’edile curule poteva convocare i comizi
tributi.
Il quadro essenziale delle competenze delle assemblee popolari
è quello tracciato da Polibio, 6.14, che descriveva i vari atti da un
punto di vista contenutistico, secondo un modello d’ascendenza greca
(esaminato al § 9.12). I Romani riconducevano efficacemente l’insieme
di questi atti a tre categorie, ossia «la creazione dei magistrati, i
giudizi popolari, gli ordini e divieti» (Cicerone, De legibus, 3.10), l’ultima
delle quali – «gli ordini e i divieti», ossia le leggi – raggruppa,
quindi, una serie di decisioni assembleari che, in Polibio, sono invece
enumerate distintamente.
Fra le materie sulle quali il popolo era chiamato a pronunciarsi,
ve n’erano alcune sulle quali era «signore», vale a dire erano di sua
riserva. Secondo l’elencazione di Polibio, che trova nelle altre fonti
conferme e precisazioni, interrogare il popolo era necessario per attribuire
le cariche (Polibio, 6.14.4; Cicerone, De lege agraria II, 11;
Pro Plancio, 11; Dionigi, 5.19; 6.66.2; 7.56.2), mettere a morte un cittadino
(Polibio, 6.14.4, 6; cfr. Cicerone, Ad Atticum, 4.17: vd. § 9.16),
richiamarlo da un giusto esilio (Livio, 5.46.11), conferire o togliere la
cittadinanza (Livio, 26.33.10), munire o privare del diritto di voto
(Livio, 38.36.8; 45.15.3), dichiarare guerra (Polibio, 6.14.10; Livio,
4.30; 38.45.6; Dionigi, 6.66.2; 7.56.2; Appiano, Bella civilia, 3.229),
concludere la pace (Polibio, 6.14.10; Sallustio, Bellum Iugurthinum,
39.3; Cicerone, De officiis, 3.3; Livio, 9.5.1-6; 9.8.5; 9.9.4-19; Dionigi,
Convocazione
delle
assemblee
Competenze
delle
assemblee
Materie
riservate
1.3. Drammaturgia 265
6.66.2; 7.56.2) e ratificare le alleanze e i trattati (Polibio, 6.14.11,
15.9). Queste materie compongono un quadro coerente e facilmente
riconoscibile. Vi si ritrova la città-stato con le sue caratteristiche fondamentali.
I componenti del gruppo sono chiamati a dare il loro voto
su questioni che riguardano l’esistenza fisica (condanna a morte) o
politica del civis (cittadinanza, esilio, diritto di voto), l’attribuzione
del potere (elezione dei magistrati), la guerra e la pace. Occorre, tuttavia,
ricordare – ricollegandoci alla valutazione sostanziale del ruolo
del popolo che già davano Polibio e Cicerone (vd. § 9.12) – che, in
talune di queste materie, sebbene il voto dei cittadini fosse formalmente
indispensabile, esso costituiva comunque l’ultimo elemento di
un processo di decisione che aveva il suo fulcro altrove, in genere nel
senato (vd. gli esempi al paragrafo precedente).
A parte queste materie riservate al voto dei cittadini, ben prima
che i populares vi si aggrappassero nella rincorsa al potere, si affermò
l’idea che il popolo fosse la fonte ultima di legittimità e, pertanto,
potesse intervenire in ogni decisione di rilievo politico, con la pretesa
riconosciuta di prevalere sulle altre istituzioni (salvo, naturalmente,
il parere del senato, che in taluni casi, come s’è ripetuto, era addirittura
sentito come obbligatorio). Tuttavia, esaminando l’uso che di
questo potere fu storicamente fatto, senza limitarsi cioè alle dichiarazioni
astratte (per quanto importanti nel determinare lo statuto del
civis, come s’avrà modo di osservare), si può misurare una notevole
distanza fra l’ideologia e la realtà, nel senso che il principio della
potestas omnium rerum attribuita al popolo, lungi dal dare adito a
una trasformazione radicale delle istituzioni, fu per lo più utilizzato
da esponenti della classe dirigente per alterare a proprio favore il
corso normale dei processi decisionali oligarchici. Per sua natura,
questo tipo di attività “strumentale” (o strumentalizzata) delle assemblee
non è suscettibile d’una descrizione sistematica. Si può procedere
per esempi: la provincia non attribuita dal senato poteva essere
chiesta al popolo (minacciò di farlo Scipione nel 205 a.C. se non gli
fosse stata affidata l’Africa); il trionfo negato dal senato poteva essere
celebrato per plebiscito (come fece Gaio Flaminio nel 223; non a
caso, Polibio, 2.21, vedeva in lui «l’iniziatore della politica demagogica
»); il console poteva essere obbligato a nominare un dittatore indicato
dal popolo; al concilium plebis poteva chiedersi che risolvesse
un appalto aggiudicato dai censori; l’autorizzazione a nominare legati,
di solito concessa dal senato – che attraverso questi incaricati di
missione esercitava un certo controllo sull’operato dei magistrati in
provincia – poteva essere data dal concilium.
9.15. Le assemblee popolari
Prevalenza
popolare
9. Il diritto e la costituzione in età repubblicana 266
Stretta fra le decisioni che scandiscono i momenti essenziali e
simbolici della vita cittadina da una parte e gli interventi strumentali
dall’altra, ebbe storicamente poco spazio la legge, intesa, come la si
intende nel moderno Stato legislativo, come norma generale ed
astratta (vd. anche § 9.7, per il diritto privato). Tacito esprimeva perfettamente
questa consapevolezza (Annales, 3.27.2): «Le leggi che
seguirono le Dodici Tavole, sebbene fossero talvolta dirette alla repressione
dei reati, più spesso sono state emanate fra i disordini, per
la lotta fra gli ordini o per ottenere cariche illecite o per bandire uomini
illustri o per qualche altro motivo perverso». Naturalmente, questa
scarsità della produzione legislativa – a parte il fatto che il giudizio
di Tacito è comunque un po’ troppo severo, poiché oltre alle Dodici
Tavole e a quelle di diritto criminale, non mancarono altre leggi
materiali importanti, specialmente nel campo del diritto pubblico –
non toglie che alla lex sia stato sempre riconosciuto ideologicamente
il primato fra le fonti di diritto.
Si può ora conclusivamente tornare sul ruolo dei cittadini nel
processo di decisione politica, sempre attenendoci al quadro dipinto
da Polibio, che godeva di un’impareggiabile visione della res publica.
Si deve ribadire, innanzi tutto, che il ruolo politico del popolo variò
nel tempo. Basti pensare che i quadri organizzativi rimasero sostanzialmente
immutati dalla metà del III secolo a.C., con l’istituzione
delle due ultime tribù e la parallela riforma delle classi, quando cioè
si era appena agli inizi della fase imperialista. In particolare, sebbene
le fonti si contraddicano nel descrivere i provvedimenti seguiti alla
concessione della citttadinanza romana agli Italici dopo la guerra sociale,
che moltiplicò il numero degli aventi diritto al voto, concordano,
tuttavia, nel presentarli come miranti a non consegnare il predominio
delle assemblee ai nuovi arrivati (vd., in particolare, Appiano,
Bella civilia, 1.214-215; vd. anche §§ 7.2, 7.3). Le diverse velocità cui
procedevano l’espansione e l’adeguamento delle istituzioni causarono
una crescente divaricazione fra corpo sociale e assemblee. Ciò significa
che i comizi che – per fare un esempio – approvarono nel 264
a.C. contro il parere del senato la spedizione militare in aiuto ai
Mamertini, rappresentavano i «molti» – per usare l’espressione di
Polibio, 1.10.1-3 (polloì) – ben più di quanto gli stessi comizi li rappresentassero
nel I secolo a.C., dopo l’immissione degli italici nella
cittadinanza romana. In questo senso, anzi, il crescente attivismo delle
contiones e delle stesse assemblee deliberanti a partire dall’età
graccana può essere considerato un effetto del distacco dalla base.
È evidente, in secondo luogo, che il principio censitario e la ri-
Legge
materiale
Ruolo
politico
dei cittadini
in assemblea
a) variabilità
nel tempo
1.3. Drammaturgia 267
partizione per tribù impediscono valutazioni generalizzanti del ruolo
politico dei cittadini, che presuppongono la fungibilità degli individui
come soggetti politici. A Roma, la misura della parte potenziale di
ciascun civis nel processo di decisione politica era determinata dalla
posizione specifica che occupava nelle tribù e nelle classi.
Poste queste due premesse, un punto che deve attirare l’attenzione
è l’irrisoria partecipazione dei cittadini alle assemblee. Stime approssimative,
ma indicative, rivelano che in media votava solo l’1-2%
degli aventi diritto. La percentuale è così bassa da apparire oggi inconcepibile,
anche per società meno propense alla partecipazione al
voto di quella italiana. Addossarne la responsabilità alle difficoltà
materiali che si frapponevano fra il diritto e la sua realizzazione, tuttavia,
non è sufficiente. In realtà – e si tocca così un secondo punto
importante – la disaffezione al voto non può essere disgiunta dalla
mancanza d’un vero interesse, che è a sua volta l’effetto d’una scarsa
libertà di scelta, che la teoria moderna ha invece individuato come
uno dei requisiti fondamentali perché si possa parlare di democrazia
in senso sostanziale.
Secondo una visione imperniata sugli studi prosopografici condotti
nelle scie di M. Gelzer e, soprattutto, di F. Münzer, questa scarsa
libertà sarebbe da imputare alla rete di relazioni, familiari, socio-giuridiche
(come la clientela) e politico-culturali (come l’amicitia) in cui
ciascun cittadino si trovava avviluppato e che predeterminava la direzione
del suo voto.
La revisione cui quest’impostazione è stata sottoposta negli ultimi
decenni, da una parte ha condotto ad accertare che l’estensione e
la tenuta di queste reti erano minori di quelle immaginate; d’altra parte,
si riconosce ora che non mancarono contese intorno a specifici
temi d’azione politica (diremmo programmi, o, addirittura, ideologie,
se le parole non rischiassero d’ingigantire fenomeni comunque limitati).
In particolare, era inevitabile che la competizione s’accendesse
per ottenere l’elezione alle cariche, obiettivo che necessariamente
metteva l’uno contro l’altro esponenti della classe dirigente (non è un
caso che il voto scritto sia stato introdotto in primo luogo proprio nei
comizi elettorali, dalla lex Gabinia tabellaria del 139 a.C.). Tali contese
avevano, quindi, indubbiamente come effetto, da un lato, di
aprire rivalità all’interno delle stesse coalizioni familiari e clientelari
e, d’altro lato, di stimolare i vari leader a cercare anche al di là delle
rispettive coalizioni il consenso necessario per fare prevalere le proprie
istanze. A ciò servivano campagne sempre più accurate, con
dispiegamento anche di notevoli mezzi finanziari, sia per l’allestib)
variabilità
soggettiva
9.15. Le assemblee popolari
c) scarsa
affluenza
d) scarsa
libertà
di scelta
9. Il diritto e la costituzione in età repubblicana 268
mento di spettacoli sia per distribuzioni fra i votanti, spesso oltre i limiti
via via più stretti che le leggi posero alla sollecitazione del voto
(ambitus).
Pur con queste precisazioni, tuttavia, nel valutare la libertà di
scelta lasciata ai cittadini, non bisogna dimenticare che l’iniziativa era
nelle mani dei magistrati, senza la cui convocazione e proposta le
assemblee non potevano deliberare e, indirettamente del senato, attraverso
lo strumento formale dell’auctoritas patrum o quello politico
della consultazione preventiva su cui vigilavano i tribuni della plebe.
Dal lato passivo, poi, la competizione per le cariche magistratuali
era strozzata dalla limitazione dell’eleggibilità ai soli cavalieri e, nelle
assemblee legislative, come s’è visto poco sopra, i temi in discussione
erano molto spesso il riflesso di lotte di potere interne all’élite,
prive o quasi d’interesse per la generalità del pubblico; marginali, nel
complesso, erano infine i processi popolari. È sicuramente partigiana
e condizionata dalla causa, ma tuttavia efficace la diagnosi degli
orientamenti politici della massa che Cicerone presenta nella Pro
Sestio: «oggi ormai non c’è quasi alcun punto sul quale il popolo la
pensi diversamente dagli aristocratici; non chiede nulla né aspira a
cambiamenti rivoluzionari» (104). È noto, del resto, l’ammonimento
che Quinto Tullio Cicerone rivolgeva al fratello candidato console,
«durante la campagna elettorale, meglio non occuparsi di politica né
in senato né nella contio» (Commentariolum petitionis, 53). Tornano
insomma alla mente le parole di De re publica, 1.47, che descrivono,
in una prospettiva radicale che certo non era quella degli ottimati romani,
le città nelle quali «a parole sono tutti liberi», visto che «votano,
attribuiscono comandi, magistrature, sono corteggiati dai candidati, li
si interroga sulle proposte di legge»; a ben guardare, tuttavia, ci si
accorge ch’essi «danno ciò che anche se non lo volessero, dovrebbero
dare e che manca proprio a loro, cui gli altri lo chiedono» (vd. anche
§ 9.12). In definitiva, vincoli sociali e scarsa attrattiva dei temi in
discussione si traducevano nella disaffezione al voto.
Se quel che si è venuto dicendo descrive, per usare un’espressione
eloquente, il «concreto del votante», ciò non toglie, tuttavia, che
per avere una visione equilibrata della condizione popolare si debba
tenere nella giusta considerazione anche l’ideologia della potestas
populi (in cui si vede, a ragione, l’equivalente del greco demokratia).
Del resto, nel passo poco sopra citato della Pro Sestio, fra le istanze
che un tempo, prima della concordia attuale, erano state oggetto di
contrasto fra massa e aristocratici, Cicerone menzionava proprio l’introduzione
del voto segreto nelle assemblee, per effetto di quattro
e) realtà
e ideologia
1.3. Drammaturgia 269
plebisciti emanati – appunto in mezzo a vivi contrasti – fra il 139 e il
107 a.C. (definiti, per la forma scritta del voto ch’essi prescrivevano,
leggi tabellariae: Cicerone, De legibus, 3.35-36): «il popolo riteneva
che si trattasse della sua libertà». Quest’esempio è la riprova del fatto
che il diritto di voto contribuiva in modo essenziale a definire lo statuto
di civis, anche al di là delle sue realizzazioni («quia populo licere
satis est»: Cicerone, De legibus, 3.39).
9.16. La repressione criminale
13. L’impero nel secondo secolo 344
Movimenti di
popolazione
entro
l’impero e
integrazione
13.3. GLI EQUILIBRI ETNICI E SOCIALI
L’arrivo degli schiavi in Italia nel corso dell’espansione aveva significato
sostanzialmente l’immigrazione forzata di un grosso numero soprattutto,
ma non solo, di orientali nella penisola. La composizione
etnica della penisola ne fu mutata, anche perché, attraverso la pratica
della manomissione, considerata in modo ambivalente come un fatto
positivo e negativo, dagli osservatori stranieri e dagli stessi politici
romani, l’integrazione di questi nuovi immigrati di provenienza
orientale con gli altri abitanti dell’Italia poteva attuarsi piuttosto facilmente:
non ostavano a questo processo atteggiamenti o pregiudizi
razzistici, che erano del tutto assenti nella società romana.
345
L’integrazione fu anche culturale e per esempio determinò il diffondersi
di pratiche religiose e di culto, soprattutto in quelle regioni
della penisola che erano legate da più stretti rapporti con l’oriente
come le città della Campania: così, ad esempio, si diffusero gli Isei e i
Serapei, gli edifici di culto delle due divinità egiziane di Iside e Serapide.
Si ebbe dunque un’integrazione nella penisola che riguardò la
popolazione nel suo complesso e anche i ceti subalterni.
Ma il processo di osmosi etnica e sociale non toccò solo l’Italia:
alla lunga interessò anche le province dove stazionavano gli eserciti.
Se nel periodo della conquista l’emigrazione dall’Italia aveva riguardato
soprattutto i mercanti e gli uomini d’affari, con lo stabilimento
della pax Augusta furono proprio i legionari, che erano inizialmente
di provenienza esclusivamente italica (§ 10.6), a rappresentare il più
potente veicolo della romanizzazione: della diffusione cioè della cultura
romana e della lingua latina. Anche in seguito l’esercito legionario
ebbe un ruolo decisivo nella dinamica dell’integrazione. Si è già
visto come le aree del reclutamento legionario nel I secolo fossero le
province più precocemente romanizzate, quali la Gallia Narbonense
e la Betica, oltre l’Italia, mentre gli ausiliari provenivano dalla Gallia
Comata e dalla Tarraconense. Queste unità militari costituite ormai
da Romani o da appartenenti a popolazioni profondamente romanizzate
furono quelle che valsero a romanizzare, a loro volta, profondamente
i distretti territoriali vicini al limes.
Ma forse più importante di questo processo, per le sorti future
dell’organismo imperiale, fu l’integrazione delle classi dirigenti dell’impero.
L’ascesa economica delle province fu parallela all’ascesa
sociale delle élites delle città provinciali. I senatori e i cavalieri cominciarono
a provenire dalle regioni più precocemente romanizzate,
le Gallie, le Spagne, l’Africa. Ad aiutare potentemente questo processo
contribuì in misura decisiva la promozione consapevole, da parte
dell’autorità imperiale, del modello di organizzazione sociale basato
sulle città: mentre le istituzioni cittadine di Roma, con la nascita del
principato, si snaturavano, esse mantenevano la loro vitalità nei centri
urbani dell’Italia e delle province. Questi centri vennero organizzati
e strutturati dall’autorità imperiale secondo una precisa gerarchia,
che vedeva i municipi di diritto romano e le colonie, soprattutto
quelle che godevano del privilegio del ius Italicum, al gradino più
alto, mentre il ius Latii manteneva la sua funzione di gradino intermedio
rispetto alle comunità peregrine nel processo di adeguamento
al modello romano.
L’integrazione conobbe però un limite: fu, appunto, in larghissi-
La dinamica
dell’integrazione
13.3. Gli equilibri etnici e sociali
13. L’impero nel secondo secolo 346
ma misura piuttosto un’integrazione orizzontale che verticale: non
fu, se non entro limiti modesti, un’integrazione fra i vari gradini della
gerarchia sociale. Il governo romano cercò sempre l’appoggio delle
élites locali: ma per renderle fedeli e interessate al mantenimento della
supremazia politica di Roma e alla stessa sopravvivenza dell’impero,
dovette garantire la loro posizione di preminenza a livello locale.
Di più: anche là dove erano presenti strutture sociali più egualitarie e
mancavano le élites, il governo romano le creò ex-novo. Le società
provinciali, perciò, nelle quali pure non mancava una certa mobilità
sociale, determinata se non altro dal fatto che il regime demografico
vigente, con la sua altissima mortalità, provocava frequentemente
l’estinzione delle famiglie, videro cristallizzarsi le differenze al proprio
interno: le élites locali, formate dal ceto decurionale (dal ceto di
coloro, cioè, che facevano parte dei consigli cittadini, un ceto che era
tendenzialmente ereditario), si distinguevano dalle plebi intramurane
– la maggioranza della popolazione cittadina – e da quelle extramurane
– i contadini, che costituivano la grande massa della popolazione.
Paradossalmente, a rappresentare l’elemento potenzialmente più
in grado di garantirsi un’agevole ascesa sociale, era quello dei liberti.
I liberti, che, come si è visto (§ 11.3), erano colpiti da limitazioni dei
propri diritti, per esempio al livello della partecipazione politica,
spesso godevano, all’atto della manomissione e specialmente se erano
stati fatti eredi dai propri ex-padroni, di disponibilità economiche
impensabili per gli ingenui (i nati liberi) di più umili condizioni, e
non erano condizionati, nel gestire le loro ricchezze, dai pregiudizi
ideologici che distoglievano gli appartenenti ai ceti alti dalle attività
commerciali e da alcune di quelle professionali, considerate sordide
e comunque indegne di un uomo di nascita libera. Erano perciò potenzialmente
più in grado di arricchirsi e, per questa via, di garantirsi
una certa ascesa sociale, di cui avrebbero potuto poi valersi pienamente
i propri figli nati dopo la manomissione (e perciò ingenui).
Il discrimine sociale fra ricchi e poveri venne ulteriormente a rafforzarsi
nel momento in cui, proprio nel corso del II secolo, cominciò
a valere un criterio di discriminazione sociale nella repressione criminale
(§ 18.9). La procedura affermatasi alla fine dell’età repubblicana
era quella che affidava il giudizio per i reati più gravi alle quaestiones
(§ 9.16): questi tribunali dovevano solo decidere se l’imputato fosse o
meno reo, ma la pena era fissa e stabilita a priori. Con l’affermarsi
della repressione criminale extra ordinem (§ 18.9), i giudici ebbero
inizialmente ampia discrezionalità nel graduare l’entità della pena
Honestiores
e humiliores
347
alla gravità del reato e al grado di colpevolezza del reo, anche attraverso
una valutazione della sua stessa personalità. Da qui a stabilire
una diversità della pena in base alla condizione sociale del reo il passo
era breve. Si affermò, dunque, già a partire dall’età adrianea, il criterio
della differenziazione delle pene pro qualitate personarum: alcune
pene, e segnatamente quella di morte, non venivano comminate,
di norma (e salvo nel caso di delitti politici), agli honestiores, agli
appartenenti ai ceti più elevati (senatori, cavalieri, decurioni delle
città); se la pena di morte veniva comminata, assumeva comunque la
forma della decapitazione e non quella della crocefissione o dell’esposizione
alle belve feroci nell’anfiteatro. Nel contempo si riconosceva
un valore diverso alle testimonianze a seconda della condizione
sociale del testimone.
La distinzione delle pene pro qualitate personarum non faceva
che ribadire la radicalità della differenziazione sociale all’interno della
popolazione dell’impero. Era in questa differenziazione sociale
che si risolveva, peraltro, la stessa differenziazione tra i singoli in termini
di statuto giuridico personale: lo stesso possesso della cittadinanza
romana, come diceva il retore greco Elio Aristide in una sua
celebre orazione in lode di Roma, recitata davanti ad Antonino Pio in
uno degli anni iniziali del suo regno, non indicava più l’appartenenza
al popolo dei conquistatori (26.63), ma era divenuto ormai il segno di
un discrimine sociale. Ciò vuol dire che correva più differenza tra il
decurione e il povero artigiano di una città dell’Asia Minore, che tra il
medesimo decurione e il suo omologo di una città spagnola.
13.4. La duplicità linguistica e culturale dell’impero
1.3. Drammaturgia 369
14.2. UNA PECULIARE ECONOMIA PREINDUSTRIALE
Al di là dei problemi posti dai costi proibitivi dei trasporti, va sottolineato
tuttavia che, per questo specifico aspetto del volume degli
scambi, sembra che l’economia romana imperiale abbia registrato
una situazione assai più favorevole rispetto ai secoli successivi alla
disgregazione dell’organismo imperiale: il volume degli scambi che
si raggiunse nell’area del Mediterraneo tra il I secolo a.C. e il III d.C.
probabilmente non sarebbe stato eguagliato che molto tardi dopo la
rottura della continuità in epoca tardoantica. Questa comparativamente
elevata consistenza degli scambi sembra essere il diretto portato
della creazione di un’organizzazione politica “imperiale”, che
riunifica tutta l’area del Mediterraneo antico. L’ampliarsi del settore
del mercato e la stessa “crescita” e lo stesso “sviluppo” dell’economia
imperiale romana sono in una prima fase il prodotto diretto della
conquista, mentre in una seconda fase sono il prodotto, si potrebbe
dire, del persistere dell’unità politica dell’organismo imperiale. E in
effetti le caratteristiche peculiari che differenziano l’economia romana
imperiale da altre economie preindustriali hanno a che fare con
l’impatto che ha sulla vita economica delle varie aree l’esistenza dell’impero
territoriale di grandi dimensioni e dell’organizzazione politica
su cui esso si basa.
Quali sono queste caratteristiche peculiari dell’economia imperiale?
Anzitutto l’urbanizzazione accentuata e capillarmente diffusa,
ma soprattutto caratterizzata da centri urbani di dimensioni assolutamente
ragguardevoli. Tra questi centri aveva naturalmente un posto a
sé la città di Roma, che avrà raggiunto e forse superato il milione di
abitanti nel corso della prima età imperiale. A Roma si affiancavano
altre “metropoli” con diverse centinaia di migliaia di abitanti, tanto
nell’Occidente quanto nell’Oriente: Cartagine, Alessandria, Antiochia,
Seleucia, Efeso, Pergamo, ma soprattutto una miriade di città
medio-grandi (dell’ordine di alcune decine di migliaia di abitanti),
sparse per tutto il territorio dell’impero, anche se non uniformemente
diffuse. Le città dell’impero assommavano a diverse migliaia. Calcolare
il loro numero pone problemi: la città nel mondo antico era un’entità
politica, prima di essere un aggregato di strutture abitative di dimensioni
consistenti. Centri di poche centinaia di abitanti potevano
vantare lo status di città, mentre grandi concentrazioni di migliaia di
abitanti restavano nella condizione di villaggi: per esempio il centro
egiziano di Karanis, la cui popolazione è stata valutata a 4.000 abitanti,
era un villaggio della chora egiziana del distretto arsinoite. Tra le
L’urbanizzazione
14.2. Una peculiare economia preindustriale
14. I caratteri dell’economia imperiale 370
regioni più urbanizzate figurava, ovviamente l’Italia, con le sue 430
città in età augustea: ma vi erano differenze tra una regione e l’altra:
le città della Cisalpina erano mediamente più grandi e dunque verosimilmente
più popolate, ma anche assai meno numerose e dunque
con territori assai più vasti. Altre regioni occidentali conobbero una
precoce e notevole urbanizzazione, come la Gallia meridionale, la
Betica e, più tardi, l’Africa. Alcune regioni orientali erano già fortemente
urbanizzate quando vennero annesse dai Romani. Un caso a
sé è quello dell’Egitto, che aveva, oltre ad Alessandria, centri urbani
di notevoli dimensioni e che come tali giocavano un notevole ruolo
economico, quali Ossirinco o Ermopoli, ma che non avrebbero avuto
che molto tardi (§ 15.2), il carattere di autonome comunità cittadine.
Sebbene gli studi più recenti abbiano posto il grado dell’urbanizzazione
dell’Europa del basso medioevo e della prima età moderna a
un livello assai più elevato di quanto non si ritenesse in passato (tanto
per le dimensioni di singoli centri urbani, quanto per il loro stesso
numero), sembra innegabile che esso non abbia raggiunto che molto
tardi il livello al quale era pervenuta l’urbanizzazione nei territori
dell’impero. Nell’Europa dell’età medievale e della prima età moderna,
in ogni caso, mancavano, o erano molto poco numerose le
grandi concentrazioni con centinaia di migliaia di abitanti. Solo dopo
il 1700 ci sarebbero state tre città, nell’area occupata in antico dall’impero,
con una popolazione superiore a 500.000 (Istanbul, Parigi e
Londra).
Questa così accentuata urbanizzazione era anzitutto causa ed effetto
a un tempo di un livello del popolamento complessivo non più
raggiunto, per alcune regioni meridionali e orientali del bacino mediterraneo,
sino al diciannovesimo o ventesimo secolo (e al di là del
problema di una determinazione quantitativa della popolazione, che
rimane problema assai discusso, e che comunque può riguardare solo
alcune regioni per le quali c’è la possibilità di arrivare a dati numerici
attendibili, come l’Italia o l’Egitto). Lo sviluppo delle città e un
forte popolamento dei centri urbani, infatti, non può che presupporre,
in uno scenario preindustriale (caratterizzato da una limitata produttività
di tutti i fattori di produzione, dalla terra al lavoro), un forte
popolamento rurale, che garantisca le condizioni di sopravvivenza
della popolazione urbana non impegnata nella produzione dei beni
primari.
Alcuni sparsi dati cifrati registrati nelle nostre fonti hanno sollecitato
tentativi ingegnosi dei moderni per individuare le dimensioni del
popolamento in alcuni momenti dell’epoca imperiale e in talune spe-
Il livello
del
popolamento
1.3. Drammaturgia 371
cifiche aree. Registrazioni di tipo censuale per varie ragioni nelle diverse
aree e a seconda dei tempi in effetti non mancavano nel mondo
romano. Una testimonianza assolutamente singolare che la tradizione
antica ci ha lasciato, traendola ovviamente da documenti ufficiali, e
che non pare avere paralleli nella storia del mondo premoderno, è
quella costituita dalle cifre risultanti da molte fra le enumerazioni che
si succedettero nel corso dell’età repubblicana e della prima età imperiale
(si tratta di una quarantina di cifre, relative al periodo che va
da Servio Tullio, che avrebbe secondo la tradizione introdotto il sistema,
sino a quelle dei tre censimenti effettuati nel 28 a.C., nell’8 a.C. e
nel 14 d.C. che Augusto stesso ci ha tramandato nelle Res gestae, 8.2-
4, e ancora alla cifra risultante dal censimento compiuto dall’imperatore
Claudio nel 47 d.C., ricordata da Tacito nei suoi Annales, 11.25).
Le cifre in età repubblicana si riferiscono ai maschi adulti, a coloro
che per la loro età sono «atti alle armi»: non è dunque difficile,
ipotizzando quale potesse essere, in termini percentuali, il numero
dei maschi in una popolazione come quella romana, stimare il numero
complessivo dei cittadini dei due sessi e di tutte le età. Nonostante
fossero previste pene molto severe per chi non effettuava la sua dichiarazione,
eludendo in tal modo i propri obblighi militari e fiscali,
non tutti i cittadini si saranno tuttavia sobbarcati all’onere di andare a
Roma e presentarsi davanti al censore, per farsi registrare: e la stessa
autorità non avrà perseguito con molto rigore quei cittadini che erano
troppo poveri per servire nell’esercito e pagare il tributo, i proletarii
(§ 9.6). I cittadini non censiti (incensi) andarono naturalmente
divenendo sempre più numerosi, a mano a mano che l’ager Romanus
si andò estendendo nella penisola sino a ricomprenderla, dopo la
guerra sociale, nella sua interezza. Sicché le cifre che la tradizione ci
ha conservato devono essere considerate dei semplici minimi. Negli
ultimi convulsi decenni dell’età repubblicana fu peraltro impossibile
procedere con regolarità alle operazioni di censimento.
La situazione dovette cambiare quando, con Cesare, venne introdotto
un nuovo criterio per effettuare la registrazione: d’ora in avanti
il cittadino capo famiglia non era più obbligato a recarsi a Roma a effettuare
la sua dichiarazione davanti al censore, ma la doveva effettuare
nel municipio o nella colonia dove era domiciliato e davanti ai
magistrati locali. Anche i cittadini romani residenti nelle province, ormai
molto numerosi, poterono essere ricompresi nel computo globale.
È forse come conseguenza di questa nuova maniera di effettuare
il censimento che si spiega come mai, nel 28 a.C., quando Ottaviano
14.2. Una peculiare economia preindustriale
14. I caratteri dell’economia imperiale 372
riuscì a censire nuovamente dopo più di quarant’anni i cittadini romani,
essi siano risultati più di quattro milioni, e cioè più di quattro
volte il numero dei cittadini romani nel 70, a meno di non voler pensare,
come una lunga tradizione di studi vorrebbe suggerire, che, a
partire da Augusto, siano stati enumerati non più soltanto i maschi
adulti, ma i cittadini di entrambi i sessi e di tutte le età.
Se riteniamo che i cittadini romani contati da Augusto erano i soli
maschi adulti, abbiamo modo di stimare l’ordine di grandezza della
popolazione libera dell’Italia romana, escluse le isole, nella prima età
imperiale: dieci-dodici milioni; a questi bisogna aggiungere un imprecisabile
numero di schiavi. L’Italia che aveva conquistato l’impero
e che era padrona del Mediterraneo risultava, non per caso, essere
anche la regione più popolata del mondo antico. Un pari livello di
popolamento sarebbe stato raggiunto di nuovo dalla penisola solo
nell’avanzata età moderna.
Non possediamo, putroppo, un documento paragonabile alle cifre
dei censimenti per i peregrini, nettamente maggioritari, com’è ovvio,
nelle province, anche se sappiamo che Augusto stesso introdusse,
a fini prevalentemente fiscali, il censimento nelle province, come
ci dice tra l’altro un luogo famoso del Vangelo di Luca (2.1-3). Qualche
indicazione delle fonti antiche consente, tuttavia, di formulare
ipotesi circa l’entità del popolamento nelle varie aree dell’impero:
per esempio da un luogo della Naturalis historia di Plinio (3.28) è
possibile inferire l’entità del popolamento di alcuni conventus della
Spagna e ancora da due luoghi di Diodoro (1.31.6-9; cfr. 1.80.6) e di
Flavio Giuseppe (Bellum, 2.385) quella della popolazione complessiva
dell’Egitto (anche se si tratta di notizie di cui rimane discusso il significato).
Questi dati confermano che tra le regioni più fittamente
popolate era, per l’appunto, la parte fertile dell’Egitto, e cioè la valle
del Nilo col Fayum e il Delta, dove venne raggiunto nella prima età
imperiale un livello di popolamento che sarebbe stato conseguito di
nuovo solo verso la fine del diciannovesimo secolo. Ma regioni densamente
popolate erano anche la Siria e buona parte dell’Asia Minore,
e l’Africa del nord avrebbe sperimentato nei primi secoli dell’età
imperiale un forte incremento demografico. Meno popolate erano le
regioni dell’Occidente, come alcune aree della Gallia e della Spagna,
e ancora le zone più prossime ai confini settentrionali.
18.
IL DIRITTO DA AUGUSTO
AL THEODOSIANUS
18.1. LA GIURISPRUDENZA CLASSICA: CARATTERI GENERALI
Per tutta l’età repubblicana, come s’è appreso (vd. cap. 9), il diritto
privato ebbe natura eminentemente giurisprudenziale, nel senso
ch’era rimesso in ultima analisi ai giuristi – dapprima in quanto pontefici,
poi in quanto riconosciuti esperti – d’individuare quale fosse il
ius, dichiarandolo nei responsa che fornivano a quei concittadini che
li interrogavano sui propri casi. Nell’individuare quale fosse il ius, i
giuristi erano guidati da criteri e scelte di valore che raramente trovavano
enunciati in leggi o in altri atti normativi espliciti. Benché la lex
votata dalle assemblee popolari occupasse il vertice delle fonti del
diritto e, in particolare, le leges delle Dodici Tavole non abbiano mai
cessato d’essere considerate la matrice dell’intero ordinamento, di
fatto raramente si ricorreva ad una legge per fornire la massima di decisione
d’un conflitto d’interessi (vd. §§ 9.7, 9.8). In questo quadro, i
criteri normativi cui i giuristi per lo più ispiravano le proprie decisioni
erano elaborati per via di “costruzione giuridica”, spesso ancorata
alla struttura formale degli atti oppure – specialmente in seguito all’apertura
mercantilistica della società romana, cui corrispose un processo
di deformalizzazione – erano ricavati dalla struttura socio-economica
dei rapporti presi in considerazione. Per questo, il sistema
giuridico romano è definito oggi un “sistema aperto”, per contrapporlo
a quei sistemi – fra i quali, ad esempio, quelli attuali dei paesi
europei continentali – nei quali i giuristi trovano appunto già poste le
massime di decisione e non partecipano alla loro statuizione (sotto
questo profilo, può essere invece avvicinato al common law inglese).
Pur se alieni dalle teorizzazioni, i giuristi romani non potevano
non essere coscienti di quest’assetto, come traspare ad esempio dalla
definizione del ius come ars boni et aequi, ossia come tecnica del
Diritto
giurisprudenziale
Sistema
aperto
18. Il diritto da Augusto al Theodosianus 466
buono e dell’equo, formulata dal giurista Celso (D. 1.1.1 pr.).
L’interpretatio giurisprudenziale non era, quindi, o era solo marginalmente
attività di esplicazione di testi normativi, come potrebbe
invece far pensare la corrispondente parola moderna «interpretazione
», solitamente riferita a un “sistema chiuso”. Insieme alle leges,
quest’interpretatio costituiva il ius civile in senso stretto, al quale, a
partire dal III sec. a.C., si venne sovrapponendo la iurisdictio del pretore,
come momento di realizzazione pratica, attraverso il processo,
del ius civile stesso, ma anche come occasione per correggerlo e integrarlo
e le cui linee erano esposte nell’editto.
La natura giurisprudenziale del ius sopravvisse alla trasformazione
della costituzione mista in principato ossia in monarchia temperata
nelle forme (che è illustrata al cap. 10). Naturalmente, la presenza
di un’istituzione accentratrice come il princeps, che tendeva, come
costatavano i contemporanei, «ad appropriarsi delle prerogative del
senato, dei magistrati, delle leggi» (Tacito, Annales, 1.2.1), non rimase
senza conseguenze sul piano del diritto. Tuttavia, specialmente se
si eccettua la stagione della legislazione etico-demografica augustea
(nella quale, oltretutto, la volontà del princeps fu pur sempre rivestita
delle forme della lex publica), si può affermare che l’influenza imperiale
si sia manifestata meno sui contenuti del ius e piuttosto sull’organizzazione
giudiziaria e sul ruolo socio-politico dei giuristi. In particolare,
sebbene fosse stato precocemente riconosciuto al principe il
potere di emettere norme giuridiche, nella forma di constitutiones
(vd. § 18.6), storicamente l’uso di tale potere fu abbastanza sporadico
fino alla metà del II sec. d.C. Anche quando, in seguito, le constitutiones
si fecero più frequenti, esse rimasero prevalentemente iscritte
all’interno dell’impianto casistico del diritto romano. Infatti, se si eccettuano
gli editti, le costituzioni del principe erano per lo più emesse
con riferimento appunto a casi concreti, affrontati in sede giudiziaria
o sulla base di una petizione, e tendevano quindi ad applicare
e riprodurre il diritto vigente. Anche quando se ne allontanavano,
dovevano comunque passare per il crivello dei giuristi, alla cui interpretatio
spettava di vagliare l’effettiva portata di queste statuizioni,
inserendole nel circuito del diritto giurisprudenziale.
Per quel che riguarda poi specificamente la tecnica giurisprudenziale,
nei primi tre secoli della nostra era essa continuò a seguire
i canoni fissati dai giuristi repubblicani. Ciò non toglie che, in connessione
con le mutevoli condizioni politiche e culturali e grazie a
individualità di grande valore, la giurisprudenza del principato abbia
una sua profondità storica. Inoltre, specialmente dall’età adrianea, in
Interpretatio
Persistenza
del carattere
giurisprudenziale
del
diritto nel
principato
Classicità
della giurisprudenza
1.3. Drammaturgia 467
coincidenza con l’emergere della personalità del giurista Salvio Giuliano,
e fino a tutta l’età dei Severi, la produzione letteraria dei giuristi
si intensificò notevolmente in quantità e s’aprì anche a nuovi temi,
capitalizzando il patrimonio di pensiero dei secoli precedenti e
incrementandolo d’ulteriori sviluppi. Se si aggiunge che, per effetto
di vari fattori per lo più socio-politici, una letteratura giuridica originale
cessò, quasi all’improvviso, intorno alla metà del III secolo d.C.
e che perciò le epoche successive dovettero rivolgersi principalmente
proprio agli scritti dei giuristi adrianei, antonini e severiani e se si
rammenta, inoltre, che, proseguendo lungo questa linea, l’imperatore
Giustiniano ne redasse un’antologia, il Digesto, che portò in salvo
proprio queste opere, consegnandole al medioevo occidentale e all’età
moderna, si comprende perché, fin dall’Umanesimo, la giurisprudenza
di questo periodo (e, più in generale, quella del principato)
sia considerata «classica». Per un insieme di circostanze, in parte
attribuibili a suoi effettivi valori, in parte alla sua fortuna letteraria, la
giurisprudenza del principato (e, per una serie d’impercettibili, ma
storiograficamente rischiosi slittamenti, il “diritto” di questo periodo)
è insomma considerata il tratto più alto d’una parabola, iniziata da
Sesto Elio, se non già da Appio Claudio e Gneo Flavio e destinata a
concludersi con Giustiniano.
18.2. I RUOLI DEL GIURISTA:
I CONSULENTI E IL PUBLICE RESPONDENDI IUS
Come s’è accennato, il mutamento principale, rispetto all’epoca precedente,
investì la posizione socio-politica del giurista. Da una parte,
infatti, con il mutare dell’assetto costituzionale, si sfaldò il modello
stesso dell’aristocratico, di cui la cognizione del ius era una componente
e, di pari passo, crebbe il peso del principe nel fornire alla giurisprudenza
una legittimazione. D’altra parte, se nell’età repubblicana
l’ufficio di giurista era – o almeno appare essere stato – un ruolo
monolitico, nel corso del principato si andò articolando in vari ruoli
specialistici. Quest’articolazione fu il risultato d’una più generale tendenza
alla specializzazione che investì tutte le discipline e le abilità,
ma anche della progressiva diffusione del diritto romano nell’impero,
che incrementò la domanda d’esperti in tutte le regioni.
Fra le varie vesti sotto cui si presenta il giurista fra la fine del I
secolo a.C. e la metà del III secolo d.C., cioè quella del consulente,
18.2. I ruoli del giurista
18. Il diritto da Augusto al Theodosianus 468
quella dell’insegnante e quella del pratico, la più solenne, che più
l’avvicina al ruolo che aveva avuto in età repubblicana, è la prima,
quella dell’esperto autorevole che offre gratuitamente responsi ai
concittadini che gli sottopongono i loro casi. Tuttavia, anche sull’ufficio
della consulenza giuridica, sul respondere, si stese subito l’ombra
del nuovo regime, nel senso che i giuristi, a partire da Augusto, furono
presi sotto l’ala del princeps di turno, che concedeva (solo) ad alcuni
il publice respondendi ius, cioè il diritto di dare responsi al pubblico
(publice qui equivale a populo: cfr. Pomponio, D. 1.2.2.48 e 50).
Questa prerogativa, concessa spontaneamente da Augusto e Tiberio
e poi elargita come un beneficio a richiesta degli interessati, oltre a
imporre loro di rilasciare i responsi per iscritto e sigillati, doveva
comportare alcune facilitazioni materiali, forse anche un pubblico ritrovo
(statio) ove fare professione. Tuttavia, l’effetto principale del
publice respondendi ius era di aggiungere all’autorità personale del
giurista il sostegno del favore imperiale. Si creava così, fra l’altro, all’interno
dei cultori della giurisprudenza, una élite di giuristi “ufficiali”,
che rispondevano al pubblico appunto ex auctoritate principis,
distinti dalla restante massa. Con Adriano, addirittura, questo incremento
d’autorità si tradusse in efficacia giuridica dei responsa emessi
dai giuristi autorizzati. Infatti, un rescritto (vd. § 18.6) di questo princeps
dichiara che se su una data questione coincidono le opinioni di
tutti i giuristi «ai quali è stato accordato di creare norme giuridiche» –
locuzione, questa, per la verità ambigua, ma che viene di solito intesa
come allusiva proprio ai giuristi muniti di publice respondendi ius –
«ciò su cui le opinioni coincidono possiede valore di legge; se invece
hanno opinioni diverse, al giudice è lecito seguire l’opinione che voglia
» (Gaio, Institutiones, 1.7, da confrontare con il passo parallelo
delle Institutiones di Giustiniano, 1.2.8). Ovviamente, come contropartita,
rilasciare o negare il privilegio di publice respondere equivaleva
a sottoporre ad un gradimento politico un’attività che, almeno
nei due secoli anteriori, era stata invece libera, fondata non su una
patente d’ufficialità, ma solo sulla «fiducia nella propria preparazione
» di chi si offriva a dare responsi (il paragone fra i due diversi sistemi
è già in Pomponio, D. 1.2.2.49). Tuttavia, questo gradimento non
implica necessariamente che i contenuti tecnici dei responsi ne abbiano
risentito; come si vedrà, esso influì piuttosto sul profilo sociologico
del ceto dei giuristi.
Oltre che attraverso il publice respondendi ius, il mutamento costituzionale
ebbe un altro contraccolpo sul ruolo di consulente. Nel
corso del principato, al più tardi con Adriano, si affermò la prassi di
Il giurista
consulente
e il publice
respondendi
ius
Responsi
dei giuristi
e rescritti
dei principi
1.3. Drammaturgia 469
cittadini e sudditi di ogni parte dell’impero di sottoporre i propri quesiti,
invece che ai giuristi, direttamente al princeps, il quale, per lo
più, rispondeva loro per iscritto, ossia mediante rescripta (vd. § 18.6).
Ciò non comportò, tuttavia, la scomparsa della funzione respondente
dei giuristi (muniti o privi del diritto di farlo publice). Infatti, a differenza
di quel che a lungo s’era ritenuto, si sa ora che i giuristi continuarono
a svolgere l’ufficio di consulenza almeno fino al V secolo,
sia in Occidente sia in Oriente (vd. § 18.6). Si può parlare, dunque,
della consulenza privata come d’una costante dell’esperienza giuridica
romana, che perdura anche nella tarda antichità. Più che avvicendarsi,
responsa dei giuristi e rescripta dei principes, pertanto, coesistettero.
È significativo che nel 239, quando ormai si stavano
spegnendo anche gli ultimi fuochi dell’ispirazione letteraria dei
giuristi, l’imperatore Gordiano III invii un rescritto a un cittadino che
aveva già rivolto il medesimo quesito – e non ne faceva mistero – al
giurista Erennio Modestino. A conferma della intercambiabilità, si
può aggiungere che la doppia interrogazione non può essere stata
motivata dalla difficoltà della questione in gioco, che, anzi, appare
addirittura banale ed ottenne non a caso dal giurista e dal principe
identica risposta (CI. 3.42.5). Resta, tuttavia, evidente che l’autorità
d’un rescritto imperiale avrebbe comunque prevalso sulla risposta
difforme d’un giurista e ciò non poteva che subordinare ulteriormente
i giuristi al principe, che faceva loro concorrenza direttamente nel
campo nel quale avevano costruito e mantenuto il loro secolare primato.
Inoltre, come meglio vedremo (vd. § 18.4), per far fronte alla
crescente massa di quesiti che venivano loro sottoposti, i principi, già
nel corso del II secolo, dovettero assorbire nei ranghi dei propri uffici
un notevole numero di giuristi, spesso anzi i migliori, indebolendo
ulteriormente la libera professione.
18.3. La trasmissione del sapere scientifico
19.
LA RELIGIONE
NEL MONDO ROMANO
19.1. PER UNA CRITICA DELLE FONTI
Questo capitolo non è un elenco, più o meno ragionato e critico, degli
dei del pantheon romano e riconosciuti tali dallo stato, con annesse
funzioni. A partire specialmente dal volume fondamentale di
Georg Wissowa sulla religione e sul culto dei Romani, noi disponiamo
di strumenti di primo piano in materia (vd. Bibliografia). «Però, lo
scopo di un lavoro storico non è semplicemente quello di riversare la
conoscenza accumulata. Un lavoro storico dovrebbe essere, piuttosto,
un fermento che stimoli il ragionamento personale del lettore»
(Bickerman 1988, p. IX). Forti di questa dichiarazione di metodo, tenteremo
di suggerire alcuni spunti di interpretazione della religione
romana. Lo scopo unitario di questa esposizione è quello di dare una
delle possibili risposte alla domanda che riesce più spontanea, qualora
si affronti il tema di una religione di oltre duemila anni fa: è possibile
ricostruire, dopo tanti secoli trascorsi, frammenti di identità del
sentimento religioso antico? Come è ovvio, ci limiteremo a produrre
alcuni esempi che sono sembrati significativi; senza pretese (assurde)
di esaustività.
Mettere anche in guardia dagli inevitabili fraintendimenti e anacronismi
delle moderne ricostruzioni rientra nel novero delle considerazioni
propedeutiche alla religione romana. Infatti, senza una
preliminare analisi critica delle fonti antiche che ci hanno conservato
compiuto ricordo della religione romana, noi corriamo il rischio di
sottovalutarne alcuni aspetti che, pure, dovevano essere centrali alla
riflessione e all’esperienza contemporanee. Per usare un esempio
classico: Varrone, citato da Agostino, è fonte canonica e indispensabile
per la comprensione dell’antica religione romana. Noi, però, nell’impiegarla,
non dovremmo fare come Agostino che attualizza un’o-
Scopo
della ricerca
Varrone
19. La religione nel mondo romano 536
pera, le Antiquitates rerum divinarum, pubblicata circa quattro secoli
e mezzo prima del De civitate Dei; proprio come se Varrone fosse
un suo contemporaneo. Le circostanze che hanno portato il Santo a
utilizzare un’opera così arcaica per i suoi tempi non sono del tutto
comprensibili.
Quello che appare sicuro è che in cinque secoli la religione romana
non poteva non essere mutata. Le speculazioni di Pietro Bembo
sopra la lingua possono essere considerate testimonianza attuale
da chi ai nostri giorni voglia riprenderne la questione? L’opera di Varrone,
anteriore di quattro secoli e mezzo circa, non è solo collocata
dal Santo a fronte di una temperie storica e culturale cristiana estranea
del tutto alla sua origine e formazione, e non è solo, di conseguenza,
misurata secondo i parametri e i valori istituiti dal cristianesimo
e dal suo sviluppo (ai tempi in cui Agostino vive) oramai secolare.
Anche se riusciamo ad esaminare in sé il valore della testimonianza
di Varrone, depurandola, per così dire, dalle osservazioni di Agostino,
deve rimanere dubbio che l’analisi erudita (quale doveva essere
quella di Varrone) sappia cogliere la complessità, l’articolazione e
la varietà del sentimento religioso vissuto nella vita reale e quotidiana
e non nel mondo dei dotti e dell’accademia.
Ad esempio, i sincretismi, che probabilmente pullulavano nello
scritto di Varrone e, comunque, pullulano nei frammenti conservati,
appartengono al mondo dei dotti. Erano grammatici e filosofi a disputare
se Vacuna potesse essere identificata con Vittoria, Cerere, Minerva
o Diana (F 1 Cardauns). Il fedele, però, che prega e adora le
divinità, si sarà posto con distacco questi interrogativi. Inoltre, come
se Varrone fosse suo contemporaneo, Agostino colloca e sente le sue
affermazioni sopra la presunta ignoranza della religione patria sullo
sfondo della progressiva affermazione del cristianesimo. Questa circostanza
può indebolire e offuscare una lettura critica dei frammenti
delle Antiquitates rerum divinarum. Leggiamo il frammento introduttivo
citato da Agostino: «egli (i.e. Varrone) diceva di temere che gli
dei perissero non per un’aggressione nemica, ma per la negligenza
dei concittadini; dalla quale egli dice che essi sono da lui liberati
come da una frana e che essi per la memoria dei buoni, per mezzo di
libri di questo genere, sono riposti e conservati con una cura più utile
di quella con cui si celebra la liberazione, da parte di Metello, dei sacra
vestalia o la liberazione dall’eccidio troiano dei penati da parte di
Enea» (F 2a Cardauns). Lo spirito di questa parafrasi agostiniana del
pensiero di Varrone, unito in specie alle accorate e ripetute professioni
di pessimismo di un Cicerone, ha finito per risultare influente,
537
se non decisivo, sulla costituzione di un cliché fisso sulla religione
romana e sul suo “stato di salute”.
Dovremmo distinguere, però, le preoccupazioni apologetiche di
Agostino, formulate dopo il sacco di Roma da parte di Alarico (410
d.C.), da quelle di una parte della classe dirigente romana formulate
nella metà del I secolo a.C. e sollecitate, forse, dal sommo pontificato
di Gaio Giulio Cesare (come è noto, l’opera di Varrone, da cui il Santo
attinge, era dedicata a Cesare, pontefice massimo). Un’esigenza
specifica e contingente, avvertita da una parte della classe dirigente
romana verso la fine della repubblica, non può assurgere a canone
fisso di interpretazione storica di un fenomeno millenario quale è
quello della religione cosiddetta politeista del mondo romano. Inoltre,
l’ignoranza delle risalenze dotte delle divinità non significa in sé
attenuazione o addirittura cancellazione del sentimento religioso tradizionale.
Tanto più che il risvolto patriottico della religione romana,
così solennemente enfatizzato nel libro secondo del De natura deorum
e del De legibus di Cicerone, non riesce a esaurirne la complessa
identità; ad esso era particolarmente sensibile, però, quella cerchia
della classe dirigente la quale, specialmente negli anni quaranta a.C.,
agitava, contro lo spauracchio del lassismo e dell’anarchia degli
“epicurei”, le religioni e la restaurazione del sentimento religioso tradizionale,
intesi come cemento di una nuova coesione della compagine
civica: si sentenziava con amarezza che la repubblica fosse andata
perduta anche perché si erano perduti gli dei.
Il progetto ciceroniano di rifondare la costituzione romana prendeva
l’avvio dalle leges de religione. Noi abbiamo conservati dalla tradizione
gli echi di questa concezione aristocratica ed elitaria del sentimento
religioso e delle sue motivazioni e giustificazioni. Essa però
non avrà rappresentato che in parte l’identità del più diffuso sentimento
religioso.
Dalle parole introduttive di Varrone, sopra riportate e tramandate
da Agostino, dipende in buona misura anche la nostra enfasi sul cosiddetto
aspetto utilitaristico, formalistico e ritualistico della religione
romana. Ad esempio, dai frammenti citati dal Santo apprendiamo che
Varrone ammoniva che «non giova a niente sapere che esiste il dio
Esculapio, se poi non sai che egli aiuta la buona salute e, così, non
sai perché tu debba supplicarlo». Questa affermazione di Varrone
sembra essere tanto pertinente e rappresentativa del sentimento religioso
corrente quanto quella di chi, ai nostri giorni, sostenga che,
prima di pregare Nostra Signora di Lourdes, sia necessario informarsi
da un prontuario in che cosa possa aiutarci. Con difficoltà immaginia-
Aspetto
utilitaristico
19.1. Per una critica delle fonti
19. La religione nel mondo romano 538
mo che l’affermazione di principio di Varrone, «essere così utile la conoscenza
degli dei, qualora si sappia quale potenza e facoltà e potestà
abbia ciascun dio di ciascuna cosa» (F 3 Cardauns), rispecchi il
sentimento religioso comune; essa sarà venuta incontro, piuttosto, a
un piano di risistemazione erudita e antiquaria delle istituzioni sacre
romane. Come dice Cicerone con enfasi: «Infatti i tuoi libri ricondussero
come a casa noi che peregrinavamo nella nostra città e vi
andavamo errando come ospiti, così che potessimo finalmente conoscere
chi siamo e dove siamo. Tu hai svelato l’età della patria, i computi
delle età, i diritti dei sacra, quelli dei sacerdoti, la scienza in pace
e in guerra, la sede delle regiones, dei luoghi, tu i nomi, i generi, le
funzioni, le cause di tutte le cose divine e umane» (T 1 Cardauns).
Questa ispirazione generale dell’opera di Varrone ha enfatizzato
e cristallizzato, nelle nostre analisi, l’aspetto contrattualistico e utilitaristico
delle relazioni del romano con la divinità. Tale aspetto, però,
più che per essere rappresentativo del sentimento religioso corrente,
è sottolineato come antidoto a una diversa concezione della religione;
una concezione che desta preoccupazioni: esso ha la prevalente
funzione di porre argini alla forza dirompente della “superstizione”,
cioè il terrore inconsulto del soprannaturale. Questo appare essere il
leitmotiv di opere contemporanee a quella di Varrone (ad esempio, il
trattato De divinatione di Cicerone, come pure il De rerum natura di
Lucrezio). Certamente, le leges arae delle nostre iscrizioni (ad esempio,
la lex arae Iovis salonitanae: ed. Laffi 1980) suggeriscono minuziosi
rituali; essi, però, erano per “gli addetti ai lavori”. Mutatis
mutandis, postulare una religione ritualistica diffusa presso l’antico
romano da testi di questo genere sarebbe come postulare ai nostri
giorni la conoscenza minuta, da parte dell’uomo della strada, del cerimoniale
religioso sulla base della liturgia e dei rituali osservati dai
sacerdoti nelle chiese.
I frammenti dell’opera di Varrone sembrano auspicare che il senso
del soprannaturale e del trascendente sia moderato e ridotto a una
visione “utilitaristica”. Il fatto che Varrone valorizzi questo aspetto
delle religioni non significa di necessità che esso fosse diffuso. In tutti
i casi, il nostro autore non vuole ridestare un sentimento religioso
che sarebbe sopito, ma riportare alla luce conoscenze utili a un rapporto
con la divinità da lui giudicato più corretto e sano. In sostanza,
noi non dovremmo confondere la decadenza delle conoscenze con
quella del sentimento religioso. L’aspetto pedante e ritualistico della
religione romana, sottolineato da Agostino nella ricostruzione di
Varrone, non può essere elevato a manifesto della religione romana.
539
Varrone si preoccupa «perché non facciamo come sono soliti fare i
mimi e finiamo per desiderare da Libero l’acqua e dalle Linfe il vino»
(F 3 Cardauns 1976). Egli doveva, prima di tutto, giustificare la sua
ricerca antiquaria, da qualunque fine e circostanza, più o meno contingenti,
fosse stata suscitata. Il grammatico reatino mostra di non accorgersi
che la gente prega e invoca la divinità anche – e soprattutto –
perché non ne conosce i poteri al dettaglio.
|
|
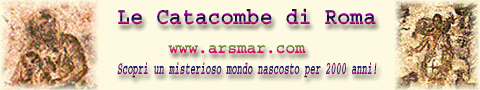
|
|
|
|
|
 | |