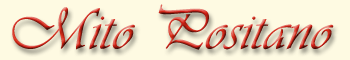7.1 Nel 1859 la Banca aveva due sedi, Genova e Torino, e cinque
succursali: Alessandria, Cagliari, Cuneo, Nizza e Vercelli. Quell’anno, già
prima che gli austriaci fossero battuti da Napoleone III, il capitale
sociale
venne portato a 80 milioni, in modo da concederne un quinto al padronato
lombardo[1]. I trentamila caduti a Solferino e San Martino erano ancora
insepolti, quando fu istituita la sede di Milano. La minaccia del dissesto,
conseguente al run dei possessori di banconote, si dissolse fra i vapori
agostani della Palude Padana, mercé l’oro che i lombardi portarono in dote.
Non so se Wagner si sia mai interessato alle banche, certo è che il dilagare
della Banca Nazionale per le cento città d’Italia ricorda l’impeto
incalzante de
La cavalcata delle Valchirie. Bombrini corse più veloce dei bersaglieri. Tra
il
giugno del 1859 e il settembre 1860 venne praticamente realizzata
l’occupazione dell’Emilia, delle Romagne, dell’Umbria, delle Marche.
Crollate
anche le Due Sicilie, furono immediatamente istituite altre due sedi, Napoli
e
Palermo. Ma non la Toscana.
Nel 1860, Bombrini inaugurò succursali ad Ancona, Bergamo, Bologna,
Brescia, Como, Messina, Modena, Parma, Perugia, Porto Maurizio (l’attuale
Imperia) e Ravenna;
nel 1862 s’insediò a Catania, Cremona, Ferrara, Forlì, Pavia, Piacenza,
Reggio Calabria e Sassari;
nel 1863 a Bari e Chieti;
nel 1864 all’Aquila, Catanzaro, Foggia, Lecce e Savona.
Nel 1865, i toscani scesero a patti, cosicché Bombrini poté aprire la sede
di
Firenze. Quell’anno inaugurò succursali anche ad Ascoli Piceno, Carrara,
Lodi,
Macerata, Pesaro, Reggio Emilia, Siracusa e Vigevano.
Nel 1866 s’insediò a Caltanissetta, Cosenza, Girgenti (Agrigento), Novara,
Salerno, Teramo e Trapani.
Nel 1867, acquisito il Veneto ai Savoia, comprò una banca veneziana e la
trasformò nella propria sede di Venezia. Aprì inoltre le succursali di
Padova,
Mantova, Udine e Verona. Al Sud inaugurò la succursale di Avellino. La
penetrazione locale proseguì dopo l’annessione di Roma (1870).
Una diffusione così ampia, ad opera di una banca privata, che si era messa
in campagna con appena cinque milioni d’oro in cassa, si spiega soltanto con
la fanfara dei bersaglieri. Questa espansione privata, e tuttavia munita del
sigillo dello Stato, fu una cosa da Compagnia delle Indie, indegna di un
Regno
che si autoproclamava fondato sulla volontà della nazione, oltre che sulla
grazia di Dio. Evidentemente in quel momento il Sud era coperto di nubi e
sfuggiva alla vista e alla grazia di Dio! Per giunta, la consorteria
cavourbombrinesca
inchiodò al remo gli altri istituti di credito esistenti, alcuni dei
quali - sicuramente il Banco delle Due Sicilie e la Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde – avrebbero potuto fare d’essa un solo boccone. Persino
l’accomodante Di Nardi è costretto ad ammettere che
"l'espansione [della Banca Nazionale] non avvenne senza contrasti e
difficoltà. Negli antichi Stati italiani esistevano altre banche […] e
potenti istituti
di credito radicati nella tradizione locale, che mal volentieri vedevano
l'insediamento nelle loro città di un istituto concorrente, che sembrava
[sic,
zucchero patriottico!, ndr] godesse appoggi e protezioni del governo. Alcune
di
quelle banche alzarono bandiera bianca davanti alla rivale piemontese, convinte di non
poter
reggere a lungo alla lotta con essa sulle stesse piazze. Fu il caso della
Banca
Parmense e della Banca delle Quattro Legazioni a Bologna, entrambe [da poco,
ndr] autorizzate all'emissione di biglietti, che concordarono presto la loro
fusione con la Banca Nazionale, per cui già nel marzo 1861 le rispettive
sedi
erano trasformate in succursali della Banca Nazionale. Atteggiamento di
resistenza assunsero invece la Banca Nazionale Toscana ed i banchi
meridionali. A Firenze la Banca Nazionale ci andò solo nel 1865, quando la
sede del governo sì trasferì nella capitale toscana. Nelle provincie
meridionali si
insediò più presto, ma dovè vincere forti resistenze locali e procedè con
ritardo
nella fondazione di alcune succursali, per le precarie condizioni
dell'ordine
pubblico in quelle provincie, che per alcuni anni furono infestate dal
brigantaggio borbonico" (Di Nardi, pag. 46 e sgg.)[2].
Come annotato da Di Nardi nel passo riportato, la Banca Nazionale entrò in
Toscana soltanto nel 1865, cioè sette anni dopo l’annessione del Granducato,
insieme al re, al governo e al parlamento, allorché la capitale d’Italia
venne
trasferita da Torino a Firenze. La città dei Bardi e de’ Medici fu l’ultima
e
sofferta conquista di Bombrini prima della terza guerra cosiddetta
d’indipendenza e della conquista del Veneto. In precedenza i toscani, avendo
capito tutto, non avevano permesso che aprisse una delle sue prosciuganti
sedi nella loro capitale e delle succursali nelle loro città, insofferenti
di
dominio forestiero. I banchieri toscani erano consapevoli che per loro
sarebbe
stato impossibile resistere all’aggressione di un concorrente ammanicato con
lo Stato, perciò si difesero sul terreno politico. Gli storici patrii non
sono
riusciti a tenere nascosto il contrasto tra toscani e piemontesi. E’ persino
divertente il visibile affanno per cercare di addolcirlo con parole
melliflue. Non
si possono offendere i toscani, perché nessuno in Italia è più italiano dei
toscani, ma neppure si può dire male dei piemontesi, essendo essi i padri
della patria. Tuttavia fra le contorsioni lessicali, emerge chiaramente che
qualcuno, capace di imporre la sua volontà persino al colendissimo e
venerato
Cavour, vietò a Bombrini di calcare una terra rinascimentale, sacra a ogni
forma di usura. E all’usura come opera d’arte.
Infatti la Toscana, fra tante primogeniture, vanta quella d’aver tenuto a
battesimo la banca moderna. Tuttavia, spenti gli antichi splendori, una sua
banca d’emissione era arrivata ad averla soltanto nel 1858: la Banca
Nazionale Toscana, che era il prodotto della fusione tra la Banca di Sconto
di
Firenze e la Banca di Livorno. Plebano e Sanguinetti, gli storici di cose
finanziare più accreditati dell’epoca, considerano la Nazionale Toscana una
copia della Nazionale Sarda (pag. 114), che l’aveva preceduta di un buon
decennio. Si tratta di un giudizio che mi appare tarato di sabaudismo, in
quanto sorvola sul fatto che i biglietti della Banca Toscana erano garantiti
dallo Stato, allo stesso modo delle fedi di credito duosiciliane; cosa che
non è
di poco conto, se si ha presente la funzione sociale e politica della dalla
Banca ligure-piemontese, consistente nel drenaggio del circolante metallico.
Qualche anno dopo la morte di Cavour, si mise a fare la ruota del gran
ministro delle finanze il napoletano Giovanni Manna, uno dei tanti utili
idioti
che il sistema padano andava mobilitando al suo servizio. E’ probabile che
alquanto ingenuamente questi considerasse l’Italia-una una specie di Tavola
Rotonda di tutti gli italiani, cosicché immaginò di poter creare un istituto
unico
d’emissione, più o meno controllato dal padronato di tutte le regioni.
Ovviamente Bombrini, sulle idee dei ministri, specialmente se napoletani, ci
faceva la pipì. D’altra parte, piegata la Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, non aveva altro avversario degno d’essere veramente temuto se
non il Banco delle Due Sicilie, al cui confronto la Banca Toscana era un
ringhioso botoletto aizzato da Ricasoli e dal suo avido contorno. I giochi
di
Bombrini ormai erano fatti: Firenze si sarebbe data per amore o per altro, e
Napoli, prima o poi, si sarebbe arresa per fame. Comunque, alle insistenze
del
ministro Manna il governatore della Nazionale non poté opporre un aperto
rifiuto. Fu così che tra la Banca Nazionale ex sarda e la Banca Nazionale
Tosacana si arrivò a un reclamizzato accordo. Manna portò in senato il
disegno di legge governativo. Dopo lunghe e ampollose discussioni, il senato
lo approvò, ma, quando passò alla camera, questa lo lasciò dormire fra le
altre scartoffie, finché non sopraggiunse la scadenza della legislatura.
In apparenza, sia alla camera sia al senato, la maggioranza era contraria
alle bramosie della Banca Nazionale; nella sostanza era Bombrini a
fomentarle
perché si perdesse tempo, in attesa che la Banca Toscana gli cadesse in
grembo come una pera matura. Bombrini voleva mangiare, e non accordarsi
sul menù. Tra attacchi e resistenze, la partita tra Juventus e Fiorentina si
protrasse dal 1859 al 1865 - cioè un incalcolabile numero di tempi
supplementari. Alla fine la cosa ebbe la sua naturale conclusione: il
governo,
spostando la capitale del Regno da Torino a Firenze, pretese che la sede
centrale della Banca bombrinesca (che era sempre una banca privata) lo
seguisse nella nuova capitale. Bombrini assorbì la Banca Toscana in cambio
di
15 milioni di azioni della Banca sarda: 10 a copertura del capitale sociale
e 5
come regalia, per tappare la bocca ai verbosi discendenti di Savonarola.
7.2 Il grande ministro, che aveva fatto il possibile per fare di Bombrini un
uomo del tesoro (o forse al contrario, il tesoro una cosa di Bombrini),
prima
ancora che i bersaglieri mettessero piede a Napoli, onde prendere il posto
delle camicie rosse, ordinò al luogotenente del re sedente a Napoli di
prendere possesso del Banco (che raccoglieva ben 50.000 ducati, pari a 212,5
milioni di lire sabaude) per conto del tesoro torinese. Ma pochi mesi dopo
esso venne emancipato dalla diretta dipendenza al nuovo re. In base al
decreto 6 novembre 1860, divenne un’istituzione pubblica (nominalmente)
autonoma. Rimase, cioè una banca di diritto pubblico[3], in teoria autonoma,
in pratica sottoposta alla direzione politica del governo. Stessa sorte
toccò alla
sezione siciliana del Banco delle Due Sicilie, che si fondava su due casse
di
sconto autonome, Palermo e Messina. Il Banco di Sicilia ebbe
un’incardinazione formale e pratica identica a quella del Banco di Napoli.
Nonostante Francesco II avesse attinto con pochi riguardi alle riserve
metalliche, per condurre la guerra contro i garibaldini, nel 1860 il Banco
aveva
ancora, nelle sue casse, argento e oro quaranta volte che la Banca
Nazionale.
Ovviamente una persona di indole fortemente venale non poteva
disinteressarsi al malloppo, cosicché, appena le inclemenze stagionali gli
permisero un viaggio per mare, Bombrini s’imbarcò a Genova (non è da
escludere che lo facesse su una fregata del defunto Regno delle Due Sicilie,
più
grande e sicura) e sbarcò a Napoli, dove l’ordine pubblico era saldamente in
mano alla patriottica e garibaldina camorra. Siamo nell’autunno 1860. Il
vittorioso Vittorio ha appena varcato il confine del Tronto. A Napoli
Bombrini
incontrò i membri del governo luogotenenziale, per spiegare loro che in alto
si
era convinti che la conquista di Napoli non poteva fermarsi alle sciabole. I
patriottici (sotto)-ministri annuirono. Il suo progetto fu fatuo e
civettuolo.
Prevedeva l’incorporazione del Banco e l’apertura a Napoli di una sede allo
stesso livello di quella milanese. Per far posto ai 200 milioni che Napoli
avrebbe
portato in dote (ai suoi 80 milioni), si dichiarò disposto a un aumentato
del capitale
sociale fino a 100 milioni (proprio così!). Una parte delle nuove azioni
sarebbe stata attribuita ai vecchi azionisti della Nazionale e un’altra –
dodici
milioni e spiccioli - assegnata a napoletani e siculi commisti. Come si vede
Bombrini, mercé la mancia di una banca che aveva cinque volte il giro
d’affari
della sua, concedeva ai fratelli d’Italia lussuose quote di larga minoranza
e
l’ambito onore di lustrargli le scarpe. Ahi, Genovesi, maestri d’ogni
magagna.
Ciliegina finale, il progetto comportava la fine dei banchi meridionali, che
sarebbero stati assorbiti e messi in liquidazione dalla Nazionale. Lo Stato
avrebbe dovuto garantire le passività pregresse e pagare gli interessi.
Colpo
scuro: “La Banca Nazionale si offriva di assumere, gratuitamente, il
servizio di Tesoreria del governo, come praticava attualmente il Banco
di Napoli” (ibidem).
Difficile essere più generosi. Come si sa, i napoletani chiacchierano. Non
sanno tenere un segreto. E poi quelli di un tempo – forse – non erano tanto
fessi quanto i loro posteri. E neppure sempre disinformati. Qualche notizia
circa i pregi di Bombrini doveva pur essere arrivata, o per mare, dalla non
lontana Livorno, o dalla Sardegna, o forse del tutto da Genova, o da Milano,
attraverso gli aspri sentieri appenninici. Sta di fatto che si spaventarono.
Se,
in materia di sciabole, quelle piemontesi andavano bene, perché ricacciavano
in gola ai contadini le loro pretese, in materia di soldi i napoletani
preferivano
far da sé. Bombrini era certamente una persona simpatica quando raccontava
barzellette, ma quando entravano in ballo le palanche i suo baffi si
rizzavano
come quelli del gatto che sente il topo.
Poco patriotticamente, l’accordo non fu raggiunto. Il Banco continuò la sua
strada e la Nazionale aprì una sua sede/tesoreria anche a Napoli per
incettare
l’argento con cui venivano pagate le tasse e per distribuire biglietti nei
pagamenti che faceva per conto del governo della nobilissima Torino.
7.3 Domenico Demarco**, che ha il merito di aver esaminato per i molti
decenni della sua attività professionale gli archivi del Banco di Napoli e
di aver
ricostruito, con dovizia di particolari, la lunga storia dei banchi pubblici
napoletani, ha anche riscoperto una vicenda napoletana che non riguarda il
Banco. L’avvocato Antonio Scialoja, ex professore di economia politica a
Torino[4] e deputato subalpino, ma napoletano di origine e di rimpatrio,
proprio a ridosso del viaggio napoletano di Bombrini, scrisse a Cavour:
[Conforti, il direttore del ministero delle finanze del governo
luogotenenziale
a Napoli] «venne in mia casa, accompagnato ad un comune amico, per
dimandarmi se io approvava che il Governo concedesse a taluno, che facevane
dimanda, la facoltà di stabilire in Napoli una Banca di Circolazione e di
Sconto.
Io risposi francamente che queste concessioni generiche non mi parevano
lecite; e soggiunsi che la via da tenere si era quella di formare una
società,
stendere uno statuto, stipulare uno strumento, e quindi fare una dimanda di
autorizzazione. Il Conforti e l’amico si convinsero della giustizia delle
mie
osservazioni; ed una lettera del primo al Dittatore (la quale è ora nella
pratica)
prova che egli secondò il disegno da me suggerito, schivando la concessione
a
priori, che sarebbe stato un privilegio esorbitante. Il fatto sta che la
proposizione era in realità assai più che io non credeva. Dopo qualche
giorno fui pregato a nome di rispettabili commercianti di consigliarli […]
intorno
alla compilazione degli statuti. Comunicai loro quelli della Banca
nazionale, e
quando li ebbero in massima adottati, mi restrinsi a consigliarli
d’introdurre
qualche modificazione accessoria per migliorarli, e la riserva di aprire
sedi alle
altre Banche italiane e fare accordi per lo mutuo scambio de’ biglietti. Le
condizioni locali del paese motivarono qualche aggiunta agli statuti di
cotesta
Banca. Fin d’allora però richiamai l’attenzione di que’ Signori sulle
difficoltà di
accordare la fondazione di una Banca privata, colla nostra Banca governativa
(il Banco di Napoli, ndr.) e colla cassa di sconto (dello stesso, ndr), che
ora è
pure del Governo. Le quali due istituzioni, quantunque condannate a perire,
non può negarsi che per ora rendono importanti servigi, e fanno parte della
macchina nostra finanziaria. In ogni modo quattro o cinque case, tra cui una
o
due delle principali del paese, e tra queste specialmente una casa che non
aveva mai versato in imprese arrischiate, il che mi pareva di buono augurio,
stipularono uno strumento per la fondazione della Banca con sei milioni di
ducati di capitale [in lire, più di 25 milioni, ndr], prendendo esse un
terzo di
azioni, riserbandone un terzo per collocarlo nella rimanente Italia, presso
case
o istituzioni di credito, e un terzo per via di sottoscrizione, con obbligo
di
prendere esse medesime le azioni che non si collocassero altrimenti. Questo
istrumento fu presentato al Ministero Dittatoriale per l’approvazione. Ma il
Ministero si sciolse prima d’impartirla. Frattanto corse voce che la Banca
nazionale aveva da Lei (Cavour, ndr) ottenuto formale promessa di estendere
a Napoli una succursale. Bastò questa voce perché le altre case che prima
non avevano sottoscritto, dimandassero di apporre al contratto la loro
sottoscrizione. [La paura faceva 90! ndr] Di maniera che può affermarsi che
oggi sono sottoscritte a quel contratto tutte le case più importanti di
questa
città, sieno del paese o straniere, e le minori vi hanno anche preso
interesse»
(citato da Demarco**, pag. 142, nota).
Aggiunge Demarco (ibidem):
“L’idea di creare un nuovo istituto bancario era stata agitata, a Napoli,
subito
dopo la caduta dei Borboni, proprio dal ceto commerciale della città. Ed
esso
mostrava preferenza per la creazione di un istituto indipendente, per una
Banca Napolitana […] fin dal novembre del 1860, promotori alcuni banchieri e
commercianti meridionali, si era costituita una società anonima per la
creazione, in Napoli, di una « Banca indipendente di circolazione e di
credito,
con capitali propri, e diretta da uomini noti al paese e conoscitori delle
sue
condizioni e bisogni », che aveva presto raccolto il vistoso capitale di sei
milioni
di ducati, e presentato la domanda di autorizzazione e lo statuto al.
governo
luogotenenziale”.
Sicuramente Bombrini avvertì l’iniziativa come una pugnalata al fianco.
Mentre prima - al tempo in cui Cavour era favorevole alla banca unica
d’emissione - aveva difeso l’autonomia della sua impresa privata, adesso,
siccome voleva tutto, si era trasformato in un assertore della banca unica
d’emissione. A tal riguardo scriveva: «I disordini monetari e commerciali,
che
troppo di frequente si ripetono e che sconcertano anche attualmente gli
Stati
Uniti, ove le banche e i biglietti possono moltiplicarsi all’infinito, non
sembrano possibili in Francia e in Inghilterra ove una sola banca, ricca di
forze materiali e di fiducia, non è mai soverchiata dagli avvenimenti, e
trova
sempre in sé vigore bastante a dominare la situazione » (citato da
Demarco**, pag 144).
Tutto giusto. Il fatto è che, nelle sue idee, la banca unica, soltanto lui
“poteva” farla, in prosecuzione di quella che già aveva. Anche se i libri di
storia sorvolano sull’argomento, in realtà Bombrini si sentiva un
bersagliere
vittorioso, come Lamarmora, e agiva da padrone allo stesso modo del
patriottico generale e dei suoi eroici sciabolatori. La vittoria gli
conferiva larghi
diritti, in primis l’arricchimento in esclusiva. La situazione creatasi a
Napoli
metteva sul chi vive i politici. Un cavourrista DOC, Costantino Nigra,
inviato
da Cavour a Napoli nel vano tentativo di mettere fine alla buriana
inaugurata
da borbonici traditori, fuorusciti rientrati, camorristi impiegati come
gendarmi, garibaldini fregati, mazziniani ricattati, sciabolatori sabaudi e
luogotenenti imbelli, relazionando a Cavour circa la pretesa della Nazionale
d’insediarsi a Napoli ebbe a scrivere “che una banca, la quale avesse
surrogato il Banco delle Due Sicilie, avrebbe trovato, nelle vecchie
consuetudini, non lievi difficoltà per accreditarsi, mentre la diffidenza
che
regnava verso il biglietto di banca, che sarebbe stato considerato carta
[senza alcun valore, ndr], poteva solo vincersi col tempo, e quando alla
testa
dell’istituto fossero stati preposti gli uomini più conosciuti della città
per
esperienza, probità e influenza finanziaria” (cit. in Demarco**, pag.
146). Più chiaro di così! D’altra parte solo un Nigra, intimo collaboratore
del
grande ministro nella presa per i fondelli di Napoleone III, poteva dire
papale
papale che i napoletani non avrebbero accolto con entusiasmo un bandito
come Bombrini né la sua banca, il cui fine risaputo consisteva nel depredare
il
prossimo.
Il progetto di una banca napolitana non ebbe seguito a causa di tre reazioni
convergenti: quella di Bombrini che aprì a Napoli uno sportello pomposamente
chiamato sede, benché mancante dei soldi occorrenti per operare
commercialmente su una piazza che era la più ricca nell’Italia del tempo;
quella dello stesso Banco, che intendeva continuare la sua vecchia attività
di
banca di deposito e di sconto; quella di Cavour, ormai padrone di Napoli,
che
ovviamente non autorizzò la richiesta.
Intanto la penetrazione della Banca Nazionale nel Napoletano e in Sicilia
incontrò seri ostacolati. Ne elenco quattro. Primo: mentre altrove il
numerario
esistente era stato rastrellato rapidamente, con la conseguenza che le
imprese,
volenti o nolenti, erano costrette a impiegare i biglietti della Nazionale,
nel
Meridione il numerario era ancora abbondante. Mancando la costrizione delle
cose a usare il biglietto piemontese, la gente lo rifiutava: gli preferiva
l’argento, dotato certamente di ben altra eloquenza. Secondo: il nuovo Stato
coniò monete in quantità insufficiente per sostituire i coni borbonici.
Terzo: il
governo di Torino, ispirandosi alla riserva mentale che le antiche monete
avrebbero dovuto essere cambiate con carta - e solo con carta della
Nazionale
- le lasciò in circolazione, riconoscendo ad esse potere liberatorio nei
pagamenti. Per cui la patriottica speranza che i napoletani si sarebbero
autospogliati del proprio danaro non ebbe corso. Quarto: anche se qualche
ingenuo poteva immaginare di ottenere lire oro in cambio di ducati, in
quella
fase avveniva che, a causa del maggiore afflusso d’oro di cui si è parlato,
il
rapporto di scambio fra oro e argento si era modificato a favore
dell’argento.
Chi aveva ducati, che di regola erano coniati in argento, ci lucrava sopra,
e non
solo nel cambio con la carta, ma anche nel cambio con le lire oro. Il
disegno
governativo di fregare i sudditi prosciugando l’argento in cambio di carta
ed
eccezionalmente di oro, ebbe buon corso nella Padana, ma non lo ebbe nelle
Due Sicilie. In pratica la coniazione delle moneta d’argento cessò. Le poche
coniazioni realizzate in questa fase furono in oro. Ciò creò disagi
dovunque,
persino nelle regioni ex sabaude. Ma nelle regioni ex duosiciliane i disagi
furono condivisi da Bombrini. Quantomeno gli resero faticoso realizzare il
suo
progetto. Le popolazioni difesero l’argento che avevano in mano, imponendo
un aggio tanto sulla cartamoneta quanto sull’oro monetato. D’altra parte,
dovunque in Italia, l’argento faceva aggio sull’oro e l’oro sul biglietto.
Al Sud, la
Banca Nazionale dovette piegarsi a un compromesso. Pur d’incassare i ducati,
Bombrini e i suoi soci liguri decisero di remunerare i depositi con un
interesse
del 2,5 per cento - una cosa che a quel tempo non rientrava nella pratica
corrente in alcuna regione italiana. Ciò nonostante il primo bilancio della
sede
napoletana della Nazionale si chiuse in perdita. In effetti solo la mano
violenta del governo nazionale avrebbe imposto l’italianità monetaria del
Sud.
“A distanza di un anno da quando la Banca Nazionale aveva aperto una
sede a Napoli, quali risultati aveva conseguiti? Non c’erano stati quei
progressi
che l’importanza della piazza poteva lasciare presumere, e le sue operazioni
erano « ben lontane » dal presentare quello stato soddisfacente sul quale si
aveva diritto di contare ad onta della introduzione del corso legale delle
monete d’oro”, commenta Demarco (**, pag. 146) citando il direttore della
sede napoletana della Nazionale. E prosegue:
“Il del Castillo poteva ripetere quanto aveva detto nel suo rapporto dell’11
gennaio [1862], circa le cause che ancora ostacolavano lo sviluppo della
Banca
Nazionale nelle provincie meridionali. L’esperienza, aggiungeva ora, aveva
provato la necessità di adottare una misura che assicurasse al paese uno
«stabilimento di credito serio e prospero», «mentre lasciando andar le cose
da
per loro si finirà per non ritirare nessun vantaggio né dalla Banca
Nazionale, né
dal Banco di [Napoli]». Se il Ministro non riteneva, per il momento,
opportuna
una soluzione radicale, egli chiedeva che si prendesse un «temperamento»,
che «la giustizia e l’interesse stesso dello Stato» richiedevano. E quale
doveva
essere questo temperamento? Richiamare il Banco di [Napoli] all’origine
della
sua istituzione, col vietargli le operazioni di sconto, e disporre che tutte
le
casse del governo, nonché quelle del Banco di [Napoli], fossero obbligate a
ricevere i biglietti della Banca Nazionale, come era avvenuto nelle altre
provincie del Regno. In realtà ecco che cosa accadeva. Mentre la fede di
credito era ricevuta da tutte le casse governative e dalla stessa Banca
Nazionale, il biglietto di quest’ultima era rifiutato e dalle casse
governative e
dal Banco di Napoli. Il biglietto della Banca Nazionale era quindi «ignorato
dai
più », o «in completo discredito», perché si riteneva che governo e banco
rifiutassero di accettarlo nelle loro casse, «per poca fiducia». L’esistenza
della Banca, senza la congiunta circolazione del biglietto è
«un’impossibilità»,
diceva il del Castillo, mentre ognuno rammenta che, con l’incalzare degli
avvenimenti del ‘59, una delle fonti, cui il governo si rivolse con maggiore
successo, fu la Banca Nazionale, rendendone forzoso il corso del biglietto.
Il
governo continuando ad operare in tal modo finiva per privarsi di una
risorsa.
Ma «non si trasformano d’un colpo le abitudini di un popolo, né si può
soddisfare a tutti i suoi bisogni con un’ordinanza del potere il meglio
assodato
e sicuro». «Cambiare violentemente non è moralizzare, ma perpetuare le idee
della violenza » (Il Commissario Governativo, del Castillo, al Ministro
dell’Agricoltura,
a Torino. Napoli, 25 ottobre 1862)”.
L’impotenza finanziaria ex sarda, quantunque accompagnata dalla forza
politica dello Stato, e la potenza finanziaria duosiciliana, benché
scompagnata
a una qualunque forza politica, resero dura e pesante la vita al governo
nelle
nuove province merdionali. Ciò convinse Bombrini - e lo Stato suo succubo -
a
piegarsi e a rimandare la cancellazione dei Banchi meridionali a un momento
più propizio. Dal canto suo, il ceto mercantile della città di Napoli, o
forse una
parte soltanto, cominciò machiavellicamente a ponderare l’idea di allearsi
con
un nemico che non aveva la forza di abbattere. Guidato credo
dall’industriale
Mauricoffe, tentò di salvare il salvabile buttandosi nelle braccia del
vincitore e
parteggiando per la Banca Nazionale. Ma, come vedremo, al punto in cui
giunse il rapporto Sud/Nord il gruppo dirigente del neo-Banco di Napoli
preferì
salvare sé stesso, anche se in posizione subordinata al governo nazionale e
servile degli interessi emersi nel paese padano.
7.4 Identica cosa avvenne in Sicilia.
“ Con decreto del 7 aprile 1843 il Governo borbonico estese alla Sicilia
l’apparato bancario napoletano istituendovi due Casse di corte, una a
Palermo e una a Messina, alle dipendenza della Reggenza del Banco delle
Due Sicilie avente sede a Napoli. In base all’atto sovrano del 2 settembre
1849 con cui fu stabilito che l’amministrazione civile, giudiziaria e
finanziaria
della Sicilia fosse ‹per sempre› separata da quella dei domini continentali,
la
due Casse di Corte siciliane furono rese indipendenti dal Banco napoletano e
costituirono un nuovo istituto che con decreto del 13 agosto1850 assunse la
denominazione di Banco regio dei reali dominii al di là del Faro e fu posto
alle dipendenze del Luogotenente generale in Sicilia” (Giuffida, pag. 6).
Il Banco siciliano funzionava allo stesso modo del Banco napoletano, cioè
accettava danaro in deposito, a fronte del quale rilasciava una fede di
credito,
commerciabile in Sicilia e nel Napoletano. Inoltre effettuava sconti
commerciali. Anche in questo caso si ha il raddoppio del danaro depositato,
e
per giunta nella forma elegante che già abbiamo segnalato. In più si ha un
aumento del circolante pari all’ammontare degli sconti effettuati. Caduta la
Sicilia in mano alle regioni toscopadane, alcuni banchieri e imprenditori
siciliani[5] chiesero e ottennero dal governo prodittatoriale (decreto del
18
ottobre 1860) di fondare un banco di emissione simile alla Banca Nazionale
del
Regno di Sardegna, che prese il nome di Banco di circolazione per la
Sicilia,
con sedi a Palermo, Messina e Catania. L’istituzione assunse (o avrebbe
dovuto assumere) la forma della società per azioni, con un capitale iniziale
di
sei milioni di lire sabaude. Naturalmente l’iniziativa morì appena
partorita. Da
una parte calò in Sicilia la Banca Nazionale sarda, dall’altra il Banco
borbonico
divenne il Banco di Sicilia. In merito all’aborto, il Trasselli[6] si è
posto alcune
domande:
«Perché il Banco di Circolazione non entrò mai in attività? forse perché i
promotori non riuscirono a collocare nei sei mesi previsti le 6.000 azioni?
o
perché il Governo italiano, dopo la breve parentesi dittatoriale e
prodittatoriale,
preferì mantenere in vita il decrepito Banco Regio? O perché, così come per
le
ferrovie, erano calati subito Adami e Lemmi, per i servizi bancari calò la
Banca
Nazionale, con le succursali in ogni capoluogo di provincia e con i suoi
privilegi?
[...]. Noi comprendiamo bene che in quel momento favorire il Banco di
Circolazione od anche soltanto lasciarlo vivere, avrebbe significato
annullare un
decennio di politica bancaria del Cavour [...]. Allora, tollerare una banca
siciliana avrebbe significato disfare sul piano bancario quell’unità che era
stata
faticosamente e non perfettamente raggiunta sul piano politico, un andar
contro quel corso storico pel quale da cinque secoli almeno le due Sicilie
erano
sotto il dominio finanziario ligure e toscano. Resta che l’unica grande
banca
moderna promossa in Sicilia, all’infuori delle banche locali e della Cassa
di
Risparmio, non venne realizzata. Frattura tra la borghesia siciliana e
quella
continentale? Questione meridionale? Purtroppo non sappiamo. [...]. Resta il
fatto che si presta a troppe interpretazioni diverse ». (Cfr. Premessa del
Trasselli a: M. Taccari, I Florio, Caltanissetta - Roma, 1967, pp. XXIX-XXX,
cit.
da Giuffrida, pag. 5).
Avendo seguito – debbo dire con grande amarezza - lo svolgimento della
doppiezza cavouriana e penetrato l’avida concezione che Bombrini ebbe a
proposito dell’Italia–una, sono ben lontano dal dubbio (forse soltanto
retorico)
che affligge lo stimato autore. Infatti Bombrini reagì sempre con grande
energia contro chi tentava di rubargli la greppia. Nella circostanza, egli
dichiarò
che non ci stava. In quanto vincitore e unificatore d’Italia, tutto quel che
poteva concedere ai napoletani e ai siciliani (i quali avevano una ventina
di
volte i suoi soldi) era una quota pari a meno di un sesto del capitale
sociale
della sua banca, 12,5 milioni su ottanta. E comunicò il diktat al
Luogotenente
palermitano. Tutto ovvio. Meno ovvio è che a Palermo, come a Napoli,
mercanti e banchieri - giunti a questo passaggio e intravista la faccia
truce di
quell’unità da loro inizialmente auspicata - si arrocchessero in difesa del
Banco
borbonico. Con il senno di poi, bisogna dire che si trattò di una scelta
oltremodo sbagliata. Orami il guaio l’avevano fatto, ergo: o disfacevano la
mala unità o stavano al gioco bombrinesco, nel tentativo d’inserirvisi con
vantaggio. La mezza misura, impersonata dai due banchi, non salvò l’economia
meridionale dal blocco coloniale, né salvò il loro capitalistico potere di
comandare lavoro.
In precedenza l’attività dei banchi meridionali era sottostata alla
direzione
politica del governo borbonico. Passati all’Italia-una, divennero dei corpi
senz’anima, mani dirette dal cervello di un’altra persona. All’inizio, i
napoletani
riuscirono a condizionare l’imperio padano. Ma più di questo non seppero
fare.
In Sicilia nemmeno a questo riuscirono. In generale il governo della Destra
non
riuscì a impedire (o almeno a nascondere) il conflitto tra il futuro
Triangolo
industriale e l’ex Granducato di Toscana, ma soffocò d’imperio tutti gli
altri
regionalismi, che l’opinione del tempo definì come municipalismo. In questa
fase fortemente repressiva di altri interessi che non fossero quelli
toscopdani,
la bussola che orientò l’azione dei banchi furono gli interessi della
burocrazia
interna, che si batté per conservare la mangiatoia per quanto magra essa
fosse. La condizione per rifornirla era costituita dalla possibilità di
continuare a
praticare lo sconto cambiario. Solo gli interessi attivi avrebbero
assicurato le
entrate necessarie a pagare gli stipendi e tenuto in vita gli istituti. Ma
la
difesa della greppia non può essere contrabbandata per amor di patria (o
meridionalismo), come accade presso certa storiografia. Storicamente, dopo
la
malaugurata unità, i banchi meridionali di meridionale o meridionalistico
ebbero soltanto la sede.
Spettava al governo accordare o negare l’invocata facoltà di praticare lo
sconto cambiario. Abilmente la manovra d’interdizione bombrinesca si
concretizzò proprio sulla negazione di tale facoltà. Michele Avitabile,
neodirettore
del Banco di Napoli, avendo capito finalmente di quale pasta erano
fatti gli uomini del nuovo Stato, nel 1863 si recò a Torino e incontrò i
ministri
competenti in materia bancaria, Giovanni Manna, napoletano, e Marco
Minghetti, toscopadano, convincendoli – dicono le storie patrie - che
l’economia
napolitana avrebbe potuto giovarsi grandemente dell’opera del Banco. Più
verosimilmente (è questa l’unica spiegazione logica) promise dei forti
acquisti
di cartelle del debito pubblico. Probabilmente aggiunse che la chiusura del
Banco avrebbe messo sul lastrico un congruo numero di illustri patrioti. I
ministri, convinti o meno, accordarono la vita al Banco.
Si tratta di un passaggio nodale nella storia del paese che, sotto i
Borbone,
era uno Stato con una sua inconfondibile identità, un paese autorevole e
rispettato, e che a partire dalla disfatta militare si chiama - copiando la
Francia - Meridione o Mezzogiorno, o copiando gli USA, il Sud; un paese
commiserato e effettivamente da commiserare. Similmente all’aristocrazia che
l’aveva preceduta nel dominio etico-poltico del paese, la parte seduta della
borghesia meridionale[7], pur di salvare sé stessa, svendette il proprio
popolo.
L’invereconda morale mostrò al padronato toscopadano attonito[8] il pertugio
(o se preferite, l’alleato, o l’ascaro) attraverso cui passare per
ilotizzare le
popolazioni meridionali. Il Banco, che era stato un’efficiente istituzione
cittadina in mano ai Borboni, una volta italianamente santificato, divenne
il
mostro che ha oberato la vita economica delle popolazioni meridionali per
più
di 100 anni.
Postesi le regioni del futuro Triangolo industriale a baricentro della vita
dell’assurda nazione, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia ebbero
l’identica
funzione della classe sociale di volta in volta deputata dallo Stato
nordista ad
esercitare l’egemonia politica sulle popolazioni meridionali. I banchi,
benché
spesso detentori di ingenti risparmi provenienti specialmente dall’estero,
non
servirono all’evoluzione della manifattura verso l’industria macchinistica,
e
neppure al progresso agricolo. Nella fase della genesi nazionale, lo scontro
con
Bombrini servì soltanto a esacerbare gli animi, a innalzare il livello
dell’inimicizia tra Nord e Sud e a imbalsamare quest’ultimo.
7.5 Prima di ricordare qualcuno degli scandali della finanza padana, i quali
mettono a nudo il volto veramente scalcinato del gruppo dirigente uscito dal
Risorgimento, è utile soffermarsi sulla finta unificazione monetaria. Si
tratta di
una vicenda contorta, incomprensibile a lume di ragione e inaccettabile
moralmente. Di regola gli storici sorvolano su questo tema, sebbene alla
fosca
operazione abbia fatto seguito il caos nel paese; il classico bordello
toscopadano stigmatizzato da Dante ben sei secoli prima. La non unificazione
monetaria non fu un accidente collegato alla povertà del nuovo Stato e/o
all’immaturità degli uomini al comando, come si lascia credere (agli
italiani),
ma una polpetta ben preparata con tossici e veleni. Il caos serviva alla
Banca
Nazionale, che si era collocata in posizione di medium (di fatto, non di
diritto)
tra i coni metallici degli ex Stati e il tesoro statale. Infatti, in quanto
fiduciaria
del tesoro avrebbe incassato (ed effettivamente incassò) i metalli in
circolazione e avrebbe emesso (e in effetti emise) biglietti. Fece il tutto
come
se il fatto fosse un accidente mentre era la regola. E di fatto in fatto, di
accidente ad accidente, trasformò l’oro e l’argento incassati nella propria
riserva.
Fu il perfezionamento del patriottico imperialismo di Cavour.
Utilizzando la massa d’oro e d’argento non suoi - incassati come per caso -
la Banca Nazionale dell’ex Regno di Sardegna poté emettere moneta (in
pratica fare credito) tre volte tanto: per altro un limite vigente solo fino
al
1866, e dopo questa data, a volontà. Insomma, pur rimanendo una banca
privata, la Banca Nazionale operò come se fosse una banca pubblica e la
banca
centrale. La sua banconota fiduciaria/sfiduciata continuò formalmente a
essere
emessa a debito di oro o argento - convertibile si continuò ad affermare -
ma
fu da subito un biglietto inconvertibile, che la gente ritenne dello Stato
sabaudo. Il capitalismo padano nasce e cresce su questi soldi falsi. Per
dirla
con la categoria smithiana più volte citata, secondo cui il capitale altro
non è
che il potere di comandare lavoro, già prima che fosse decretato il corso
forzoso dei suoi biglietti, la Banca Nazionale aveva emesso il 95 per cento
delle banconote in circolazione e aveva in mano una quota elevatissima del
potere di comandare lavoro in Italia. Traducendo altrimenti il concetto,
essa, in
quanto erogatrice della carta monetaria, poté realizzare un’incontrastata
egemonia sui processi capitalistici in atto, subordinando a sé tutto il
padronato
nazionale, in particolare la speculazione sul debito pubblico, le banche
commerciali, il commercio interno e internazionale, la manifattura, la poca
industria che c’era, l’agricoltura capitalistica e lo stesso Stato.
Negli anni immediatamente successivi alla malefica unità, le monete
metalliche rappresentavano ancora il versante mobiliare della ricchezza
italiana - o meglio degli italiani. Essendo fatte d’oro e d’argento,
allorché
venivano accantonate come riserva per il futuro, configuravano un risparmio
rigorosamente privato e anche stabile nel tempo. Bisogna inoltre aggiungere
che erano valuta internazionale in mano ai privati, come qualunque altra
merce[9]. Le nazioni che non possedevano miniere d’oro e/o d’argento, o non
avevano colonie ricche di miniere o una svelta pirateria, ottenevano i
metalli
da coniare cedendo altre merci ai paesi produttori e/o ai mercanti di
metalli
nobili.
Circa la quantità d’oro e d’argento coniati e circolanti al tempo, ci sono
giunte parecchie stime fatte sia al momento della conversione sia risalenti
ai
decenni precedenti. Tali valutazioni si fondavano su dati certi (o quasi): i
registri delle zecche statali che monetizzavano le barre di metallo
importato o
fondevano e riciclavano l’oro o l’argento delle monete ritirate dalla
circolazione.
Fra dette stime, gli storici danno la palma a quella di Giuseppe Sacchetti,
un
funzionario della zecca milanese. Questi produsse due elaborati. Il primo
risale
al 1858, il secondo fu fatto nel 1862, proprio nella circostanza
dell’unificazione
mancata, e comprende anche la Venezia Euganea, Roma e Mantova, non
ancora passate allo Stato sabaudo.
Tab. 7.5a Circolazione metallica in Italia
Stime del Sacchetti:
| |
Prima stima
(milioni) |
Rettifica
(milioni) |
Circolante pro
capite rispetto.
Due Sicilie = lire
50 |
| Regno di Sardegna |
182,2 |
176,5 |
-10,1 |
| Ducato di Parma |
20,3 |
19,9 |
-10,5 |
| Ducato di Modena |
18,5 |
18,0 |
-20,1 |
| Stato Pontificio (a) |
97,1 |
98,8 |
-10,0 |
| Toscana |
71,8 |
73,0 |
-10,1 |
| Lombardo-Veneto |
223,5 |
|
|
| Due Sicilie |
464,1 |
457,5 |
= |
| Lombardia (b) |
|
112,3 |
-10,0 |
| Nizza e Savoia |
|
26,6 |
-10,0 |
| Veneto |
|
99,9 |
-10,0 |
| Roma e Lazio |
|
29,7 |
-10,0 |
| Totale |
1.077,5 |
1.112,2 |
|
Mia elaborazione su De Mattia, pag. 72
a) Bologna, Romagna, Umbria, Marche
b) Esclusa Mantova
c) Popolazione residente secondo il Censimento 1861
* Le prime due colonne numeriche riportano i dati forniti da Sacchetti. La
terza colonna contiene un indice, che ha a parametro la circolazione pro
capite
le Due Sicilie, in quanto lo Stato duosiciliano ha un dato più alto (ma
forse
soltanto il dato più attestato da pubbliche registrazioni).
Questa stima contrasta con un dato che si vuole certo; una di quelle
certezze, però, tipicamente italiane, di cui è preferibile dubitare. Si
tratta della
registrazione, a cura del ministero delle finanze, del rastrellamento di
tutti i
coni preunitari, concluso nel 1894.
Tab. 7.5b Circolazione monetaria negli ex Stati calcolata
base alle monete successivamente rastrellate:
| Stati |
Milioni
di lire |
Media pro capite
(lire) |
Milioni lire |
| Antiche provincie (Regno di Sardegna) |
27,1 |
Provincie meridionali |
433,7 |
| Provincie parmensi |
1,2 |
Provincie venete |
12,8 |
| Provincie modenesi |
0,5 |
Provincie romane (dopo 1870, ndr) |
35,4 |
| Provincie ex pontificie |
55,3 |
Valute estere |
13,9 |
| Provincie toscane |
85,3 |
Verghe del Banco di Napoli |
4,6 |
| Provincie lombarde |
8,1 |
Monete decimali |
17,3 |
| |
|
Monete italiane a 835 mill. |
27,0 |
| Totale |
|
|
722,2 |
De Mattia, pag. 72.
Il problema dell’unificazione dei sette sistemi monetari esistenti venne
affrontato un anno dopo l’unificazione dei debiti pubblici degli ex Stati.
In
ossequio alla logica – da cui non si può prescindere neanche nel dare
giudizi
sul passato - tratterò prima il tema della (non) unificazione monetaria e
poi
quello cronologicamente precedente del debito pubblico.
A provvedere all'unificazione monetaria, il governo Rattazzi impegnò il
ministro dell’agricoltura, che aveva competenza anche sul commercio e
sull’industria. Ed è questa un’ulteriore stranezza, in quanto logica avrebbe
voluto che fosse il ministro delle finanze, al tempo Quintino Sella, a
occuparsene.
Siamo a metà anno del 1862. Cavour era morto l’anno prima. Gli era
succeduto Ricasoli, ma il bacchettone laico era stato costretto a lasciare
la
mano perché inviso al luminoso re piemontese. Fra i componenti del ministero
Rattazzi, entrato in carica all’inizio dell’anno, c’è Gioacchino Napoleone
Pepoli,
un aristocratico bolognese, figlio della figlia di Gioacchino Murat –
pertanto
cugino di Napoleone III - nonché marito di una congiunta del re di Prussia
e,
bisogna doverosamente aggiungere, appassionato patriota, drammaturgo,
narratore, buon conoscitore dei problemi economici e infine già parrocchiano
del defunto Cavour.
In teoria l’operazione non presenta problemi. Si tratta puramente e
semplicemente di copiare l’assetto francese, a cui volente o nolente
l’Italia
deve uniformarsi, per una convenzione internazionale in itinere e per
agevolare
i suoi traffici internazionali, come peraltro avevano fatto per mezzo secolo
il
Regno Sardo e da trent’anni il Regno duosiciliano. Nel Piemonte e nel Ducato
di Parma vigeva il sistema decimale (quello che noi posteri usiamo), mentre
negli altri ex Stati l’unità monetaria aveva multipli e sottomultipli di
tipo
tradizionale e non sempre il sistema decimale. Nonostante le contrarie
affermazioni dei ballerini di fila, ingaggiati nelle patrie università in
occasione
del centenario della conquista sabauda (per mostrare all’inclito vulgo
quanto
grande e forte e bello e civile fosse il Piemonte di Cialdini e Lamarmora e
quale
schifo facessero gli altri italiani), nel Regno delle Due Sicilie il sistema
monetario era perfettamente decimale, anche se circolavano ancora dei coni
non coordinati con il dieci e con i multipli di dieci.
Il ducato, l’unità monetaria napoletana, non era coniata; il conio minimo
era
di quattro ducati (taglio per i benestanti). Al posto dell’unità mancante
era
coniato, però, un dieci carlini d’argento, in pratica un ducato. Difatti il
ducato
si divideva in 10 carlini, un carlino in 10 grana[10], un grano in 10
cavalli o
calli; in età precedente il cavallo si divideva in tornesi. In Sicilia i
nomi
cambiavano ma il sistema era lo stesso. L’unità monetaria era lo scudo
avente
il valore esatto di tre ducati. Quanto alla moneta divisionaria, un tarì era
lo
stesso che un carlino, un baiocco lo stesso che un grano e un picciolo lo
stesso
che un cavallo. Uno scudo → 30 tarì → 300 baiocchi → 3000 piccioli.
La convivenza di una moltitudine di nomi e di segni monetari può sembrare
la fonte di una gran confusione. Ma più che una divisione del valore delle
monete c’era, in questa varietà di nomi e di tagli, una divisione
orizzontale
delle classi di reddito. L’oro era riservato ai ricchi e ai potenti,
l’argento alla
generalità della borghesia, il rame e il bronzo al proletariato. In effetti
la
molteplicità dei nomi aveva una valenza classista, mentre la irregolarità di
multipli e sottomultipli era il prodotto del succedersi dei dinasti e delle
dinastie[11] e della longevità dei metalli. Internazionalmente le monete dei
vari Stati trovavano una scorrevole coordinazione mentale e contabile nella
diffusa conoscenza del contenuto in metallo fino di ciascun conio. Nell’area
padana, i ricchi e coloro che stavano negli affari avevano un riferimento
fisico e
contabile internazionale rappresentato dal franco francese, che veniva
impiegato non solo nelle transazioni commerciali, ma era considerato anche
una specie di moneta di conto.
L’influenza francese non raggiungeva le Venezie e le regioni
centromeridionali. Però il fiorino austriaco e il ducato napoletano erano
monete
largamente note, perché le corrispondenti regioni avevano larghi traffici.
Pertanto il loro valore al cambio non doveva essere calcolato di volta in
volta
dai privati, ma dava luogo a una specie di cambio fisso, che restava tale
fin
quando non mutava l’intrinseco delle monete o il prezzo relativo dei
metalli.
All’epoca, le popolazioni meridionali (i ricchi, o i non poveri) usavano
prevalentemente monete d’argento, mentre circolava soltanto qualche
pezzatura d’oro. Dopo l’unità, la rivalutazione dell’argento sull’oro
coinvolse
anche i meridionali. Le monete d’oro, con l’effigie del vittorioso Vittorio,
che il
governo torinese cercava di rifilare in cambio dei ducati in argento, furono
disdegnate. C’è da aggiungere che i coni postunitari del Regno d’Italia
ebbero
un minor titolo d’argento, mentre per il ducato, che non era più coniato, il
titolo dell’argento rimase quello di prima. Cosicché neanche l’argento
padano si
scambiò scorrevolmente con l’argento napoletano. Si deve, infine, annotare
che il cambio ufficiale di un ducato per lire 4,25 era leggermente
fregatorio;
cosa che nelle transazioni commerciali più consistenti risultava
penalizzante.
D’altra parte - l’abbiamo già ricordato - in Piemonte la convivenza di
monete d’oro e d’argento, tra loro permutabili in base a un rapporto fisso
(bimetallismo), aveva provocato e provocava la fuga dell’argento, nonché
l’insorgere di un aggio dell’argento sull’oro (la moneta di minor valore
intrinseco scaccia dalla circolazione quella migliore, che si propende a non
spendere). Ergo, fatta l’unità, i ducati d’argento presero a far gola sia a
Bombrini, che li cedeva alla Francia, dove venivano valutati per il
contenuto di
fino.
In conclusione, Pepoli non cambiò alcunché, benché la conversione fosse
agevole da fare avvalendosi dell’oro e dell’argento in circolazione, la cui
massa
era tale che qualcuno poté stimare quella italiana una circolazione più
abbondante della francese. Il ministro si limitò a determinare una parità
cambiaria tra lira piemontese e ciascuno degli altri coni circolanti.
Peraltro
questa tariffa di cambio era già in vigore. L’avevano fissata, luogo per
luogo,
nel corso della guerra, i dittatori, i prodittatori, i luogotenenti regi,
cioè i
funzionari di Cavour, travestiti da rivoluzionari, che si andavano
acquartierando
nelle città assoggettate. Con la legge Pepoli la lira fu proclamata l’unica
moneta ufficiale, ma solo sulla carta, perché le antiche monete conservarono
per legge un potere liberatorio presso i privati e presso lo Stato italiano,
pari al
loro cambio ufficiale. In buona sostanza la lira fu, per lungo tempo, una
vera
moneta soltanto negli ex Stati sabaudi, in Lombardia ed Emilia. Altrove si
configurò come una vessazione e un’ingiuria del conquistatore. Al Sud, per
più
di un decennio, fu scarsamente accettata. La gente calcolava in lire
l’importo
delle tasse da pagare, ma le pagava, però, con la moneta storica (cosa che
piaceva al potere padanista). Qualche mercante che accendeva un debito con
la sede locale della Banca Nazionale, per utilizzarlo, doveva compiere tre
operazioni in perdita. Prendeva biglietti, che trasformava in oro pagando un
aggio; e pagava un aggio per cambiare le lire oro in vecchi ducati e
carlini.
Nient’altro d’italiano, neppure le private e pubbliche imprecazioni alla
faccia di
Vittorio, ovviamente profferite in dialetto.
Si potrebbe aggiungere che l’introduzione della lira come moneta di
conto, invece che rendere più agevoli gli scambi, li complicò. Ad esempio,
tra
un ducato napoletano e un fiorino austriaco il cambio, prima, era diretto,
mentre adesso bisognava fare (quantomeno negli atti pubblici) un conto
triangolare con la lira sarda. La cosa fu lamentata in parlamento, ma in
modo
banale. Non si trattava soltanto del disagio personale di chi viaggiava, nel
caso i deputati e i senatori, a cui toccava attraversare la penisola per
raggiungere la nuova capitale, ma molto più. Ovviamente il deputato
siciliano,
che passando per Ancona voleva mangiare e comprare un sigaro, non poteva
farlo se prima non aveva cambiato la sua valuta nella moneta locale. Nella
realtà sociale, la gente subiva bel altro disagio, in quanto la vecchia
moneta
veniva incassata dallo Stato (e in misura notevole rispetto al passato),
mentre
il numerario di Vittorio continuava a latitare. Anche peggio per lo spezzato
di
rame o di bronzo, risucchiato a Torino per fare anch’esso da riserva ai
biglietti
della Nazionale. Più che di disagi, bisogna parlare di una crisi di notevoli
dimensioni, puntualmente registrata dai contemporanei, ma quasi ignorata
dalle gloriose storie patrie per le scuole.
Nel Napoletano, dove la gente aveva un gran rispetto per la moneta e dove
prima correva una quantità notevole di spezzato metallico, la crisi non fu
soltanto economica, ma anche morale (e forse spirituale), perché Stato e
popolo realizzarono una contrapposizione prima inesistente[12].
7.6 Il fatto che il caos monetario dipese dall’ingordigia della Banca
Nazionale
emerge senza ombra di dubbio, se ci prendiamo la pena di confrontare il
circolante stimato e il circolante rastrellato entro 1894.
Tab. 7.6c Vuoto contabile tra circolazione e ritiro delle monete:
| Ex Stati |
2ª Stima
Sacchetti
(milioni) |
Monete
rastrellate
entro il 1892 |
Differenza (vuoto
contabile) |
| Regno di Sardegna |
176,5 |
27,1 |
-149,4 |
| Ducato di Parma |
19,9 |
1,7 |
-36,2 |
| Ducato di Modena |
18,0 |
|
|
| Stato Pontificio |
98,8 |
90,7 |
-8,1 |
| Granducato di Toscana |
73,0 |
85,3 |
+12,3 |
| Lombardo-Veneto |
212,2 |
20,9 |
-191,3 |
| Due Sicilie |
457,5 |
443,3 |
-14,2 |
| Totale |
|
|
-386,9 |
Mancano all’appello 387 milioni in oro e argento, un terzo della
circolazione
stimata. Il vuoto maggiore si registrò in tre aree politiche, il Regno di
Sardegna, il Lombardo-Veneto, i Ducati, il nucleo cinquantonovesco del Regno
d’Italia. Si trattava delle le regioni agricole più ricche d’Italia e non è
immaginabile che le popolazioni potessero svolgere i normali scambi con 50
milioni appena. D’altra parte il vuoto non si produsse in trenta anni, ma in
tre
soli anni, infatti venne rilevato già nel 1862. In sostanza Bombrini, in tre
anni,
riuscì a far sparire dalla circolazione ben 387 milioni di numerario.
In questo lasso di tempo la Banca Nazionale s’irrobustì con il numerario dei
nuovi sudditi e venne a trovarsi nella fortunata condizione di partecipare
attivamente alla collocazione dei prestiti nazionali, accanto ai grossi
finanzieri
internazionali. In buona sostanza, non era più una banca provinciale, ma una
banca che aveva vinto il SuperEnalotto dell’unificazione nazionale. Cavour
defunto, Bombrini non era più un attaché, ma un potente che stava più in
alto
del governo, del parlamento e del re.
La legge morale, quella che tutti conosciamo guardando il cielo stellato,
per
lui era il lucro; un sentimento comune a quasi tutti gli uomini, e anche
legittimo, anzi encomiabile nell’assetto capitalistico vigente per gli
uomini del
suo tempo e del nostro, ma sicuramente un sentimento da non contrabbandare
per patriottismo. La retorica capital-patriottica mette sullo stesso altare
i
fratelli Cairoli e Carlo Bombrini, i ragazzi di Curtatone e la Banca
Nazionale.
Ciò serve a confondere le idee in testa alle popolazioni meridionali.
Infatti, è
indiscutibile che tanto Bombrini quanto la Banca Nazionale hanno dato
all’Italia
padana molto più di tanti giovani generosi. Ma né gli eroi né i martiri
santificano le scostumatezze del capitalismo padano nel governo del
Meridione
– quelle del passato, quelle attuali e quelle future. Né l’Italia di
Bombrini può
essere decentemente l’Italia di tutti. Il busto di Sella, che sta nel
salotto dei
ministri del tesoro, in Via XX Settembre, a Roma, e le celebrazioni
giornalistiche e accademiche di un ambivalente e controvertibile uomo di
Stato,
vanno considerati uno schifoso plagio della coscienza dei meridionali.
Quanto alla circolazione, la legge Pepoli stabilì che in futuro i nuovi coni
avrebbero recato la faccia impudente del re Savoia. Tuttavia, nel corso dei
decenni successivi, le nuove coniazioni della lira ascesero in tutto a 416
milioni,
cioè a un terzo del numerario necessario per assicurare una soddisfacente
circolazione. Assolto il compito, Pepoli, che probabilmente non era dotato
della
faccia tosta che Dio aveva regalato ai suoi colleghi, cambiò mestiere e andò
a
fare l’ambasciatore prima in Russia e poi in Germania. Evidentemente si rese
conto d’essere stato un pupazzo, bassamente strumentalizzato in un’azione
contraria all’interesse nazionale. Gli italiani badarono poco al suo destino
politico, invece dovettero piangere per decenni a causa della baraonda
monetaria voluta da Bombrini e dalla speculazione al comando.
Esaminando le cifre, chiunque capisce che in un paese in cui il circolante
metallico era considerato più che sufficiente, e forse del tutto abbondante,
anche senza i 400 milioni confiscati proditoriamente da Bombrini, la massa
d’argento disponibile avrebbe consentito di far partire, senza forzature,
anzi
nel modo più tranquillo, una circolazione metallica sufficiente per l’intera
Italia,
sulla quale innestare l’impiego della banconota convertibile per dilatare il
credito. Invece il governo – non a caso o non per ignoranza - scelse la
soluzione più odiosa e meno corretta, infliggendo agli italiani trenta anni
di
caos monetario. Sempre non a caso, si arrivò al punto che anche i milionari
si
trovavano in difficoltà quando compravano un sigaro (sicuramente toscano). I
coni minori e gli spiccioli non scarseggiarono per una stagione o per un
anno,
ma per interi decenni. Da tutte le regioni del paese – un po’ meno dal Sud,
che
difese la sua moneta - i prefetti spedivano allarmati telegrammi alle
autorità
centrali, in quanto le aziende non riuscivano a cambiare le banconote
bombrinesche nella moneta necessaria per pagare i salari. Clamoroso - ma non
isolato, anzi alquanto comune e dovunque rilevato - il caso di Firenze dove,
per
anni, circolarono bigliettini monetari emessi dai macellai. In verità, il
vero
macellaio d’Italia fu Bombrini, avido e arrogante.
E’ inutile chiedersi se fu insipienza o una scelta. Manovrato dietro le
quinte
dal grande banchiere, il governo rese stabile l’incertezza. Artefice del
disastro
non fu, dunque, l’inesperienza, come raccontano untuosamente gli storici
unitari, ma la guerra del capitalismo, che in quanto capitalismo è apolide,
contro gli italiani e la speranza di fare dell’Italia una nazione. E non
basta
neppure definire il passaggio con un succinto riferimento allo scontro di
classe;
fu anche uno scontro all’interno della classe vittoriosa tra produzione
reale e
parassitismo bancario, nonché scontro aperto per l’utilizzazione delle
risorse
centralizzate dallo Stato, fra municipi ex rinascimentali e le aree prive di
tradizioni municipalistiche. In tale quadro, molto articolato, ha
un’importanza
decisiva che, dopo la morte di Cavour, la gran regia delle finanze italiane
fosse
tenuta concretamente dai soliti genovesi – il duca di Galliera, Bombrini,
Balduino – e da qualche toscano. Senza anticipare eventi posteriori, basti
qui
ricordare che i ministri delle finanze andavano e venivano, e così pure i
presidenti del consiglio dei ministri, e che invece Bombrini restò
inchiodato al
suo posto di amministratore di una società privata, quanto ai suoi
interessi, ma
pubblica quanto al potere di comando.
L’Italia dei ladri si formò sotto la sua regia. Come risultato non
accessorio
dell’arricchimento gratuito della Banca Nazionale si ebbe l’enorme
dilatazione
della disponibilità di capitale liquido, sotto forma di credito bancario,
per la
clientela degli speculatori. Sulla base dei 400/500 milioni di riserve
auree,
Bombrini poté spargere su quella parte della Padana che oggi chiamano il
Nordovest, quasi fosse un punto cardinale di tipo morale, ben un miliardo di
crediti bancari, cioè sestuplicare il potere di comandare lavoro che i
capitalisti
dell’area avevano in precedenza. Con forzature del genere si dà luogo non a
una, ma a quattro o cinque questioni meridionali.
Gli storici hanno l’impudenza di non spiegare che, nei seimila e più Comuni
del nuovo Regno, non si presentò mai un funzionario pubblico a convertire
l’oro
e l’argento recante l’effigie di un antico sovrano, con l’oro recante il
laido
profilo di Vittorio secondo, come avrebbe voluto un minimo di funzionalità e
patriottica correttezza. Le nuove coniazioni di numerario arrivarono in
tutto a
416 milioni, nonostante che le importazioni d’oro dalla Francia – ovviamente
pagate dalle esportazioni di tutta l’Italia – arrivassero a 800 milioni in
appena
sette anni.
La contraddizione è patente, ma è facile da spiegare; cosa che ci permette
di preparare il lettore alle maraviglie che incontrerà da qui a poco, quando
tratteremo del debito pubblico. L’oro veniva acquistato solo in parte per la
monetazione, come si vorrebbe far intendere, e neppure veniva portato in
Italia fisicamente, sebbene all’operazione si dia il nome rallegrante di
importazioni. Le triangolazioni sono e sono sempre state una buona occasione
di profitto. In antico quelle dello zucchero americano, al tempo di Bombrini
quelle delle cartelle della rendita, oggi quelle tra banche patrie e banche
off
shore. Facciamo l’ipotesi verosimile dell’emissione di un prestito pubblico
di
500 milioni al 5 per cento annuo: cinque lire d’interesse sulla cartella
standard da 100 lire. Poniamo inoltre che lo Stato, ormai sfiduciato, pur
d’incassare una parte dei 500 milioni, collochi le cartelle a 50 lire
cadauna. Le
cartelle vengono sottoscritte da banche nazionali e da case finanziarie
straniere. Entrambe, però, se ne disfano subito, rivendendole ai piccoli
risparmiatori a un prezzo inferiore. Per esempio a lire 45. In tal modo
fomentano, anche se a proprie spese, un clima ribassista. Il risparmiatore
qualunque le compra in un suo momento di prosperità, per assicurasi una
rendita annua o per non tenere inoperoso il danaro. Poi, o si presenta
l’occasione per un affare migliore, o sopravviene un’imprevista esigenza di
liquidità o la paura d’aver sbagliato l’investimento. Di fronte a situazioni
simili, la prima cosa che il piccolo ricco fa è quella di rivendere i titoli
che
tiene in portafoglio.
In tal modo il titolo ribassa ancora. Scende (è storia patria) a 35, 30, 25,
23 lire. A questo livello le banche e le case bancarie ri-comprano.
Incassare
una rendita diviene più vantaggioso che prestare a interesse. Quatto
cartelle,
comprate al prezzo di una, danno 20 lire di interessi annui. Cioè, non più
il 5,
ma il 20 per cento di interesse annuo. In pratica, in un solo anno, gli
interessi
pagano il capitale. Nei nove anni successivi, 10 lire frutteranno gratis 9
volte
x 10, cioè 90 lire; in venti anni moltiplicano il capitale diciotto volte.
Insomma la patriottica unità è un affare di palanche. Il capitalismo
cosiddetto nazionale, quando non nasce rubando direttamente allo Stato,
nasce da una banca che regala ai patrioti padani l’oro che lo Stato le
consente
di confiscare alle classi subalterne con la violenza, la paura, l’inganno,
la
sopraffazione. Quest’oro lo moltiplica fittiziamente molte volte, attraverso
un
automatismo bancario e creditizio che sposta verso le centrali regionali di
comando dell’altro oro, e poi, una volta esaurito l’oro nazionalmente
disponibile, una quota consistente del surplus sociale prodotto nelle
restanti
regioni. Sembra sviluppo, ma fattualmente è capitale confiscato alla
produzione
Il meccanismo bombrinesco trovò il suo carburante nell’impoverimento
delle masse contadine e manifatturiere e nella confisca della rendita
padronale ad opera della fiscalità statale. Storicamente, attraverso
l’impoverimento delle popolazione, il capitalismo speculativo e
intrallazzistico
toscopadano impose, in primo luogo, la formazione di surplus da astinenza
e, in secondo luogo, la ruralizzazione di una vasta parte del paese, in
particolare del Sud, le cui attività extragricole crollarono in poche
settimane e
continuarono a essere tenute sotto mazza, in modo che non potessero
riprendersi. Il sottosviluppo del Sud è incontrovertibilmente funzionale
alla
formazione di un comando padano.
7.7 Un meccanismo collaterale dell’accumulazione originaria è il debito
pubblico. Parigi è la borsa guida per i titoli italiani. Ma lì, le banconote
di
Bombrini non hanno corso. Si compra pagando in oro, altrimenti che Parigi
sarebbe! Ma da dove arriva l’oro con cui gli italiani acquistano cartelle
del
debito pubblico italiano a Parigi? Dalla stessa Parigi, dove decine di
migliaia
di importatori francesi di seta, di vino, di zolfo, di olio, di marmi, di
fichi
secchi acquistano con oro sonante valuta italiana, con cui pagare
l’esportatore italiano. Per trent’anni, quest’oro resta fisicamente a
Parigi,
anche se contabilmente entra in Italia e viene impiegato a tradire
patriotticamente gli interessi d’Italia (ente fumoso) e degli italiani
(esseri
viventi). E nonostante queste carognate, c’è ancora chi, riferendosi agli
uomini della Destra storica, si esalta, e definisce gli anni in cui fu fatta
l’Italia
e furono disfatti gli italiani come l’era del buongoverno.
In conclusione, le importazioni d’oro non servirono granché a coniare
monete; furono prevalentemente atti contabili, apparentemente del settore
pubblico, in effetti del settore privato, collegati al patriottismo
bancario, lo
stesso che infervora gli attuali cantori dell’Inno di Mameli.
Tab. 7.7 Importazioni di oro prima del corso forzoso del 1866
Fonte: Atti I, p. 32:
| 1860 |
49.366.000 |
|
1864 |
151.579.900 |
| 1861 |
111.832.715 |
|
1865 |
152.497.400 |
| 1862 |
118.360.200 |
|
1866 |
43.094.000 |
| 1863 |
171.790.190 |
|
In totale |
798.490.405 |
Per 35 anni, la confusione monetaria e contabile regnò sovrana. Il
numerario scompariva dalla circolazione senza altra spiegazione se non
questa: l’oro esce dal paese perché, a ondate, i possessori stranieri (leggi
le
grandi case parigine, in pratica Rothschild) si disfano dei titoli del
debito
pubblico in loro possesso. Ma ci si guarda bene dall’aggiungere che dietro
quelle vendite si sviluppava il patrio intrallazzo. Chi compra alle svendite
parigine sono quei fondatori della patria che stampano banconote o le
ricevono facilmente in prestito al 5 per cento. E non solo loro. Parecchi
ministri padani (dei governi italiani) partecipano allo scialo. Molte grandi
fortune padane nascono da questa disonesta prassi. Il re nomina conti e
marchesi gli avventurieri più fortunati, i loro palazzi illustrano tuttora
le più
belle vie delle capitali padane, le loro ville nobilitano gli eredi, i libri
di storia e
le enciclopedie ne illustrano i meriti. Gli italiani pagavano e pagano.
Non solo l’oro importato non viene effettivamente importato, ma il
circolante metallico degli ex Stati viene esportato a fiumi con la copertura
di
Bombrini e il beneplacito dei patrioti che reggono le sorti dello Stato. La
Commissione d’inchiesta parlamentare sul corso forzoso non volle
(ovviamente) affondare il coltello nella piaga, né il patriottico regista
della
colossale speculazione sul pane quotidiano degli italiani, mai, ne dette le
cifre.
E’ facile dedurre che l’omessa conversione del circolante metallico
non ebbe altro scopo che quello di coprire con una fitta cortina
fumogena la subdola e bieca espropriazione del popolo nazionale da
parte di una società privata, che colse il momento propizio per
realizzare superprofitti di regime.
A passarsela male furono i poveri particolari. Se a qualcuno venisse in
mente di fare un’antologia degli interventi parlamentari svolti tra il 1861
e il
1915 sulla condizioni create fra la gente dall’ingordigia bancaria, dovrebbe
prevedere un’opera in dieci volumi. In Italia si arrivò al punto che avere
un
pezzo d’oro da venti lire bisognava darne venticinque di carta e per
cambiare
un biglietto da cento lire in venti monete da cinque lire si pagava un pizzo
di
venti lire; e come già ricordato, mancavano i pochi centesimi necessari per
pagare un caffè, perché la Nazionale speculava anche sul rame e sul bronzo .
7.8 E’ interessante osservare la dilatazione, tra il 1859 e il 1866, della
cassaforte di Bombrini, la quale conteneva appena 5, 7 milioni nel 1858 oro,
ma si ritrovò con ben 400 milioni oro nel 1866. E ciononostante pretese il
corso forzoso dei suoi biglietti.
Tab. 7.8 Drenaggio operato dalla Banca Nazionale
prima e dopo l’unificazione politica
(milioni di lire italiane dell’epoca)
| Anni |
Oro |
Argento |
| 1858 |
2,791 |
2,918 |
| 1859 |
11,183 |
1,194 |
| 1860 |
24,245 |
2,421 |
| 1861
|
16,493
|
4,815
|
| 1862 |
11,080 |
14,123 |
| 1863 |
11,762 |
14,554 |
| 1864 |
9,184 |
15,408 |
| 1865 |
18,187 |
28,003 |
| 1866 |
15,250 |
19,928 |
| 1867 |
55,226 |
19,895 |
| 1868 |
58,899 |
39,758 |
| Drenaggio 1858-68 |
231,509 |
160,099 |
| In totale |
|
392,506 |
| Diritto di emissione
|
|
1.177,5
|
|
= 5,709
Periodo: Regno sardo – Diritto di
emissione = 17 milioni |
Regno d’Italia (Ex provincie sarde +
Lombardia. Emilia, Romagne, Umbria,
Marche) – Rastrellati
Oro 8,430
Argento 51,921
Diritto emissione =
181 milioni |
Precedenti + Napoletano e Sicilia.
Rastrellati:
Oro 83,997
Argento 52,515 Diritto di emissione:
181 milioni |
Precedenti + Toscana. Rastrellati:
Oro 117,434
Argento 100,446
Diritto di emissione: 651 milioni |
Precedenti + Mantovano e Venezia
Euganea. |
| |
| |
|
|
Dal 1866 sarà in vigore il Corso forzoso, per la Banca Nazionale un diritto
d’emissione teoricamente
illimitato
Crescita del diritto di emissione tra il 1858 e il 1868: 145 volte
Secondo Carlo M. Cipolla - che esagera - nel 1874 la circolazione era
interamente passata alla carta bancaria. Attraverso cordiali e non casuali
facilitazioni dello Stato, la Banca Nazionale s’impadronì di tutto l’oro e
di tutto
l’argento italiano in cambio di carta accettata dal tesoro. E tuttavia il
suo
guadagno maggiore non fu l’oro, che prima o poi dovette cedere ai creditori
stranieri, ma il meccanismo in base al quale il temporaneo incasso di
numerario (oro, argento, rame, bronzo, fedi dei banchi meridionali) si
trasformava riserva legale su cui effettuare nuove emissioni. Ciò le permise
di
moltiplicare la carta, in pratica il credito. E c’è una seconda apparenza da
smitizzare: non fu la Banca Nazionale in prima persona a ottenere un
duraturo vantaggio. Nel lungo periodo, furono i suoi clienti finali – quei
padani
che operavano nella produzione reale - a realizzare un consistente aumento
del potere di comandare lavoro e a incanalare i loro affari in una spirale
positiva; cosa che li condusse senza affanni al controllo di tutto il
mercato
nazionale.
Ripeto, la conversione delle monete avvenne con una semplice procedura: i
privati, se non avevano carta di cui liberarsi, pagavano imposte e tasse con
il
vecchio numerario. La tesoreria di Stato, alias Bombrini, pagava con i suoi
biglietti. L’oro incamerato faceva da riserva ai biglietti. I biglietti dati
a credito
facevano, a loro volta, l’accumulazione originaria del capitalismo padano.
Al
principio la cosa sconvolse l’immaginario collettivo e la vicenda venne
stigmatizzata con l’espressione ‘il carnevale bancario’. Poi, una volta
scavato
il solco e trascorsi i decenni, l’acqua prese a scorrere normalmente
nell’alveo,
sicché il giudizio cambiò e il ‘carnevale’ si trasformò nel ‘capitalismo
italiano’ e
‘nel salotto buono di Milano’. Si dice a Napoli: ‘pure ‘o scarafone è bello
a
mamma sua’.
7.9 Nelle pagine iniziali di questo lavoro, ho cercato di riassumere il
generale
percorso dalla banconota, che parte timidamente dalla convertibilità in
numerario, affronta le guerre napoleoniche con la copertura del corso
forzoso
(il quale – ricordo - nasconde un’imposta sul patrimonio), torna poi alla
convertibilità, ma questa volta (benché la forma rimanga ancora quella del
titolo cambiario privato) nella sostanza è già una moneta emessa e garantita
da una banca centrale - effettivamente dallo Stato. In Gran Bretagna e in
Francia i vari passaggi si snodano su un percorso che dura un secolo e mezzo
circa. Invece in Italia si bruciano le tappe. Lo Stato italiano nasce prima
della
sua buffonesca inaugurazione ufficiale del marzo 1861. La data di partenza è
il
1859, allorché l’amministrazione sabauda prende sotto di sé mezza Italia.
Tra
questo momento e il maggio del 1866, data della decretazione del corso
forzoso dei biglietti, corrono appena sette anni, nel corso dei quali viene
perfezionato il meccanismo dell’accumulazione originaria padana. Di fronte
alla ricchezza reale, effettiva, si erge lo Stato, il quale l’assorbe e la
ridistribuisce attraverso il fumo di una banconota praticamente
inconvertibile.
Il corso forzoso del 1866 rappresenta il primo assestamento della manovra,
la
prima tappa del drenaggio, dalla quale il meccanismo riparte con maggiore
sicurezza di sé e con più vaste pretese. In apparenza niente era cambiato
rispetto a prima, chi aveva una casa ce l’aveva ancora, chi aveva un fondo
ce
l’aveva ancora, chi aveva un opificio continuava a portarlo avanti. Ma nel
paese
era nato un nuovo equilibrio, si era creata una ricchezza, ambiguamente
infondata e vera, che poteva comprare le case, i terreni, gli opifici, le
navi, gli
animali, con i danari di chi vendeva. Dal punto di vista degli equilibri
nazionali,
era soprattutto avvenuto che la fatica della gente (il comprare e il
comandare
lavoro) si poteva ottenere con danari che non c’erano, ma che in futuro
sarebbero volati via dalle tasche di qualcuno, per approdare nelle tasche di
un
altro.
Questo fumo di valore, nelle mani della banca d’emissione assurge a
potere di erogare credito. E il credito, una volta in mano al produttore,
diventa capitale, potere di comandare lavoro. L’Italia, che prima
dell’unità, se non era un paese politicamente unito, era quantomeno un paese
uniforme, adesso si divide: avvia una sua singolare storia di disparità
nazionale, avendo come displuvio economico e civile il potere della carta.
L’egemonia parlamentare e governativa della proprietà agraria è una favola
di cui siamo debitori alla malafede degli storici. Indubbiamente
l’estrazione
degli asini e dei malfattori, che sedevano in parlamento, era di tipo
agrario e
municipalistico; non altrettanto l’indirizzo governativo, che fu ispirato da
ammiragli incompetenti e ribaldi, da generali inetti e sanguinari, da
speculatori
impancatisi a cavalieri d’industria e da usurai che si autodefinivano
banchieri,
fra loro, in combutta aperta o in tacito consenso. Certo il Rinascimento ha
lasciato ai toscopadani grandi opere d’arte e insigni monumenti, ma anche un
vocazione all’ingordigia, al cinismo, all’usura. L’animus spoliandi sta alle
radici
della cultura corrente. Genovesi, fiorentini, veneziani, per più di mezzo
millennio erano stati seduti assieme agli angioini, agli aragonesi, ai
castigliani,
a banchettare alla tavola che i meridionali erano costretti a imbandire. I
Borbone li avevano ricacciati trecento miglia lontano, ma ora tornavano
trionfanti e con un gagliardo appetito.
Nell’inseguire la sua ambizione di dominio, la Banca Nazionale ignorò la
lezione di prudenza e autocontrollo che veniva dalle banche d’emissione di
Francia e Regno Unito. Diversamente che in quei paesi, dove la banca
centrale
condivideva il disegno governativo di unificare le varie regioni, la
politica
bancaria di Bombrini mirò a realizzare - e realizzò - una forte non
comunicazione tra le borghesie delle regionali sottoposte unitariamente alla
stessa sovranità politica.
L’oro e l’argento, che Bombrini intasca, rendono, prima di tutto, una somma
pari al loro valore, e poi il loro valore moltiplicato per tre. Insomma 0
capitale
iniziale + 100.000 uomini in armi = zero per zero fa quattro: uno in cassa e
tre
dati a credito. La procedura è agevole. L’incasso statale di tributi fa due
beneficiari: i settori dell’economia padana verso cui fluisce la spesa
pubblica e
la Banca Nazionale che agguanta il numerario metallico, e con questo edifica
un potere fittizio di comandare lavoro a favore della sua clientela. Sarebbe
interessante appurare se Bombrini ebbe la consapevolezza dei risvolti
propriamente rivoluzionari delle sue intriganti operazioni. Comunque, la
sopraffazione è evidente in tutte le operazioni che va compiendo. Spesso si
tratta di azioni che il codice penale configura come reato, ma che restano
impunite in quanto hanno l’avallo del potere statale. Gli stessi ministri e
i
pubblici funzionari sanno di commettere un reato allorché traducono nella
sua
carta le somme riscosse come tributi allo Stato, ma l’ ’ordine nuovo’ sta
nella
carica di violenza e sopraffazione che il nuovo Stato incorpora ed
emblematizza.
Accanto alle fonti più larghe e cospicue di arricchimento, ce n’è una
riassuntiva ed emblematica della ‘legale’ spoliazione del Sud (o viceversa
del
patriottico uso padanista del Sud): i pagamenti sulle piazze estere delle
esportazioni meridionali. Chi, all’estero, paga un’importazione dall’Italia,
è
regola che lo faccia acquistando moneta italiana o un credito sull’Italia.
L’esportatore meridionale otterrebbe oro straniero, se di mezzo non ci fosse
la
banca italiana, la quale fornisce le lire richieste sulle piazze estere e
incassa la
valuta straniera che ne è il controvalore. In sostanza il Sud esporta, ma
l’oro
che lucra se lo pappa Bombrini. Il sistema bancario media tutte le
operazioni
valutarie. Bombrini, in quanto banca d’emissione, ottiene due lucri: la
mediazione bancaria e l’oro che incamera il cambio dei pagamenti all’estero
delle fatture italiane.
Siccome le esportazioni meridionali sono più di un terzo delle esportazioni
dell’Italia unita, esse diventano una fonte gratuita di arricchimento per la
Banca Nazionale e per l’intero sistema padano. Ottenere il valore delle
merci e dare carta in cambio, al momento, costituisce un passaggio
decisivo della colonizzazione padana del Meridione[13]. Traducendo
quanto sopra in storia dell’Italia unita, non solo si ripete un concetto
generalmente esplicitato, e cioè che a padroneggiare lo Stato è la borghesia
toscopadana, ma si individuano anche i processi tutt’altro che encomiabili,
anzi
propriamente (e regionalmente) ladroneschi, attraverso cui si realizza la
padronanza.
Infine è il caso di ricordare (lo vedremo meglio in appresso) che per
agevolare l’espansione della Banca Nazionale, i banchi meridionali furono
bloccati per parecchi anni e vennero riammessi a operare quando i buoi erano
fuggiti dalla stalla e in subordine alla Banca Nazionale. Insieme con altri
provvedimenti cavourristi, la sterilizzazione del sistema bancario
meridionale
sterilizzo anche la borghesia produttiva (De Matteo**, cit.), anzi la
riportò
indietro al 1825. La fine della borghesia attiva del Sud è la causa
efficiente del dualismo italiano, la conseguenza tragica della guerra
regionale inaugurata con l’unità. La politica bancaria cavourrista fu, per
il
Sud, una batosta più catastrofica dell’iniquità erariale; volle dire in
pratica
l’ilotizzazione del paese meridionale.
7.10 Nella sua velocissima corsa verso le cento città d’Italia, Bombrini non
piantò le tende solo nelle città ricche di commerci e d’affari, ma anche in
luoghi in cui il giro commerciale aveva un tono alquanto dimesso. Il fatto
riceve il suffragio degli storici, i quali affermano che tale procedura era
il frutto
della volontà politica di diffondere il credito bancario dove non esisteva.
Un’affermazione capziosa, ovviamente! Al tempo, la massa delle operazioni
creditizie veniva effettuata dalle case bancarie, diffuse anche in
provincia. Ma
le carte vengono rimescolate abilmente, in modo che venga fuori,
immancabilmente, il sette di coppe. Da sempre si è detto o lasciato
intendere
che la parte d’Italia carente di una buona geografia creditizia fosse il
Sud. Falso
anche questo! Carte alla mano, fino al 1858il Regno di Sardegna ebbe
soltanto
due sportelli bancari, e solo a partire da quella data cinque. Nel 1859, la
Toscana aveva due banche e in tutto tre sportelli, la Lombardia una banca
con
due sportelli. A Parma, Modena e Bologna esisteva una banca per città. In
tutto il Triveneto operavano due sportelli bancari. La Due Sicilie dal 1849
avevano due banchi fra loro coordinato, e nel 1858 tre sedi aperte e due in
via
di apertura. Non si capisce quindi dove fosse il relativo ritardo del Sud.
Gli storici lamentano che, al Sud, la Banca Nazionale incontrò una
rilevantissima freddezza. Ma perché avrebbe dovuto non incontrarla? I
colonizzati non si fidavano di una banca proveniente da una terra ignota,
che
dava carta in pagamento e poi mostrava molta cattiva volontà allorché era
richiesta di barattarla con l’oro o l’argento; una resistenza che era
incomprensibile nelle Due Sicilie, in quanto la carta del Banco era stimata
più
dell’oro.
Così stando le cose, perché Bombrini si accollò la spesa di un affitto e lo
stipendio degli impiegati spediti in colonia?
La gente capisce qualcosa più degli storici. A costo d’apparire noioso,
ripeto
il concetto. La Banca Nazionale – e con essa la generica borghesia
capitalistica
delle regioni toscopadane - attraverso i suoi esponenti al governo andò
perseguendo un risultato di accumulazione preliminare, che nel Sud assunse
subito il volto del saccheggio e della spoliazione selvaggia.
7.11 Nelle pubbliche carte le patriottiche oscenità bombrinesche non
figurano. Le serie storica degli incassi fatti dalla Nazionale per conto del
ministero tesoro, che qui riporto, è quella fornita dalla Banca Nazionale
alla
Commissione d’Inchiesta. Essa comprende solo gli incassi ufficialmente
delegati dallo Stato alla Banca, mediante leggi e altri atti. Per esempio
quelli
relativi alla vendita dei beni demaniali o il collocamento di alcuni
prestiti. Non
comprende, invece, gli incassi fiscali, che dovrebbero corrispondere a quasi
tutto l’ammontare delle imposte. Cionostante si tratta di una cifra elevata.
Tab.7.11a Banca Nazionale
Conto corrente con il Tesoro
Lire:
| Situazione all’1. 1. 1860 |
169.297.300 |
| Incassi 1860 |
3.04.490 |
| Ammontare all’1. 1. 1861 Incassi per il 1861 |
172.301790 23.429.380 |
| Ammontare all’ 1. 1. 1862 Incassi per il 1862 |
195.731.178 79.101.145 |
| Ammontare all’1. 1. 1863 Incassi per il 1863 |
274.832.343 128.991.412 |
| Ammontare all’1. 1. 1864 Incassi per il 1864 |
401.823.755 303.526.578 |
| Ammontare all’1. 1. 1865 Incassi per il 1865 |
705.350.333 154.490.036 |
| Ammontare all’1. 1. 1866 Incassi per il 1866 |
859.840.369 64.772.044 |
| Ammontare all’1. 1. 1867 Incassi per il 1867 |
924.612.413 94.611.437 |
| Ammontare all’1. 1. 1868 |
1.019.223.850 |
Atti II, pag. 51
Nel viluppo di bugie coniate dalla storiografia unitaria, ce n’è una che
vola
più alta delle altre: quella secondo cui il tesoro non fu un compiacente
amico
delle tresche della Banca Nazionale. Difatti nel 1851 il senato sabaudo
bocciò
il disegno di legge cavouriano che avrebbe voluto affidare alla Banca
Nazionale il servizio del tesoro. Fino al 1867 la situazione non sarebbe
stata
modificata.
La verità è che Cavour e Bombrini se ne fregarono del senato e
delle sue deliberazioni. L’andazzo fu contenuto al tempo del Regno di
Sardegna e si dispiegò pienamente solo dopo la conquista della Penisola. Le
tesorerie provinciali furono impiantate dovunque, ma solo per la bassa
cucina.
Città per città, i dipendenti periferici del ministero del tesoro portavano
il
riscosso allo sportello locale della Banca Nazionale, che lo accreditava
alla
sede centrale, e questa a sua volta, dopo averlo fatto ben lievitare, lo
accreditava al tesoro. Incassato il numerario, sia la sede centrale sia
quelle
periferiche effettuavano i pagamenti per conto del tesoro mediante biglietti
della banca ermafrodita. Nel passaggio dal Piemonte sabaudo all’Italia
liberale
– da dante causa ad avente causa - la cosa andò avanti tranquillamente e
senza smorfie di sorta da parte dei ministri delle finanze succedutisi al
governo. Essi dovevano soltanto far finta di non sapere. E debbono far finta
di
non sapere anche i nostri professori di storia. Anticipiamo una
testimonianza
resa alcuni anni dopo; una dichiarazione buttata lì a caso
Nell’ultima decade dell’aprile 1866, qualche giorno prima di decretare il
corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale, il ministro delle
finanze,
Antonio Scialoja – onde precostituirsi un alibi - chiese al direttore
generale
del tesoro se, con le disponibilità di cassa, lo Stato fosse in condizione
di far
fronte agli impegni in scadenza. L’interpellato rispose con una succinta
relazione, di cui trascrivo alcuni passi.
Primo:
“Signor Ministro,
“Mi pregio di trasmetterle, secondo il consueto, il prospetto dei fondi di
cassa del Tesoro per la seconda decina di aprile, ossia esistenti la sera
del 20
detto”.
Il prospetto dice:
Tab. 7.11b I rapporti consuetudinari tra Banca Nazionale e Ministero del
Tesoro:
| I fondi ascendono a |
112.800.000 |
| E sono così composti: |
|
| Oro e argento |
28.000.000 |
Biglietti della Banca Nazionale e della Banca
Toscana, e fedi di credito del Banco di Napoli |
68.000.000 |
| Bronzo |
15.280.000 |
Crediti in conto corrente colle Casse bancarie
estere |
1.520.000 |
| Totale |
112.800.000 |
Seconda parte della lettera:
“A primo aspetto, e nell’attuale crisi commerciale e monetaria, può far
senso che a comporre il fondo di cassa entri una massa di 68 milioni in
biglietti e fedi di credito. Il signor Ministro sa bene che si è studiato
questo
fatto ed il modo di diminuire quella massa di carta, restringendo anche, ove
fosse stato possibile, la facoltà alle Casse (alle tesorerie provinciali,
ndr) di
ricevere la carta di quegli Stabilimenti, e vi si è tornato sopra più volte
in
previsione del futuro bisogno di danaro. Ma, oltreché una restrizione
consimile, spargendo la diffidenza, avrebbe accelerata la già minacciata
crisi,
si è dovuto riconoscere che il Governo non poteva respingere le fedi di
credito
del Banco di Napoli, perché quelle debbonsi ricevere obbligatoriamente, in
forza del decreto del 12 dicembre 1816 e dell’articolo 6 degli accordi presi
in
Torino fra il Governo e il Banco il 30 maggio 1864, in compenso dell’onere
assuntosi dal Banco di anticipare al Tesoro 20 milioni in buoni del Tesoro
al 3
per cento;
doveva accettare i biglietti della Banca Toscana, in forza della legge che
approvò i suoi statuti (articolo 11 del decreto granducale 8 luglio 1857);
ed avendo sempre ricevuti come moneta quelli della Banca Nazionale
Sarda, non era possibile per essa una distinzione odiosa…”
Terzo:
“Infine esiste una convenzione del 17 marzo 1854, in forza della quale la
Banca Nazionale Sarda, in compenso delle facilitazioni per il trasporto del
suo
numerario sulle ferrovie dello Stato (sic!), fa al Tesoro gratuitamente il
passaggio dei fondi da una all’altra tesoreria, mediante mandati della
stessa banca, che non altrimenti vengono estinti che in biglietti.” (Atti
I, p. 282, 283)
Chiaro? Chiarissimo. E’ chiaro altresì che frequentemente – anzi quasi
sempre - alcuni nostrani nonché illustri storici della banca italiana
scrivono
baggianate. E purtroppo le scrivono pur sapendo che sono baggianate!
Sugli intrallazzi e le prevaricazioni di Bombrini la Commissione
parlamentare d’inchiesta fece luce, ma non affondò il coltello. E non è
difficile
capire il perché. Filippo Cordova, che ne fu il presidente, e alcuni altri
componenti, come Sella, erano stati ministri delle finanze e impareggiabili
patrioti. Additare l’illecito sarebbe stata la stessa cosa che addebitarlo
al
grande ministro, al rimpianto padre della patria cosiddetta nazionale, e a
loro
stessi.
7.12 La politica monetaria dei governi nazionali fu capace d’inventare una
classe sociale, ma non di avviare lo sviluppo. Il paese rimase inchiodato al
suo
secolare ritardo fin quando non arrivarono le rimesse dagli emigrati. La
fuga
all’estro di un terzo del paese - le classi atte al lavoro - ne è la cocente
prova.
Per trent’anni ingenti risorse vennero spostate dalla produzione (attuale e
potenziale) alla speculazione. Lo si fece attraverso l’usura sul debito
pubblico,
cedendo beni del patrimonio pubblico, creando situazioni monopolistiche a
favore dei tangentisti, elargendo capitali a imprese che si sapevano
fasulle,
persino mandando a morire decine di migliaia di persone in un’impresa
coloniale finalizzata ad arricchire un armatore genovese.
Leggiamo un’analisi prestigiosa di ciò che era avvenuto in Francia poco più
di un decennio prima (e avveniva ancora nei decenni successivi). Cambiamo i
nomi e ci troviamo di fronte all’Italia sotto quel porcilaio che furono la
Destra
e la Sinistra, entrambe storiche[14].
“Il disagio finanziario rese fin dall'inizio la monarchia di luglio
dipendente dalla grande borghesia, e la sua dipendenza dalla grande
borghesia fu la sorgente inesauribile di un crescente disagio finanziario.
Impossibile subordinare l'amministrazione dello Stato all'interesse della
produzione nazionale senza stabilire l'equilibrio nel bilancio, l'equilibrio
tra le
uscite e le entrate dello Stato. E come stabilire questo equilibrio senza
limitare le spese dello Stato, cioè senza vulnerare interessi che erano
altrettanti sostegni del sistema dominante, e senza riordinare la
ripartizione
delle imposte, cioè senza rigettare una parte notevole del peso delle
imposte
sulle spalle della grande borghesia stessa?
“L'indebitamento dello Stato era, al contrario l'interesse diretto della
frazione della borghesia che governava e legiferava per mezzo delle Camere.
Il
disavanzo dello Stato era infatti il vero e proprio oggetto della sua
speculazione
e la fonte principale del suo arricchimento. Ogni anno un nuovo disavanzo.
Dopo quattro o cinque anni un nuovo prestito offriva all'aristocrazia
finanziaria
una nuova occasione di truffare lo Stato, che, mantenuto artificiosamente
sull'orlo della bancarotta, era costretto a contrattare coi banchieri alle
condizioni più sfavorevoli. Ogni nuovo prestito era una nuova occasione di
svaligiare il pubblico, che investe i suoi capitali in rendita dello Stato,
mediante
operazioni di Borsa al cui segreto erano iniziati il governo e la
maggioranza
della Camera. In generale la situazione instabile del credito pubblico e il
possesso dei segreti di Stato offrivano ai banchieri e ai loro affiliati
nelle
Camere e sul trono la possibilità di provocare delle oscillazioni
straordinarie,
improvvise, nel corso dei titoli di Stato; e il risultato costante di queste
oscillazioni non poteva essere altro che la rovina di una massa di
capitalisti più
piccoli e l'arricchimento favolosamente rapido dei giocatori in grande.
Perché il
disavanzo dello Stato era nell'interesse diretto della frazione borghese
dominante, si spiega come le spese straordinarie dello Stato negli ultimi
anni
del governo di Luigi Filippo superassero di molto il doppio delle spese
straordinarie dello Stato sotto Napoleone, e toccassero quasi la somma annua
di 400 milioni di franchi, mentre l'esportazione media complessiva della
Francia
raggiungeva dì rado la somma di 750 milioni di franchi. Le enormi somme che
in tal modo passavano per le mani dello Stato davano inoltre l'occasione a
contratti di appalto fraudolenti, a corruzioni, a malversazioni, a
bricconate
d'ogni specie. Lo svaligiamento dello Stato, che si faceva in grande coi
prestiti,
si ripeteva al minuto nei lavori pubblici, i rapporti tra la Camera e il
governo si
moltiplicavano sotto forma di rapporti tra amministrazioni singole e singoli
imprenditori.
“Al pari delle spese pubbliche in generale e dei prestiti dello Stato, la
classe
dominante sfruttava le costruzioni ferroviarie. Le camere addossavano allo
Stato i carichi principali e assicuravano la manna dorata all'aristocrazia
finanziaria speculatrice. Sono nella memoria di tutti gli scandali che
scoppiarono alla Camera dei deputati quando il caso fece venire a galla che
tutti quanti i membri della maggioranza, compresa una parte dei ministri,
partecipavano come azionisti a quelle medesime costruzioni ferroviarie che
essi
facevano poi, come legislatori, eseguire a spese dello Stato […].
“La monarchia di luglio non era altro che una società per azioni per lo
sfruttamento della ricchezza nazionale francese, società i cui dividendi si
ripartivano fra i ministri, le Camere, 240 mila elettori e il loro seguito
[…]
.Commercio, industria, agricoltura, navigazione, gli interessi della
borghesia
industriale dovevano sotto questo sistema essere continuamente minacciati e
compromessi” (Marx, 41 e segg.).
Bisogna aggiungere che, in Italia, le risorse capitalizzate in rendita non
provenivano dai surplus di un sistema a riproduzione allargata, ma da
surplus
contadini, che, unita l’Italia, diventarono surplus da astinenza,
realizzaticon
la violenza delle armi e delle leggi di cui lo Stato sabaudo si servì senza
pregiudizi umanitari e senza alcuno spirito di solidarietà nazionale. Ci
furono
anche surplus da indebitamento – regolarmente investiti in armamenti – che,
all’atto, vennero finanziati con prestiti esteri, il cui rimborso venne
dilazionato nel tempo e patriotticamente intestato alle future generazioni,
sempre di contadini. L’espropriazione dei miseri in nome della speculazione
ebbe come contropartita l’omissione degli investimenti in agricoltura, come
venti anni dopo dimostrerà l’Inchiesta Jacini[15].
7.13 Appendice
L’inferno burocratico-fiscale in cui noi sudditi dello Stato italiano
bruciamo il
nostro lavoro ha la sua scaturigine nel fatto che l’Italia è la prosecuzione
giuridica e mentale di uno Stato - quello sabaudo - che aveva poco rispetto
per
i suoi sudditi e nessuna fiducia nei propri funzionari. Lo squallore di
quell’ente,
in cui vanamente si cercherebbe un segno di quel che i costituenti
statunitensi
scrissero nella loro costituzione – essere lo Stato in funzione della
felicità dei
cittadini - emerge con chiarezza dal confronto tra il sistema fiscale
duosiciliano
e quello sardo.
L’erario del Regno delle Due Sicilie era strutturato su cinque fonti
d’entrata
1) Imposta fondiaria
2) Dazi doganali all’entrata e all’uscita delle merci
3) Privativa sul sale, sui tabacchi, sulle carte da gioco e sulle
poveri da sparo.
4) Tassa fissa sulla registrazione e pubblicità dei negozi
giuridici
5) Monopolio del gioco del lotto.
6) Tasse sulle spedizioni postali di lettere e pacchi (i nostri
francobolli)
7) Imposte locali
Imposizione vigenti nel regno di Sardegna al momento della sua
trasformazione in Regno d’Italia:
1) Imposta fondiaria
2) Imposta sui fabbricati
3) Imposta sulla ricchezza mobile
4) Imposta di fabbricazione
5) Imposta sulle mani morte (opere pie)
6) Imposta di successione
7) Imposta sulle pensioni
8) Imposta sulle industrie
9) Imposta sulle donazioni
10) Imposta sui mutui
11) Imposta sulle doti maritali
12) Tassa fissa sulle adozioni e sulle emancipazioni
13) Dazio sul consumo di carni e di alcolici
14) Dazio sulle pelli e sui corami
15) Imposta sui tabacchi
16) Dazio sulla polvere da sparo, sul piombo e sui pallini da caccia
17) Imposta sui pesi e le misure
18) Dazio di esportazione sulla paglia, il fieno e l’avena
19) Carta bollata
20) Imposta sulle insinuazioni fallimentari
21) Imposta sulle vetture
22) Tassa sul permesso di caccia
23) Tassa sulle società
24) Tassa sanitaria
25) Imposte locali
L’elenco è difettoso. Le voci estorsive erano più di cento. Ed ecco il
commento di Nitti, tratto dall’incipit della famosa analisi sulla formazione
del
bilancio dello Stato nazionale italiano (Nitti**. pag. 39 e seg.).
“La finanza napoletana, organizzata da un uomo di genio, il cavaliere
Medici, era forse la più adatta alla situazione economica del paese. Le
entrate
erano poche e grandi e di facile riscossione.
“Base di tutto l'ordinamento fiscale era una grande imposta fondiaria. Ed
era
così bene organizzata che rappresentava un vero contrasto con il Piemonte,
dov'era assai più gravosa e di difficile riscossione : «Il sistema di
percezione
della fondiaria - dice il cavaliere Sacchi [l’inviato di Cavour a Napoli
conquistata, ndr], nella sua relazione del segretariato generale delle
finanze -,
la prima e la più importante delle risorse dello Stato, era
incontrastabilmente il
più spedito, semplice e sicuro, che si avesse forse in Italia.
«Lo Stato, senza avervi quella minuziosa ingerenza, che vi ha in Francia e
nelle antiche Province (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), ove si fece
perfino
intervenire il potere legislativo nella spedizione degli avvisi di
pagamento, avea
assicurato a periodi fissi e ben determinati l' incasso del tributo, colle
più solide
garanzie contro ogni malversazione per parte dei contabili » […]
Non vi era quasi alcuna imposta sulla ricchezza mobiliare. Poiché questa si
andava formando, il cavaliere Medici e i suoi continuatori aveano ritenuto
che
vi fosse pericolo grande a colpirla con imposte. Il commercio interno avea
ogni
agevolezza: «la ricchezza mobiliare ed il commercio in ispecie è esente in
Napoli da ogni maniera d'imposizione diretta, mentre la ricchezza
immobiliare
è gravata di un tributo, comparativamente all'entrata generale dello Stato,
assai più grave ».
[…] Le tasse del registro e del bollo, gravissime in Piemonte, erano assai
tenui nel Reame di Napoli. L'ordinamento delle fedi di credito del Banco di
Napoli, mirabilmente semplice sotto questo aspetto, rendeva inutili le
registrazioni. «Il mirabile organismo finanziero delle Province Napoletane »
dice il cav. Sacchi, si vedeva soprattutto in quanto riguardava il
funzionamento
del Banco. […] Per spiegare questa differenza si sono invocate molte cause e
molti fatti sono stati messi avanti: si è parlato perfino di razze
differenti, si è
discusso di razze inferiori e di razze superiori; quasi che ciò che è
prodotto
delle razze, cioè di natura, mutasse da un decennio all'altro.”
[1] Ma non più di questo. I soci fondatori della Nazionale, liguri e
piemontesi, continuarono ad avere la maggioranza azionaria fino alla
consunzione della società e il suo risorgimento come Banca d’Italia. A
compenso degli incommensurabili meriti degli antenati, i loro discendenti
sono
tuttora i soli soci privati della illustrissima Banca d’Italia e si pappano
il loro bel
dividendo.
[2] La giustificazione, oltre che ipocrita, è cretina. I briganti stavano
fra i
boschi e non nelle città, dove si pagavano le tasse. In effetti la Nazionale
non
inaugurava nuove sedi per fare il mestiere di banca, ma quello di tesoriere
dello Stato e incassare l’oro e l’argento dei contribuenti.
[3] Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia furono le sole banche di
diritto
pubblico (cioè dipendenti dal Tesoro) esistenti in Italia fino al dissesto
della
Banca Nazionale e alla creazione della Banca d’Italia (1894). Tra questa
data e
il 1926, in Italia si ebbero tre banche emettenti biglietti teoricamente
convertibili in oro. Ma diversamente che nei banchi meridionali, il
governatore
della Banca d’Italia non era (e non è) nominato dal governo, ma
dall’assemblea
degli azionisti, cioè dei maggiori capitalisti e dalle banche private. .
[4] La cattedra torinese di economia politica fu fondata proprio per Antonio
Scialoja. Quando questi fu eletto deputato, la cattedra passò all’esule
siciliano
Francesco Ferrara. Evidentemente i torinesi, l’economia politica,
preferivano
farla anziché insegnarla.
[5] Ignazio e Vincenzo Florio, Antonio Chiaramonte Bordonaro, Michele
Pojero, Michele Raffo, Francesco Varvaro, tutti autorizzati a sdoganare le
loro
importazioni con cambiali doganali per ben 20.000 once (pari a 60 mila
ducati,
pari a circa 250 mila lire sabaude), nonché membri della Camera Consultiva
di
Commercio, Deputati della Borsa dei Cambi, Deputati della Cassa di Sconto,
Governatori del Banco regio dei reali dominii ad di là del Faro (Giuffrida,
pag
2).
[6] A parere di chi scrive il più penetrante fra storici del Sud.
[7] Chi scrive aderisce alla tesi crociana, secondo cui l’involuzione del
paese
meridionale ha inizio con il regno normanno e l'introduzione (tardiva),
sempre
ad opera dei conquistatori normanni, del ruralismo feudale. Per volontà del
papato e ad opera delle potenze europee, specialmente della Spagna, il Sud
diventò la terra di nessuno che stava tra dette potenze e gli Arabi, presso
cui il
sistema di mercato era ancora vitale, e in seguito i Turchi, con cui si
affermò
l’involuzione del Mediterraneo orientale verso il feudalesimo orientale.
L’aristocrazia meridionale nacque in un paese in cui la rendita padronale
aveva
un forte carattere politico e in cui l’opinione pubblica era mediata dal
basso
clero. In un quadro nazionale di marcata dipendenza militare, la rendita è
legata alla grazia del potente, e non alla buona conduzione della proprietà.
La
borghesia, che nasce dal disfacimento dell’aristocrazia feudale, conserva
largamente la morale servile (o se vogliamo clientelare) di cui è impregnato
l’ambiente.
[8] In verità Cavour e i suoi epigoni conoscevano il volto morale della
proprietà cadetta e lo valorizzarono nell’interesse toscopdano. L’ammiraglio
Persano, con una spesa di circa due milioni e qualche promessa di carriera,
poté corrompere quasi tutti gli ufficiali della marina borbonica. Garibaldi,
con
una spesa di gran lunga minore, si liquidò in quattro scaramucce un esercito
di 120 uomini. I danari e le promesse corruppero persino alcuni fratelli di
Ferdinando II e zii di Francesco II, il re in trono.
[9] I governi dei grandi imperi – Spagna, Portogallo, Olanda, Francia, Gran
Bretagna – puntarono costantemente al saccheggio di oro e argento per
affermare il potere dello Stato non solo verso gli altri Stati, ma anche sui
propri sudditi. La stessa cosa del petrolio, oggi.
[10] S incontrano più dizioni: grano, grana, grani, grane, grana. Insomma
una desinenza incerta sia al singolare che al plurale.
[11] Torno a ricordare l’importanza sociale della moneta divisionaria.
L’ammontare dei salari giornalieri stava sotto le monete argentee e auree.
Per
quel che riguarda il Regno meridionale erano di regola meno di un ducato.
Nel
Regno sardo, spesso anche meno di una lira (meno di un quarto di ducato).
[12] In verità, sarebbe questo un capitolo da aprire. Infatti, le Due
Sicilie
conoscevano una forte contrapposizione politica tra padronato redditiero (e
liberale o giacobino, che dir si voglia) e popolo contadino, mentre la
posizione
regia appariva come una mediazione. Invece nella nuova (si fa per dire)
Italia,
lo Stato divenne l’agente militare della classe padronale.
[13] La stessa cosa avverrà 30/35 anni dopo con le rimesse degli emigrati.
[14] E forse potremmo spiegarci anche l’attuale porcilaio.
[15] Si dovette certamente al fatto che la classe dei massari meridionali
non partecipò all’intrallazo speculativo se, tra il 1861 e il 1887,
l’agricoltura
meridionale progredì con sorprendente velocità.
|