 |
|
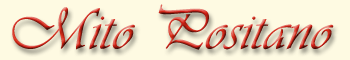 |
|
L'ARTE DEGLI
ETRUSCHI
|
|
|
|
LA STORIA, L'ARTE, IL
CULTO DEI MORTI, LA RELIGIONE, LA LINGUA |
Pagina precedente
La pittura
La pittura etrusca è il completamento dell'architettura delle
tombe. La
tecnica usata è una specie di affresco, con colori disciolti
nell'acqua che
vengono assorbiti dallo strato sottile dell'intonaco. La
pittura è
planimetrica: pochi colori, privi di chiaroscuro, distesi in
superficie,
staccati dal fondo, con la conseguente prevalenza della linea che
li
campisce, quasi come se fosse una decorazione vascolare. Quanto ai
temi,
poiché lo scopo delle figurazioni è quello di circondare il morto con
le
immagini della vita, prevalgono le scene di costume, con
musicanti,
danzatori, ginnasti, partite di caccia e di pesca. Non mancano
tuttavia le
figurazioni mitologiche, derivate dalla pittura vascolare greca o
dovute ad
artisti greci immigrati. Tra queste i più antichi affreschi sono
quelli
della Tomba dei Tori a Tarquinia, con l'agguato teso da Achille al
giovane
troiano Troilo presso la fontana sacra ad Apollo; tra le figure,
definite
linearisticamente e campite con chiari colori, compaiono fiori
stilizzati,
ed altri elementi paesistici, quali alberelli e cespugli spinosi.
Nella
tomba della caccia e della pesca a Tarquinia le figure dei
pescatori,
rappresentate con grafia semplificata e leggera, assumono un
carattere
squisitamente decorativo al pari degli uccelli e dei pesci che
popolano
sparsamente gli ampi spazi celesti e marini. Il fascino di queste ed
altre
consimili figurazioni consiste in buona parte nella
disposizione
irrealistica dei colori: secondo una convenzione derivata dalla
pittura
vascolare le figure sono tinteggiate in rosso se maschili, in bianco
se
femminili: nè mancano talvolta audaci invenzioni e arbitrii cromatici,
come
cavalli rossi ed azzurri.
Altre pitture interessanti sono quelle
della Tomba del Barone.
Sulle pareti della piccola camera funeraria sono
cavalli e figure umane,
intervallate da arboscelli. I colori (nero, rosso,
grigio, verde,
bruno-violaceo) sono stesi su un sottile velo di preparazione.
Il rapporto
fra i pieni e i vuoti è perfettamente bilanciato, così come sono
calcolati
gli equilibri fra le immagini di un lato e quelle dell'altro, le
proporzioni
delle figure fra loro e delle singole parti con tutto il
complesso. Il
disegno è sottile, raffinato, adeguato all'eleganza delle
figure. Nel IV
sec. si stringono nuovi contatti con la civiltà greca.
Lo
confermano le pitture della Tomba dell'Orco a Tarquinia fra le quali
emerge
la testa di una fanciulla della famiglia Velcha, partecipante a un
banchetto
funebre. Il fondo verde scuro, dai contorni irregolari,
rappresenta forse una
nuvola nera, richiamo all'oltretomba. Questo piano di
fondo dal colore
compatto fa risaltare il profilo puro della giovane e
permette di evitare la
tradizionale linea di contorno. Manca però il
chiaroscuro. Il valore
dell'immagine si affida al rapporto fra i due colori
fondamentali: quello del
fondo e il bianco-rosa del bel volto di profilo, le
labbra lievemente
dischiuse, il grande occhio aperto a contemplare la scena
infernale, i
capelli inghirlanditi, il collo ornato da una doppia collana.
La visione
dell'oltretomba si va facendo drammatica. A contrasto con la
fanciulla Velcha
sta l'immagine paurosa del demone Charu (Caronte), dal
colorito verdastro, il
naso adunco, la barbetta irsuta, i capelli
anguiformi, le grandi ali, il
bastone. L'aldilà non è più il luogo dove
prosegue tranquilla la vita, ma
bensì il luogo di tormenti per tutti gli
uomini.
Tomba dei
Tori:
L'agguato di Achille a Troilo
Tomba della Caccia e della
Pesca:
Scena di pesca
Tomba del Barone:
Fregio con persone e
cavalli
Tomba dell'Orco:
Testa di
fanciulla
Finalità, condizionamenti e
tendenze
L'arte etrusca nacque dalla vita quotidiana e rimase sempre
sostanzialmente
vincolata al soddisfacimento delle esigenze da quella
proposte. Essa fu
pertanto strettamente legata, da un lato, alla struttura
sociale, dall'
altro, alla sfera delle concezioni religiose e dell'ideologia
funeraria. Non
a caso, cioè non soltanto per le fortuite circostanze della
loro
conservazione e della loro riscoperta, le testimonianze che essa ha
lasciato
provengono nella stragrande maggioranza dalle aree dei santuari e da
quelle
cimiteriali. Questo significa che, tranne poche eccezioni, si trattò
di un'
arte dalle caratteristiche di tipo artigianale (o di artigianato
artistico),
con tutto quello che ciò comporta e pur tenendo presente che la
distinzione
tra arte e artigianato non sempre trova valida rispondenza nel
mondo antico.
In ogni caso, non si può parlare per l'arte etrusca di un
fenomeno autonomo
né di finalità estetiche, e solo raramente ci si trova di
fronte a
manifestazioni che si potrebbero dire di "grande arte", frutto
meditato del
lavoro di particolari individualità e opera personale di artisti
consapevoli
o di scuole ben definite e caratterizzate come tali.
Si
aggiunga il condizionamento dell'arte greca che fu sempre presente
nella
maggior parte dei temi, dei tipi, degli schemi compositivi e dei
canoni
stilistici. Al punto che, una volta superata la fase dei primordi
ancora
legata alle tradizioni d'origine preistorica o alle
suggestioni
ornamentalistiche del periodo orientalizzante, le successive fasi
di
sviluppo, a partire dal primo arcaismo e fino alla tarda età
ellenistica,
cioè dalla fine del VII secolo a quasi tutto il I secolo a.C.,
ripeterono
praticamente quelle dell'arte greca. Il condizionamento fu
tuttavia di
natura prevalentemente formale ed esteriore. Essenzialmente
decorativa,
attenta al particolare e generalmente di sapore incolto e
popolaresco; tesa
alla spontaneità e all'immediatezza, disorganica ed
espressiva, portata all'
enfatizzazione e alla tensione drammatica;
conservatrice ma anche
incostante, discontinua e incoerente: proprio per
queste sue naturali
tendenze (oltre che per la necessità di selezionare i
modelli onde adattarli
ai propri scopi), l'arte etrusca seppe trovare una sua
via di fronte all'
insegnamento dei Greci. Sicché il confronto, più che
soffermarsi sulla
qualità, riguarda la diversità degli atteggiamenti e delle
realizzazioni,
cioè il modo di reagire degli artisti etruschi alle
sollecitazioni e ai
modelli che giungevano dal mondo greco. A seconda delle
necessità e delle
epoche, e quindi in relazione alle caratteristiche delle
varie fasi dell'
arte greca. Così, dei modelli via via disponibili, gli
Etruschi alcuni li
ignorarono altri li assunsero facendoli propri e talvolta
rielaborandoli,
magari insistendo su motivi che nella stessa Grecia ebbero
scarso rilievo o
furono presto superati. Quanto ai canoni stilistici, ci
furono momenti di
consonanza e di partecipazione, come nel periodo arcaico (e
specialmente nei
confronti dell'arte ionica) del VI secolo a.C.: momenti di
ripulsa e di
rigetto o, più semplicemente, d'incomprensione, come nel periodo
classico,
tra il V e il IV secolo a.C.; momenti di sudditanza e di
pedissequa
imitazione, come nel periodo ellenistico, dal III al I secolo
a.C.
Non mancarono tuttavia atteggiamenti estranei, se non antitetici,
alle
concezioni figurative greche, soprattutto quando queste non erano
congeniali
alle tendenze espressive etrusche e quindi non sentite e
incomprese. E
furono proprio quelle tendenze, insieme alle finalità pratiche
del
quotidiano, che indussero gli Etruschi a trascurare, o a relegare in
secondo
piano, certe forme d'espressione artistica, come l'architettura e
la
statuaria, e a privilegiarne altre, come la coroplastica, ossia l'arte
della
creta, la bronzistica, a quella connessa, e le cosiddette arti minori,
come
la piccola plastica, la ceramica, l'oreficeria, la toreutica. Con
risultati
spesso di notevole perfezione tecnica e non dirado d'elevato valore
formale.
Arte profana
E' proprio nelle arti
"minori", nella vastissima produzione di
suppellettili, piccoli bronzi fusi e
piccole terracotte con funzioni
ornamentali, gemme incise e avori intagliati,
che si espresse al meglio
l'originalità e la creatività degli artisti
etruschi. Particolare attenzione
meritano gli specchi, trovati a centinaia
nelle necropoli. Il modello più
comune era quello tondo con il manico. Il
retro della suprficie di bronzo
era inciso, solitamente con soggetti
mitologici provenienti dall'arte greca,
oppure coperto di iscrizioni.
Ricchissima e meritatamente famosa anche la
produzione di monili ed oggetti
in oro, nella quale gli etruschi
dimostrarono un elevato grado di
elaborazione tecnica, capace di sfruttare
le possibilità espressive del
metallo. Il periodo di massima fioritura fu
tra la metà del VII e la fine del
VI secolo a.C., a Vetulonia e Vulci. Nella
tomba Regolini- Galassi, scoperta
a Cere nel 1832, gli archeologi si
trovarono davanti ad un gran numero di
gioielli; grandi bracciali lavorati,
fibule incise, un pettorale in oro
sbalzato di 42 cm. conservato ai musei
Vaticani.
Specchio
riproducente la cerimonia del chiodo Anche nell'orificeria trionfò
il gusto
per il sovraccarico e gli effetti enfatici, sia con l'incontro di
motivi
ornamentali vegetali, figurati e geometrici, sia con l'impiego delle
diverse
tecniche di lavorazione, spesso combinate insieme.
Tali tecniche
comprendevano l'incisione, lo sbalzo, la fusione la filigrana
e, soprattutto,
la granulazione, consistente nell'applicare sulla superficie
del metallo
piccoli granelli d'oro saldati tra loro, moltiplicando così
l'effetto
dell'incidenza della luce.
Gioielli (V-VI sec)
Collare con
teste di Sileno, VI-V sec.
I monumenti
architettonici
Ben altra ricchezza di testimonianze dirette ci si offre
per l'architettura
e per le arti figurative: si tratta infatti degli stessi
monumenti
superstiti e dei resti materiali recuperati attraverso le
scoperte
archeologiche. Nonostante la distruzione di tante opere e manufatti
antichi,
questi documenti sono tali da offrirci una visione sufficientemente
ampia
dell'attività artistica degli antichi Etruschi nelle sue tendenze e nei
suoi
sviluppi.
L'edilizia monumentale non può naturalmente valutarsi sul
metro di quella
dei Greci o dei Romani. L'impiego esclusivo di strutture
murarie a blocchi
di pietra s'incontra soltanto nelle opere militari e nelle
tombe: per il
resto, e cioè per gli edifici sacri e civili, esso appare
limitato alle
fondazioni, mentre per le parti elevate si adoperavano
materiali più
leggeri, quali il legno, il pietrame, i mattoni crudi, la
terracotta. Ciò
significa che di questi edifici non possediamo più che le
piante e qualche
elemento di decorazione; ma nonostante tutto è possibile
raffigurarcene
l'aspetto originario, sulla base dei modelli offerti dai
sepolcri rupestri e
dalle urne che ne imitano le forme o da piccole
riproduzioni di destinazione
votiva. Le strutture murarie offrono, a seconda
dei tempi, dei luoghi e
della qualità dei monumenti, una notevole diversità
di materiale e di
tecnica. Le pietre di più largo impiego sono i calcari, il
travertino, le
arenarie, il tufo, tutte di estrazione locale: l'assenza del
marmo che ha
tanta importanza nell'architettura greca, si deve al fatto che
lo
sfruttamento delle cave di Carrara non avrà inizio se non con l'età
romana.
Il genere delle murature varia dalla tecnica dei grandi blocchi
semilavorati
ed irregolari, quale si mostra, ad esempio, nella cinta di
Vetulonia, a
quella dei fini paramenti con piccoli blocchi squadrati che si
riscontra
nelle mura urbane delle Città dell'Etruria meridionale ed in
altre
costruzioni, specialmente funerarie. Ma non c'è in generale
un'evoluzione
delle strutture più rozze e primitive alle più raffinate: la
muratura
quadrata regolare si conosce e si impiega sin dalle fasi iniziali
della
civiltà etrusca; e le differenze paiono dovute piuttosto a
particolari
condizioni di materiale, di capacità delle maestranze, di fretta
nella
costruzione, ecc. Contrariamente a certe opinioni già diffuse tra
gli
archeologi, la tecnica poligonale vera e propria deve considerarsi
estranea
agli usi costruttivi degli Etruschi e tardivamente introdotta, dai
primi
coloni militari romani, nelle piazzeforti di Pyrgi, di Cosa, di
Saturnia.
L 'uso, almeno parziale, dei mattoni crudi non soltanto
nell'edilizia
domestica ma anche nell'architettura militare sembra attestato
a Roselle sin
dalla fine del VII secolo; ciò rientra nel quadro di una
tradizione
struttiva che si va sempre più rivelando diffusa nel mondo
mediterraneo
sotto l'influenza greca; ed è probabile che a questa tecnica si
riferiscano
anche le notizie sulla cinta di mattoni della città di
Arezzo.
Notevole diffusione ha in Etruria il sistema delle coperture a
falsa volta
ed a falsa cupola con filari di blocchi sovrapposti in aggetto,
di
universale diffusione mediterranea; al quale si sovrappone, nelle fasi
più
recenti, la tecnica della volta reale a spinte, che appare in porte di
città
(Volterra, Perugia) ed in monumenti sepolcrali, preludendo alle
strutture
dominanti dell'architettura romana. In questa predilezione per la
copertura
a volta l'architettura etrusca continua, perfeziona e trasferisce
in sede
monumentale motivi di antica origine orientale che l'architettura
greca
classica tende invece generalmente a respingere come elementi estranei
alla
sua rigorosa concezione rettilinea, basata sulla struttura ad
architravi.
Fra i monumenti più notevoli dell'architettura militare
ricordiamo le cinte
di Tarquinia (e tratti superstiti di quelle, simili, di
Veio, Caere, Vulci,
ecc.), Volsinii, Roselle, Vetulonia, Volterra, Chiusi,
Cortona, Perugia,
Fiesole, Arezzo. Queste opere si datano generalmente tra il
VI ed il III
secolo, con ampliamenti e rifacimenti posteriori, dato che in
generale
rimasero efficienti durante i tempi romani e in qualche caso anche
più
tardi. Nonostante la diversità delle strutture, hanno in comune il
carattere
di muraglie continue, originariamente non intrammezzate da torri:
avancorpi
e rientranze si osservano soltanto in corrispondenza delle
porte.
Queste erano forse da principio architravate; ma nei grandiosi
esempi
superstiti della Porta dell' Arco di Volterra e della Porta Marzia e
della
Porta "di Augusto" di Perugia appaiono coperte a volta e presentano
in
facciata elementi di decorazione architettonica o figurata a
rilievo.
L'aspetto antico di cinte urbane merlate e con porte ad arco ci
è
testimoniato anche da figurazioni di urne e sarcofagi.
L'architettura
funeraria si presenta con manifestazioni piuttosto eterogenee,
per il fatto
che essa rappresenta l'occasionale complemento o sviluppo
costruttivo di
tipi di sepolcri di origine od ispirazione diversa. La maggior
parte delle
tombe, anche a carattere monumentale, risulta infatti lavorata
direttamente
nella roccia sia che si tratti di vani scavati (che vanno dalle
più modeste
forme dei pozzetti e delle fosse primitive sino ai grandiosi e
complessi
ipogei con molti ambienti dell'età più matura), sia che si tratti
di
adattamenti esterni aventi l'aspetto di tumuli rotondi o corpi
quadrangolari
con terra sovrapposta o di facciate scolpite nella fronte di
declivi
rupestri. Tali opere, pur non avendo un carattere architettonico,
si
ricollegano strettamente all'architettura in quanto imitano
spesso
fedelmente le forme di edifici reali nel loro aspetto esteriore
ed
interiore, negli elementi decorativi e talvolta persino nelle
rifiniture
d'arredo e nelle suppellettili.
Frequente è però anche la
presenza di opere murarie, talvolta aggiunte ad
integrazione delle pareti e
delle coperture di roccia, altre volte
costituenti per intero il monumento.
Le camere sepolcrali costruite della
fase più antica presentano coperture a
falsa volta ed eccezionalmente a
falsa cupola (come nella tomba di Casal
Marittimo nel territorio di
Volterra, o in quella recentemente scavata presso
Quinto Fiorentino). In età
più recente si hanno tombe con volta a botte di
bella struttura (per es. la
tomba del Granduca a Chiusi e l'Ipogeo di San
Mannopresso Perugia). Il tipo
monumentale del tumulo rotondo (con tamburo
generalmente ricavato nella
roccia come a Cerveteri e costruito come a
Populonia) diviene a partire dal
V secolo assai meno frequente, ma evolve,
forse anche in contatto con
l'architettura funeraria ellenistica, verso lo
schema dei grandi mausolei
circolari romani di età imperiale quali l'Augusteo
e il Mausoleo di Adriano
(per es. la così detta "Tanella di Pitagora" di
Cortona). Non mancano
sepolcri quadrangolari informa di tempietti, per
esempio a Populonia. E va
ricordato infine anche il tipo di tomba con
basamento a zoccolo sormontato
da grandi cippi troncoconici o da obelischi,
noto soprattutto attraverso le
figurazioni dei rilievi delle urne sepolcrali,
ma attestato direttamente
fuori d'Etruria, nel così detto sepolcro degli
Orazi e Curiazi presso Albano
Laziale. Un grandioso monumento di questo tipo
con più obelischi adorni di
campane è ricordato dalle fonti antiche come
esistente a Chiusi, e
identificato con la tomba del re Porsenna. I cippi
funerari imitano in
piccolo queste forme.
L'architettura domestica e
quella religiosa hanno origini e caratteristiche
comuni. Delle forme assunte
dalla casa si tratterà più avanti parlando della
vita etrusca. Il tempio che
da principio si identifica, come nel mondo
paleo-ellenico, con la casa
rettangolare con tetto a spioventi e senza
portico (documentata da modellini
votivi e dai resti di un edificio scoperto
sull'acropoli di Veio) assume poi
forme più complesse parzialmente parallele
a quelle del tempio greco. Il tipo
che Vitruvio (de archit. IV, 7)
attribuisce agli Etruschi è caratterizzato da
una pianta di larghezza poco
inferiore alla lunghezza, con la metà anteriore
occupata dal portico
colonnato e la metà posteriore costituita da tre celle,
per tre diverse
divinità, o da una sola cella fiancheggiata da due alae o
ambulacri aperti.
Resti di monumenti scavati a Veio, a Pyrgi, ad Orvieto, a
Fiesole, a
Marzabotto dimostrano che questo schema ebbe effettivamente una
vasta e
durevole diffusione in Etruria dall'età arcaica sino a quella
ellenistica:
esso appare anche a Roma nel tempio di Giove Capitolino, la cui
prima
edificazione risale ai tempi della dinastia etrusca dei Tarquini.
Ma
senza dubbio si costruivano anche edifici sacri più vicini, nel loro
schema,
al tempio greco, e cioè con pianta rettangolare allungata e colonne
in
facciata (prostilo) o addirittura con colonnato continuo su tutti i
quattro
lati (periptero): esempi cospicui ne sono il tempio più antico di
Pyrgi e
quello dell'Ara della Regina a Tarquinia. L' originalità dei templi
etruschi
non consiste comunque tanto nella loro concezione planimetrica
quanto
piuttosto nel materiale, nelle proporzioni e nelle forme dell'alzato,
nel
genere della decorazione.
Si è già detto che, all'infuori delle fondazioni,
essi dovevano essere
costruiti di materiali leggeri, con impiego del legno
per le ossature
portanti e per la travatura. Ciò comporta uno sviluppo
relativamente
limitato in altezza (quale appunto risulta dalle misure del
tempio
"tuscanico" secondo Vitruvio), larghi intercolumni, tetto ampio con
notevole
sporgenza laterale delle gronde. La travatura lignea esige una
protezione
con elementi compatti ma leggeri: donde l'uso universale di
rivestimenti di
terracotta policroma, che si sviluppano in vivaci sistemi
decorativi
geometrici e figurati con placche di copertura longitudinale o
terminale
delle travi, cornici, ornati della estremità dei coppi (antefisse)
e delle
sovrastrutture del tetto (acroteri). Il frontone era in origine
aperto,
lasciando visibili in facciata le strutture della gabbia del tetto;
solo più
tardi si adottò il tipo del frontone chiuso, decorato con una
composizione
figurata come nei templi greci. Queste varie caratteristiche del
tempio
etrusco trovano indubbi riscontri nella primitiva architettura greca
e, come
si è detto, parziali paralleli nel tempio greco arcaico e
classico.
La differenza sta nel fatto che il tempio greco sin dal VII secolo
a;C.
tende a trasformarsi in un edificio monumentale pressoche
interamente
costruito di pietra, con una sua propria ed inconfondibile
evoluzione delle
forme architettoniche; mentre il tempio etrusco resta
sostanzialmente fedele
alle tradizioni dell'architettura lignea sino alla
piena età ellenistica,
accentuando, se mai, l'esuberanza decorativa dei
rivestimenti di terracotta.
I quali offrono, specialmente nel VI e V secolo,
varietà di concezioni e
sviluppi: per esempio nel tipo delle lastre di
copertura longitudiriale dei
travi che possono formare fregi figurati
continui a rilievo di ispirazione
greco-orientale (così detta "prima fase" o
"fase ionica") o possono invece
presentare una semplice ornamentazione
dipinta con forte sviluppo della
sovrastante cornice in aggetto, come nei
sistemi decorativi fittili della
Grecia propria e delle colonie dell'Italia
Meridionale e della Sicilia
("seconda fase" o "fase arcaica"). Quest'ultimo
tipo si afferma a partire
dalla fine del VI secolo, in coincidenza con il
momento di maggiore
splendore dello sviluppo dei templi etruschi,
caratterizzato anche dalle
antefisse a conchiglia, dalle decorazioni
frontonali a rilievo distribuite
sulle placche di rivestimento delle testate
dei travi lunghi, dai grandi
acroteri figurati: esempi caratteristici il
tempio di Veio e i templi di
Pyrgi. Lo schema decorativo così formato sarà
poi seguito con poche
modificazioni nei secoli successivi.
La sola
novità rilevante è l'introduzione del frontone chiuso decorato con
una
composizione figurata unica alla maniera greca, di terracotta e
in
altorilievo; esso appare già forse nel V secolo, ma ci è noto soprattutto
a
partire dal IV secolo a Tarquinia, a Talamone, a Luni ("terza fase" o
"fase
ellenistica"). Parlando delle forme e dei rivestimenti del tempio
etrusco,
non si può trascurare il fatto fondamentale che i medesimi caratteri
e
sviluppi si riscontrano nei templi del territorio falisco e laziale e,
sia
pure con qualche differenza, in Campania: può parlarsi di una comune
civiltà
architettonica dell'Italia tirrenica a settentrione dell'area
direttamente
toccata dalla colonizzazione greca. L'affermarsi del tipo del
tempio di
pietra, in sostituzione delle tradizionali strutture lignee
(sotto
l'influsso greco, ma pur sempre con forme peculiari), avrà
luogo
progressivamente, sotto l'influsso dei modelli greci, nel corso del
IV
secolo e dell'età ellenistica.
Il predominio di elementi di ispirazione
arcaica anche in opere di età molto
recente si osserva del resto in tutti i
motivi della decorazione
architettonica etrusca, quali appaiono nelle
costruzioni di pietra ed in
quelle di legno e terracotta, e nelle loro
innumerevoli riproduzioni ed
imitazioni dell'arte funeraria e votiva.
Vitruvio parla di un "ordine
tuscanico" distinto dagli ordini dorici, ionici
e corinzio dell'architettura
greca. Esso era caratterizzato da un tipo di
colonna che si vede
effettivamente impiegato nei monumenti romani e
rappresenta una variante
della colonna dorica, con la stessa forma di
capitello ma con il fusto
liscio e con un basamento. La sua origine etrusca è
provata da testimonianze
che risalgono all'età arcaica: di questa forma era,
verisimilmente, la
maggior parte delle colonne lignee dei templi e degli
edifici civili. Si
tratta in realtà di una sopravvivenza ed elaborazione del
tipo detto
"protodorico" (fornito di plinto sagomato, con fusto senza
scanalature e
sensibilmente rigonfio, con capitello a cuscino bombato), che
nel mondo
greco primitivo era stato prestissimo sostituito dalla colonna
dorica vera e
propria. Ma accanto a questo tipo vediamo diffuso in Etruria
anche un genere
di colonne e di pilastri con capitello a volute floreali,
semplici e
composite, che trova la sua ispirazione nei capitelli
orientali
siro-ciprioti e nei capitelli così detti "eolici" della Grecia
orientale:
genere, anch'esso, precocemente scomparso nel mondo greco, con
l'affermarsi
del capitello ionico.
Modanature di impronta arcaica, con
dadi, cordoni, "campane", "gole",
appaiono dominanti nella sagoma di
basamenti e coronamenti di edifici,
altari, cippi, ecc. ; mentre la
incorniciatura di porte e di finestre
sottolinea gli stipiti sui lati del
vano rastremato verso l'alto e il
sovrapposto architrave sporgente che, in
epoca più evoluta, si piega alle
estremità nelle caratteristiche
"orecchiette". L'ornamentazione non figurata
delle cornici, dei coronamenti e
degli altri elementi delle sovrastrutture
degli edifici appare domi!lata da
motivi a foglie stilizzate, trecce,
palmette e fiori di loto, spirali,
meandri, ecc., di prevalente ispirazione
ionica. Il sistema del fregio dorico
con metope alternate a triglifi sembra
diffondersi soltanto dopo il IV
secolo; ma spesso, in luogo dei triglifi,
s'incontrano veri e propri
pilastrini.
Il problema dell' «arte
etrusca»
Considerate le diverse categorie di monumenti artistici, resta
da affrontare
il problema più grosso, il «problema» per eccellenza: quello
del loro
significato estetico e storico. Gran parte delle opere che
possediamo non
ha, ovviamente, il carattere di creazione originale: rientra
nel solco di
tradizioni artigianali e riflette soltanto alla lontana le
grandi linee di
sviluppo della storia dell'arte. Ma esistono alcuni monumenti
e gruppi di
monumenti, nei quali si può ritenere presente l'impronta di una
certa
personalità artistica, più o meno spiccata. Si tratta di stabilire fino
a
che punto questa possibilità risponda a realtà, e cioè se veramente ci
si
trovi, in questi casi, di fronte a piccole o grandi creazioni; o invece
si
abbia pur sempre a fare con semplici imitazioni di modelli; ed in
quale
ambiente debbano eventualmente ricercarsi questi modelli.
Il fatto
più evidente è che la stragrande maggioranza dei temi, dei tipi,
degli schemi
compositivi della produzione artistica etrusca trova i suoi
precedenti e la
sua ispirazione nel mondo greco; e che tale dipendenza si
estende normalmente
anche alle forme stilistiche; cosicche lo sviluppo
dell'arte in Etruria, dal
primo arcaismo sino alla tarda età ellenistica,
ripete sostanzialmente le
fasi di sviluppo dell'arte greca. Però si notano
anche differenze: nel senso
che l'Etruria ignora certi motivi della
produzione ellenica ed elabora invece
diffusamente altri che in Grecia hanno
scarso rilievo o appartengono a fasi
stilistiche già superate; ne mancano
indizi di atteggiamenti estranei, se non
addirittura antitetici, alle
concezioni figurative greche.
C'è da
chiedersi se e fino a che punto gli artisti etruschi abbiano inteso
reagire e
di fatto abbiano reagito, con soluzioni originali, alle dominanti
formule
greche. C'è da chiedersi poi se, realizzando una loro propria
visione
artistica, essi abbiano creato le premesse al formarsi di tradizioni
locali
distinte dall'arte greca; e su quale ampiezza e per quale durata
queste
tradizioni abbiano avuto la possibilità di imporsi. In altre parole,
posta
l'esistenza di spunti autonomi nella produzione-etrusca, ci domandiamo
se
tali spunti siano fatti effimeri e slegati o se esista tra loro
una
connessione; e se un'ipotetica «costante» nelle tendenze del gusto
in
Etruria attraverso i secoli debba attribuirsi a continuità storica
o
piuttosto ubbidisca ad una profonda predisposizione del popolo etrusco
verso
orientamenti espres- sivi differenti da quelli del popolo greco.
Questi
diversi interrogativi si riassumono, tutto sommato, in uno solo: fino
a che
punto ed in che senso possiamo parlare della esistenza di un' ,
'arte
etrusca"?.
La posizione della critica nel secolo XIX fu, in
proposito, negativa. La
produzione etrusca era da considerare come un
fenomeno provinciale dell'arte
greca, con opere rozze e senza valore; mentre
ogni trovamento di un qualche
pregio artistico fatto in Etruria si attribuiva
senz'altro a mano greca. Ma
i nuovi orientamenti della critica e della storia
dell'arte, affermatisi col
principio del nostro secolo specie a seguito degli
studi di A. Riegl,
riconoscendo piena validità di espressione ad esperienze
artistiche diverse
da quella classica, aprirono la strada ad una comprensione
di fenomeni
stilistici del mondo antico per l'innanzi sottovalutati, quale
appunto
l'etrusco. Dall'analisi di singole opere d'arte di recente scoperta
(come
l'Apollo di Veio, come il "Bruto Capitolino") si arrivò, più o
meno
cautamente, ad affermare l'originalità e l'autonomia dell'arte
etrusca
rispetto alla greca, per una sua diversa ed inconfondibile visione
della
forma. che trasoarirebbe evidente anche nell'imitazione degli schemi e
dei
tipi ellenici. Si parlò, in vero, addirittura di una peculiare
disposizione
dei popoli italici (non soltanto, quindi, degli Etruschi, ma più
tardi anche
dei Romani) a concepire la realtà secondo una immagine
«illusionistica»,
«inorganica», immediata e fortemente individualizzata, di
contro alla
visione «naturalistica», «organica», «tipica» dell'arte greca. A
questi
punti di vista non sono mancate obiezioni critiche di un certo peso.
Più di
recente si è tornati anzi ad affermare che non esistono in Etruria
vere
opere d'arte se non sotto la diretta influenza delle forme greche; e che
la
«originalità» etrusco-italica si riduce a manifestazioni effimere
di
colorita abilità artigiana e popolaresca, incapaci di dar vita ad
una
tradizione (R. Bianchi Bandinelli).
Il problema, dunque, resta ancora
sostanzialmente aperto. Ma forse esso fu
male impostato così dai negatori
come dai sostenitori della originalità
dell'arte etrusca. Si considerò
infatti generalmente questo fenomeno in
blocco, senza tener conto che esso
abbraccia manifestazioni quanto mai
varie, per la durata di almeno sette
secoli, e che le trasformazioni
avvenute nel corso di un così lungo periodo
non riguardano soltanto
l'Etruria e la Grecia, ma hanno una portata decisiva
per tutto lo sviluppo
dell'arte antica. È evidente che le prospettive mutano
a seconda dei tempi;
e parrebbe quindi logico esaminare il problema
dell'«arte etrusca»
riportandoci alla situazione di ciascun periodo,
piuttosto che cercarne
astrattamente una soluzione complessiva.
Risulterà
così che alle origini, più o meno tra il IX e il VII secolo,
l'attività
artistica dei centri etruschi si svolge parallela a quella di
altri paesi
mediterranei, compresa la Grecia, in un fluido e complicato
accavallarsi di
motivi di tradizione preistorica (specialmente evidenti nel
vivace realismo
della piccola plastica) e di influenze orientali che
caratterizzano quella
fase del gusto decorativo che chiamiamo appunto
orientalizzante. È chiaro che
per questi periodi non è ancora il caso di
parlare di subordinazione all'arte
greca. Diremo piuttosto che l'Etruria
partecipa, nella sua posizione
periferica verso occidente, alla estrema
elaborazione di un'antica esperienza
artistica mediterranea, pa!allelamente
alla Grecia. Ma fatta eccezione per
qualche spunto di originalità nella
plastica funeraria (per esempio nelle
espressive teste dei canopi di
Chiusi), non vi è nessun accenno al formarsi
di una valida tradizione
artistica locale, o nazionale. Qui appunto sta la
differenza decisiva,
gravida di sviluppi futuri, rispetto alla Grecia che,
precisamente in questa
età cruciale, andava superando con vigoroso impeto
creativo le formule del
vecchio mondo ed aprendo una nuova pagina nella
storia dell'arte universale.
Non sorretta da una propria tradizione,
fatalmente l'Etruria era destinata a
cadere nell' orbita della esperienza
artistica greca, la cui capacità di
attrazione, oltreche nel fascino
innovatore e nella intrinseca superiorità
di valori estetici, consisteva
anche nella sua amplissima diffusione
territoriale dalla madrepatria alle
colonie d'Italia e di Sicilia. Ciò
avvenne effettivamente almeno dagli inizi
del VI secolo; e dobbiamo ritenere
che le influenze dell'arcaismo greco
sull'Etruria nel campo artistico non
consistessero soltanto nella
importazione di oggetti e di modelli, ma anche
nella diretta attività di
artefici greci nelle città etrusche. Eppure
proprio in questo periodo, nel VI
e nei primi decenni del V secolo, la
produzione d'arte in Etruria si
manifesta con un rigoglio meraviglioso e,
per certi aspetti, insuperato,
nell'architettura templare, nella plastica,
nella bronzistica, nella pittura,
negli oggetti «minori» decorati: con opere
numerosissime, di tecnica
raffinata e di alto livello stilistico, non prive
di un certo «carattere»
peculiare che le rende sovente riconoscibili come
prodotti etruschi o di
ambiente etrusco. Il dilemma originario (dipendenza o
autonomia ?) si propone
qui ora con aspetti tanto più delicati, quanto più i
fatti sembrano condurre
verso un giudizio apparentemente contraddittorio,
che giustifica le
incertezze dei critici moderni: nel senso che queste opere
pur essendo
«etrusche» non cessano per ciò stesso di esser «greche».
Affermazione che
potrebbe sembrare paradossale; ma non lo è, purche ci si
sforzi di
sbarazzarci dello schema mentale di «arte nazionale», che nel
caso
particolare non è applicabile.
Dobbiamo in verità tener presente che
l'arte greca arcaica non rappresenta
un fenomeno rigidamente unitario e
stilisticamente conseguente; bensì
piuttosto il risultato della elaborazione
locale di centri quanto mai vari,
numerosi e dispersi nello spazio, con
correnti vivaci, multiformi, mutevoli
che si diffondono, si trasmettono,
s'intersecano. In questo quadro,
essenzialmente regionalistico, trovano posto
anche territori parzialmente
ellenizzati o non greci ma sotto l'influenza
della civiltà greca: quali, ad
esempio, in oriente Cipro, la Licia, la Caria,
la Lidia, la Frigia, a
settentrione la Macedonia e la Tracia, in occidente
l'Etruria. Questi paesi
non sono soltanto «province» recettive che subiscono
passivamente l'impronta
delle creazioni del genio greco; ma partecipano essi
stessi, come «regioni»
di una vasta comunità civile, alla elaborazione
dell'arte arcaica, secondo
le circostanze, le particolari esigenze, le
capacità: e pertanto con proprie
caratteristiche nell'ambito della più vasta
unità periellenica. Nel caso
dell'Etruria le peculiarità «regionali» della
produzione d'arte arcaica
potrebbero indicarsi nei seguenti motivi
principali:
1) esigenze religiose e funerarie che predispongono
l'attività
figurativa ad una rappresentazione concreta, immediata, veristica
della
realtà;
2) sensibili persistenze di schemi, tecniche e
tradizioni formali
della precedente fase «mediterranea» ed
orientalizzante;
3) relazioni dirette e fortissime con le
esperienze artistiche
del mondo greco-orientale, e cioè dei centri eolici e
ionici delle coste e
delle isole dell' Asia Minore occidentale: tali da
determinare per molti
decenni (fra la metà del VI e il principio del V
secolo) quella impronta,
sostanzialmente unitaria, della cultura figurativa
in Etruria che suoI
definirsi appunto come arte
ionico-etrusca;
4) manifestarsi, nell'ambito dell'attività
artistica locale, di
rilevanti personalità, di artisti greci e locali e di
scuole di alto livello
(bronzisti di Vulci e di Perugia, pittori come il
maestro della Tomba del
Barone a Tarquinia, modellatori in terracotta di Veio
come l'artefice
dell'«Apollo» e i suoi seguaci, ecc.), cui difficilmente
potremmo negare una
autentica, origi- nale ed a volte vigorosissima genialità
creativa.
La prospettiva storica muta completamente nella prima metà del
V secolo. La
Grecia passa dall'arte arcaica all'arte classica con un processo
di
fondamentale importanza per la storia della civiltà umana. Ma l'attività
dei
grandi maestri greci tende a farsi stilisticamente più serrata, acquista
un
carattere più «nazionale», si concentra specialmente attorno ad Atene e
alle
città del Peloponneso. Anche per motivi d'ordine politico-economico
le
regioni periferiche declinano. L'Etruria resta isolata. Lo spirito
della
classicità, in quanto realtà di un momento creativo irripetibile
ed
inimitabile, non trova rispondenza del mondo etrusco, dove, tra l'altro,
le
felici condizioni storiche che avevano favorito la fioritura
artistica
dell'arcaismo sono venute a cessare, con l'inizio di un lungo
periodo di
depressione e di decadenza. Vediamo così per tutta la durata del
Ve fino
all'inoltrato IV secolo perdurare motivi e formule di tradizione
arcaica o
ispirate all'arte greca di "stile severo", cioè della fase di
passaggio
dall'arcaismo alle forme classiche. Il fenomeno dell'attardamento
proprio
dei paesi marginali (come, ad esempio, nella contemporanea arte
«subarcaica»
di Cipro) si manifesta con una certa evidenza. La penetrazione
delle
influenze classiche è parziale e stentata. In questo ambiente privo di
una
tradizione unitaria ed accreditata, come già nella fase delle origini,
la
vitalità artistica si palesa soltanto in qualche effimero spunto
di
originalità espressiva; mentre nel campo della tecnica artigiana
continua,
particolarmente attiva, la produzione dei bronzisti.
Una intensa
ripresa di contatti artistici fra Grecia ed Etruria ha luogo a
partire dal IV
secolo e si continua per tutta l'età ellenistica,
confondendosi alla fine con
il fenomeno, altrimenti ben noto, del trionfo
dell'ellenismo nell'Italia
romana della fine della repubblica e del
principio dell'impero. Ma
l'atteggiamento dei figuratori etruschi rispetto
all'arte greca non sembra
più quello dei tempi arcaici. Non si può più
parlare della elaborazione, in
qualche modo originale di un patrimonio
comune: si tratta piuttosto della
imitazione, più o meno fedele e riuscita,
di modelli «stranieri». Non si
accolgono soltanto forme e singoli motivi
tipologici, ma si riproducono
intere composizioni, specialmente da prototipi
della grande pittura, ad
ornamento di edifici e di oggetti. Per quest'ultima
fase di produzione
potrebbe giustificarsi il concetto dell'Etruria come
«provincia» del mondo
greco (ciò che equivale alla negazione di una sua
originalità
artistica).
Occorre però tener conto di un altro aspetto, completamente
diverso e di
gran lunga più importante, dell'attività figurativa etrusca di
età
ellenistica. In singoli monumenti o in gruppi di opere,
specialmente
dell'arte funeraria, vediamo aparire motivi e soluzioni
stilistiche
decisamente contrastanti con il gusto classico: strutture
compatte e
geometrizzanti, forme «.incompiute», sproporzioni, esasperazioni
di
particolari espressivi, ecc. Ci si può chiedere se e fino a che punto
queste
manifestazioni siano da spiegare come sopravvivenze artigianali di
remote
formule arcaiche, favorite dall'immobilismo rituale del mondo
religioso
etrusco, o come improvvisazioni popolaresche senza conseguenze,
o
addirittura come casuali effetti di una tecnica manuale scadente. Ma si
può
anche pensare a riflessi seppure indiretti dell'attività di artisti
che,
accogliendo antichissime assuefazioni locali e reagendo ai modelli
greci
secondo il proprio temperamento, abbiano tentato nuove forme di
espressione.
Questa ipotesi diventa certezza nel campo della ritrattistica,
che ci si
rivela con au- tentiche ed originali opere d'arte (grandi bronzi,
pitture,
ecc.) e con innumerevoli prodotti secondari (coperchi di
sarcofagi,
terrecotte), i quali mostrano a loro volta il formarsi di una
salda
tradizione locale attorno all'attività dei maestri maggiori.
In
contrasto con il ritratto greco, al quale pure originariamente si ispira
(nel
IV secolo) e talvolta si richiama (nel corso dell'età ellenistica),
il
ritratto etrusco tende a realizzare il massimo della concretezza
espressiva
per ciò che concerne le fattezze e, in un certo senso, anche il
«carattere»
individuale, prescindendo dalla coerenza organica delle forme
naturali, ma
accentuando gli elementi essenziali attraverso l'impiego
semplice, rude,
discontinuo e a volte violento delle linee o delle
masse.
Con questo possiamo dire che è nato un nuovo stile, una nuova
tradizione
artistica, effettivamente definita ed autonoma rispetto al mondo
greco: una
tradizione che è «etrusca», ma anche, più genericamente «italica»,
perchè il
suo sviluppo si continua, di là dal tramonto dell'Etruria come
nazione,
nell'arte dell'ltalia romana e del mondo occidentale sotto l'impero.
Tale
visione «espressionistica» della realtà, specialmente nel ritratto, ma
anche
in altri temi d'arte, perdurerà vitale nelle correnti di produzione
popolare
dei primi secoli dell'impero, si diffonderà nell'arte provinciale
europea,
riaffiorerà impetuosamente nella grande arte romana aulica della
fine del II
e del III secolo d.C., costituirà una delle componenti più
significative
della civiltà artistica della tarda antichità e del
medioevo.
La Religione
Introduzione
Il pantheon etrusco
Lo
spazio sacro
L 'al di là
Forme del culto
Il culto degli dei e dei
defunti
La ''disciplina etrusca"
L'interpretazione dei fulmini e delle
viscere
L'osservazione dei prodigi
Libri Fulgurales
L'arte della
divinazione
Il rito di fondazione
Le pratiche rituali
Il rituale
funerario
Il culto dei morti
Introduzione
Gli autori
latini erano concordi nel definire gli etruschi un popolo
religiosissimo
esperto nell'arte divinatoria. Ebbero infatti un'articolata
letteratura
religiosa, oggi purtroppo irrimediabilmente perduta. Esistevano
una serie di
rigide regole che determinavano il rapporto tra gli dèi e gli
uomini (quella
che costituiva la ''disciplina etrusca", ossia scienza
etrusca), quindi sul
rito e sull'interpretazione della volontà divina. Di
queste norme possiamo
farci solo un'idea attraverso alcuni passi di
Cicerone, Plinio il Vecchio,
Livio o Seneca (che si rifacevano a traduzioni
che non ci sono pervenute) e
tramite rarissimi documenti etruschi come la
"mummia di Zagabria" o il
"fegato di Piacenza". Sappiamo inoltre che quella
etrusca fu una religione
rivelata attraverso le profezie di esseri superiori
come il fanciullo Tagete
e la ninfa Vegoe o Vegonia. Fra gli etruschi delle
origini la divinità appare
sempre in modo molto impreciso, sia nell'aspetto
che nelle mansioni ed è
ragionevole pensare che in principio vi fosse
un'unica entità divina che si
manifestava in molteplici modi, assumendo
connotati diversi. Tra l'VIII e il
VI secolo a.C. si assiste alla
trasformazione della religione etrusca. Dalla
Grecia vennero importate in
Etruria nuove divinità; quelle indigene assunsero
figura umana e col tempo
ereditarono le caratteristiche e le mansioni degli
dèi dell'Olimpo classico.
Il pantheon etrusco
Le
più antichità divinità degli etruschi rappresentavano le forze della
natura,
distruttrici e creatrici al tempo stesso: Tarconte era il dio della
tempesta,
distruttore ma anche dispensatore di benefica pioggia; Velka era
il dio del
fuoco e, insieme, della vegetazione. Sommo dio dell'Etruria -
dice Varrone -
era Velthune (in latino Vertumnus o Voltumna), il multiforme,
che
rappresentava l'eterno mutare della stagioni ed era adorato nel
santuario
federale di Volsinii. All'antico pantheon appartenevano anche gli
dèi Selvans
(Silvano) e Ani (poi Giano) e la dea Northia, divinità
probabilmente del
fato. Dal VII secolo a.C. molte divinità di fondo
originariamente etrusco
vennero assimilate agli dèi olimpici: la divinità
superiore Tinia (o Tin),
rappresentata sempre col fulmine, fu l'equivalente
di Zeus ossia Juppiter
(Giove); lo stesso avvenne con Uni, compagna di
Tinia, che divenne Hera,
ossia la Iuno latina (Giunone). Turan, la dea
dell'amore, fu assimilata ad
Afrodite e quindi alla Venus (Venere) latina;
Menerva ad Athena (Minerva);
Maris ad Ares (Marte); Nethuns a Poseidon
(Nettuno); Turms a Hermes
(Mercurio); Fufluns a Dionisio (Bacco); Sethlans a
Efesto (Vulcano); di
Castor e Pollux (Castore e Polluce, i Dioscuri)
diventati Castur e Pultuce,
ecc.. Ci furono anche dèi nuovi, importati
direttamente dal mondo greco, che
conservarono il loro nome appena
etruschizzato: Artemis (ossia Diana) divenne
Aritimi, Apollon (Apollo) fu
chiamato Apulu, Heracles (Ercole) cambiò in
Hercle. Controversa è l'origine
etrusca delle ''triadi" che conosciamo con
certezza soltanto nel mondo
romano: non è chiaro se la triade capitolina
Giove-Giunone-Minerva
corrisponda a Tinia-Uni-Menerva. Di sicura origine
greca sono invece le
coppie (''diadi"), come quella degli dèi infernali Ade e
Persefone (in
etrusco Aita e Phersipnai).
Gli Etruschi credevano
nell'ineluttabilità del destino, al limite potevano
solo rendere più
piacevole la loro permanenza terrena, per questo motivo
compivano feste e
riti magici. Credevano nell'aldilà, in particolare nell'
inferno, che aveva
una porta di accesso, detta mundus, sorvegliato dalla
terribile figura del
demone Tuchulcha, mostro con orecchie d'asino, il muso
di avvoltoio e i
capelli fatti da serpenti. Questa figura fa maggiormente la
sua presenza
nella fase di declino della cultura etrusca, caratterizzata
dalla presenza di
morte e persecuzioni.
Il demone degli inferi era Charun, che accompagna i
morti nell'aldilà, da
cui si rievoca la figura di Caronte, portava indosso un
mantello ed aveva in
mano un martello, simile a quello impiegato oggi per la
sepoltura del Papa,
con il quale si tocca tre volte la tempia del pontefice
defunto. Un gioco
funebre caratteristico è quello legato al mito di Phersu,
da cui ha origine
la parola "persona", che aizza un cane contro una persona
con la testa
coperta da un sacco, che lentamente viene legata. Il cane sbrana
la persona
e sta a testimoniare l'ineluttabilità del destino. Le tombe
rappresentavano
le scene di vita quotidiana: gioia, feste, pranzi e, negli
ultimi anni,
dolore e terrore. Adottarono un calendario introdotto dai
Tarquini, con
influenze mesopotamiche, e poi modificato da Cesare, con
l'aiuto sempre di
tirreni. In esso si ricordavano feste e appuntamenti sacri.
Suddivisero la
loro era in dieci saeculum dopo dei quali ci sarebbe stata la
fine della
civiltà tirrenica, come in realtà fu confermato dalla
storia.
Lo spazio sacro
Lo spazio "sacro",
orientato e suddiviso, risponde ad un concetto che in
latino si esprime con
la parola templum. Esso riguarda il cielo, o un'area
terrestre consacrata -
come il recinto di un santuario, di una città, di
un'acropoli, ecc. -, ovvero
anche una superficie assai più piccola (ad
esempio il fegato di un animale
utilizzato per le pratiche divinatorie),
purchè sussistano le condizioni
dell'orientamento e della partizione secondo
il modello celeste.
L'orientamento è determinato dai quattro punti
cardinali. congiunti da due
rette incrociate, di cui quella nord-sud era
chiamata cardo (con vocabolo
prelatino) e quella est-ovest decumanus nella
terminologia dell'urbanistica e
dell'agrimensura romana che sappiamo
strettamente collegate alla dottrina
etrusco-italica.
Posto idealmente lo spettatore nel punto d'incrocio
delle due rette, con le
spalle a settentrione, egli ha dietro di se tutto lo
spazio situato a nord
del decumanus. Questa metà dello spazio totale si
chiama appunto «parte
posteriore» (pars postica). L'altra metà che egli ha
dinnanzi agli occhi,
verso mezzogiorno, costituisce la «parte anteriore»
(pars antica). Una
analoga bipartizione dello spazio si ha nel senso
longitudinale del cardo: a
sinistra il settore orientale, di buon auspicio
(pars sinistra o
jamiliaris); a destra il settore occidentale, sfavorevole
(pars d extra o
hostilis). La volta celeste, così orientata e divisa,
s'immaginava
ulteriormente suddivisa in sedici parti minori, nelle quali
erano le
abitazioni di diverse divinità. Questo schema appare riflesso nelle
caselle
del bordo esterno (appunto in numero di sedici) e nelle caselle
interne (ad
esse corrispondenti, seppure in maniera non del tutto chiara) del
fegato di
Piacenza. Tra i numi dei sedici campi celesti, citati da M.
Cappella, e i
nomi divini in scritti sul fegato esistono indubbie
concordanze, ma non una
corrispondenza assoluta, perche l'originaria
tradizione etrusca pervenne
presumibilmente alterata nelle fonti del tardo
scrittore romano, con qualche
spostamento nelle sequenze. Ciò nonostante è
possibile ricostruire un quadro
approssimativo del sistema di ubicazione
cosmica degli dèi secondo la
dottrina etrusca. Esso ci mostra che le grandi
divinità superiori,
fortemente personalizzate e tendenzialmente favorevoli,
si localizzavano
nelle plaghe orientali del cielo, specie nel settore
nord-est; le divinità
della terra e della natura si collocavano verso
mezzogiorno; le divinità
infernali e del fato, paurose ed inesorabili, si
supponevano abitare nelle
tristi regioni dell'occaso, segnatamente nel
settore nord-ovest, considerato
come il più nefasto.
La posizione dei
segni che si manifestano in cielo (fulmini, volo di
uccelli, apparizioni
prodigiose) indica da qual nume proviene agli uomini il
messaggio e se esso è
di buono o di cattivo augurio. Indipendentemente dal
punto di origine, una
complicata casistica riguardante le caratteristiche
del segnale (per esempio
la forma, il colore, l'effetto del fulmine, o il
giorno della sua caduta)
aiuta a precisarne la natura: se si tratti cioè di
un richiamo amichevole, o
di un ordine, o di un annuncio senza speranza e
così via. Lo stesso valore
esortativo o profetico hanno le speciali
caratteristiche presentate dal
fegato di un animale sacrificato, preso in
esame dall'aruspice, secondo una
corrispondenza delle sue singole parti con
i settori celesti. Così l'«arte
fulguratoria» e l'aruspicina, le due forme
tipiche della divinazione etrusca,
appaiono strettamente collegate; ne fa
meraviglia che esse possano essere
state esercitate da un medesimo
personaggio, come quel L. Cafatius di cui si
rinvenne a Pesaro l'epitafio
bilingue e che fu appunto haruspex (in etrusco
netsvis) e fulguriator (cioè
inrerprete dei fulmini: in etrusco trutnvt
frontac o trutnvt?). Uguali norme
devono aver presieduto all'osservazione
divinatoria del volo degli uccelli,
come intravvediamo specialmente da fonti
umbre (Tavole di Gubbio) e latine.
A tal proposito ha speciale importanza lo
spazio terrestre d'osservazione, e
cioè il templum augurale, con il suo
orientamento e le sue partizioni, cui
senza dubbio si ricollega la
disposizione non soltanto dei recinti sacri, ma
dello stesso tempio vero e
proprio, cioè l'edificio sacro contenente il
simulacro divino, che in Etruria
appare di regola orientato verso sud o
sud-est, con una pars antica che
corrisponde alla facciata ed al colonnato
ed una pars postica rappresentata
dalla cella o dalle celle. E del pari le
regole sacre dell'orientamento si
osservano (almeno idealmente) nella
planimetria delle città (concreto esempio
monumentale è Marzabotto in
Emilia), e nella partizione dei campi.
In
tutte queste concezioni e queste pratiche, come in generale
nelle
manifestazioni rituali etrusche, si ha l'impressione, come già
accennato, di
un abbandono, quasi di una abdicazione dell'attività spirituale
umana di
fronte alla divinità: che si rivela nella duplice ossessione
della
conoscenza e dell'attuazione della volontà divina, e cioè da un lato
nello
sviluppo delle pratiche divinatorie, da un altro lato nella
rigida
minuziosità del culto. Così anche l'adempimento o la violazione delle
leggi
divine, nonche le riparazioni attuate attraverso i riti espiatorii,
sembrano
essere soprattutto formali, al di fuori di un autentico valore
etico,
secondo concezioni largamente diffuse nel mondo antico, che però
appaiono
soprattutto accentuate nella religiosità etrusca. Ma è possibile che
almeno
gli aspetti più rigidi di questo formalismo si siano definiti soltanto
nella
fase finale della civiltà etrusca, e precisamente nell 'ambito di
quelle
classi sacerdotali le cui elaborazioni rituali e teologiche trovarono
la
loro espressione nei libri sacri, forse favorite dal desiderio dei
sacerdoti
stessi di accentrare nelle loro mani l'interpretazione della
volontà divina
e quindi la direzione della vita spirituale della
nazione.
Un altro aspetto, che si ricollega alla mentalità primitiva degli
Etruschi,
è l'interpretazione illogica e mistica dei fenomeni naturali,
che
persistendo sino in età molto recente viene a contrastare in
maniera
drammatica con la razionalità scientifica dei Greci. A questo
riguardo è
particolarmente significativo e rivelatore un passo di Seneca
(Quaest. nat.,
II, 32, 2) a proposito dei fulmini: Hoc inter nos et
Tuscos...interest: nos
putamus, quia nubes collisae sunt, fulmina emitti,.
ipsi existimant nubes
collidi, ut fulmina emittantur," nam, cum omnia addeum
referant, in ea
opinionesunt, tamquam non, quiafactasunt, significent, sed
quia
significatura sunt, fiant. (La differenza fra noi [cioè il
mondo
ellenistico-romano] e gli Etruschi... è questa: che noi riteniamo che
i
fulmini scocchino in seguito all'urto delle nubi; essi credono che le
nubi
si urtino per far scoccare i fulmini; tutto infatti attribuendo
alla
divinità, sono indotti ad opinare non già che le cose abbiano un
significato
in quanto avvengono, ma piuttosto che esse avvengano perche
debbono avere un
significato...).
L 'al di
là
La mistica unità del mondo celeste e del mondo terrestre si
estende
verisimilmente anche al mondo sotterraneo, nel quale è localizzato,
secondo
le dottrine etrusche più evolute, il reame dei morti. Gran parte
delle
nostre conoscenze sulla civiltà degli antichi Etruschi proviene, come
è
noto, dalle tombe (la stragrande maggioranza delle iscrizioni è di
carattere
funerario; alle pitture, alle sculture, alle suppellettili
sepolcrali siamo
debitori dei dati fondamentali sullo sviluppo delle forme
artistiche e sugli
aspetti della vita). Ed è naturale che le tombe ci
offrano, più o meno
direttamente, indizi sulle credenze relative alla sorte
futura degli uomini
e sui costumi e sui riti collegati a queste credenze. Ciò
nonostante siamo
ancora ben lungi dall'avere una idea chiara dell'escatologia
etrusca. Motivi
complessi e contrastanti denunciano livelli diversi di
mentalità religiosa
ed influenze eterogenee. Ne risultano problemi tuttora in
parte irresoluti,
singolarmente affascinanti.
Il carattere stesso delle
tombe e dei loro equipaggiamenti, soprattutto
nelle fasi più antiche, offre
una testimonianza inequivocabile del
persistere di concezioni primitive
universalmente diffuse nel mondo
mediterraneo, secondo le quali la
individualità del defunto, comunque
immaginata, sopravvive in qualche modo
congiunta con le sue spoglie mortali,
là dove esse furono deposte. Ne
consegue l'esigenza, fondamentale per i
superstiti, di garantire, difendere,
prolungare concretamente questa
sopravvivenza, non soltanto come tributo
sentimentale di affettuosa pietà,
ma come obbligo religioso non disgiunto,
probabilmente, da timore. A questo
genere di concezioni appartiene in
Etruria, come altrove (e segnatamente
nell'antico Egitto), la tendenza ad
immaginare il sepolcro nelle forme di
una casa, a dotarlo di arredi e di
oggetti d'uso, ad arricchirlo di
figurazioni pregne, almeno originariamente,
di significato magico
(specialmente pitture tombali con s.cene di banchetto,
di musica, di danze,
di giuochi atletici, ecc.), a circondare il cadavere
delle sue vesti, dei
suoi gioielli e delle sue armi; a servirlo con cibi e
bevande; ad
accompagnarlo con figurine di familiari; e, infine, a riprodurre
l'immagine
somatica del morto stesso, per offrire un incorruttibile
«appoggio» allo
spirito minacciato dal disfacimento del corpo, onde in
Etruria (come già in
Egitto) sembra nascere il ritratto funerario. Ma quale
sia l'effettiva e più
profonda natura delle idee religio- se che
traspariscono esteriormente in
così fatte costumanze e come esse abbiano
potuto sussistere ed evolversi
accanto ad altre credenze è cosa ancora tutto
sommato assai oscura.
All'origine della storia delle città etrusche vediamo
infatti dominare
pressoche esclusivo un rito funebre, quale è quello della
cremazione, che
non può non riflettere concetti estranei a quelli del legame
materiale tra
spirito e corpo del defunto; che anzi, almeno nella piena età
storica, esso
sembra talvolta significare un'idea di «liberazione» dell'anima
dai ceppi
della materia verso una sfera celeste. Tanto più curioso è
osservare come
nelle tombe etrusche del periodo villanoviano e
orientalizzante le ceneri e
le ossa dei morti bruciati si contengano talvolta
in urne in forma di
abitazioni o entro vasi che tentano di riprodurre le
fattezze del morto (i
così detti "canopi" di Chiusi): ciò che rivela, già dai
tempi più antichi
del formarsi della nazione etrusca, una mescolanza di
credenze e forse anche
un riaffermarsi delle tradizionifunerarie mediterranee
sul costume diffuso
dai seguaci della cremazione. Ne si può affermare che
l'idea della
sopravvivenza nella tomba escluda assolutamente una fede
nella
trasmigrazione delle anime verso un regno dell"'al di là". Ma è certo
che in
Etruria quest'ultima concezione si venne affermando e
concretando
progressivamente sotto l'influsso della religione e della
mitologia greca,
con l'attenuarsi delle credenze primitive: e si configurò
secondo la visione
dell'averno omerico, popolato da divinità ctonie, spiriti
di antichi eroi ed
ombre di defunti. Già nei monumenti del Ve IV secolo, e
poi soprattutto in
quelli di età ellenistica, la sorte futura è rappresentata
come un viaggio
dell'anima verso il regno dei morti e come un soggiorno nel
mondo
sotterraneo. Soggiorno triste, senza speranza, a volte dominato
dallo
spavento che incute la presenza di mostruosi dèmoni, o addirittura
dai
tormenti che essi infliggono alle anime. È, in sostanza,
la
materializzazione dell'angoscia della morte in una
escatologia
essenzialmente primitivistica. E a simboleggiare la morte sono
specialmente
due figure infernali: la dea Vanth dalle grandi ali e con la
torcia, che,
simile alla greca Moira, rappresenta il fato implacabile; e il
dèmone
Charun, figura semibestiale armata di un pesante martello, che
può
considerarsi una paurosa deformazione del greco Caronte dal quale prende
il
nome. Sia di Vanth sia di Charun esistono moltiplicazioni, forse con
una
propria individualità ed un proprio secondo nome. Ma la
demonologia
infernale è ricca e pittoresca, e conosce altri personaggi,
come
l'orripilante Tuchulcha dal volto di avvoltoio, dalle orecchie d'asino
e
armato di serpenti; accoglie largamente la simbologia di animali
ctonii,
come il serpente e il cavallo.
Anche per questa fase più tardiva
le fonti monumentali, nei loro aspetti
frammentari ed esteriori, sono
insufficienti a darci un'idea sicura e
completa delle credenze contemporanee
sull'oltretomba. Stando alle pitture e
ai rilievi sepolcrali, parrebbe che il
destino dei morti fosse
inesorabilmente triste ed uguale per tutti: la legge
crudele non risparmia
neanche i personaggi più illustri, la cui affermazione
di superiorità si
limita ai costumi sfarzosi, agli attributi delle cariche
rivestite e al
seguito che li accompagna nel viaggio agli inferi. Esistono
tuttavia nella
tradizione letteraria, alcuni accenni più o meno espliciti a
consolanti
dottrine di salvazione, e cioè alla possibilità che le anime
conseguano uno
stato di beatitudine o addirittura q i deificazione,
attraverso speciali
riti che sarebbero stati descritti dagli Etruschi nei
loro Libri
Acherontici. Un prezioso documento originale di queste cerimonie
di
suffragio, con prescrizioni di offerte e di sacrifici a
divinità
specialmente infernali, sembra esserci conservato nel testo etrusco
della
tegola di Capua, che risale al V secolo a.C.. Non sappiamo fino a che
punto
allo sviluppo di queste nuove concezioni escatologiche abbia
contribuito il
diffondersi in Etruria di dottrine orfiche, pita- goriche e,
più ancora,
dionisiache (il culto di Bacco è, in verità, largamente attestato
anche in
rapporto con il mondo funerario). Comunque le speranze di
salvazione
sembrano restare collegate al concetto delle operazioni
magico-religiose,
proprie di una spiritualità primitiva, piuttosto che
dipendere da un
superiore principio etico di retribuzione del bene compiuto
in vita.
Forme del culto
Le testimonianze
monumentali, i documenti scritti etruschi e i riferimenti
delle fonti
letterarie classiche offrono numerosi dati per la ricostruzione
della vita
religiosa e delle forme del culto. Si tratta di costumanze che,
almeno per
quel che riguarda gli aspetti sostanziali (luoghi sacri e
templi,
organizzazione del sacerdozio, sacrifici, preghiere, offerte di doni
votivi,
ecc.), non differiscono profondamente dalle analoghe manifestazioni
del
mondo greco, italico e, specialmente, romano. Ciò si spiega per un
verso
considerando i comuni orientamenti spirituali della civiltà
greco-italica a
partire dall'età arcaica, per altro verso tenendo conto della
fortissima
influenza esercitata dalla religione etrusca su quella romana. Uno
studio
delle antichità religiose etrusche non può quindi prescindere dal
quadro,
ben altrimenti particolareggiato e complesso, che in materia rituale
ci
presentano la Grecia e Roma: tanto più difficile è determinare i
riflessi
che le concezioni proprie della mentalità religiosa etrusca ebbero,
con
motivi peculiari, nella prassi del culto.
Sarà, in primo luogo, da
attribuire agli Etruschi quella concreta e quasi
materialistica adesione a
norme sancite ab antiquo, quel preoccupato
formalismo dei riti, quel
frequente insistere sui sacrifici espiatorii, che
si avvertono nell'ambito
delle tradizioni religiose romane come un elemento
in certo senso estraneo
alla semplice religiosità agreste dei prisci Latini
e indizio della presenza
di un fattore collaterale che non può non
riportarsi ad una antica e matura
civiltà cerimoniale, quale è appunto
l'etrusca. Questa ars colendi religiones
(secondo l'espressione di Livio nel
passo sopra citato) risponde in pieno al
senso di subordinazione dell'uomo
alla divinità, che sappiamo predominante
nella religiosità etrusca e
presuppone la fede nella efficacia magica del
rito, proprio delle mentalità
più primitive. La concretezza degli atti
cultuali si manifesta nella precisa
determinazione dei luoghi, dei tempi,
delle persone e delle modalità, entro
i quali e attraverso i quali si compie
l'azione stessa volta ad invocare o a
placare la divinità: quell'azione che i
Romani chiamavano nel loro complesso
res divina e gli Etruschi probabilmente
ais(u)na (cioè, appunto, servizio
"divino", da ais "dio"): donde, anche, la
parola umbra esono "sacrificio".
Essa si svolge nei luoghi consacrati
(tempia) dei quali si è fatta già
menzione: recinti con altari ed edifici
sacri contenenti immagini delle
divinità. Sovente questi edifici sono
orientati verso sud e sud-est. Il
concetto di consacrazione al culto di un
determinato luogo o edificio è
forse espresso in etrusco dalla parola sacni
(donde il verbo sacnisa):
questa condizione può estendersi, come in Grecia e
nel mondo italico e
romano, ad un complesso di recinti e templi, per esempio
sulle acropoli
delle città (Marzabotto); carattere in certo senso analogo
hanno anche le
tombe, presso le quali o entro le quali si compiono sacrifici
funerari o si
depongono offerte.
Speciale importanza deve avere avuto in
Etruria la regolamentazione
cronologica delle feste e delle cerimonie, che,
insieme con le modalità
delle azioni sacre, costituiva la materia dei Libri
Rituales ricordati dalla
tradizione. Il massimo testo rituale etrusco,
tramandatoci nella lingua
originale -e cioè il manoscritto su tela
parzialmente conservato nelle fasce
della mummia di Zagabria - contiene un
vero e proprio calendario liturgico,
Con l'indicazione dei mesi e dei giorni
ai quali si riportano le cerimonie
descritte. È probabile che altri documenti
fossero redatti nella forma
attestata dai calendari sacri latini: e cioè come
una elencazione
consecutiva di giorni contrassegnati dal solo titolo delle
feste o dal nome
della divinità celebrata.
Il calendario etrusco era forse
analogo al calendario romano precesareo:
conosciamo il nome di alcuni mesi e
sembra che le "idi", circa a metà del
mese, abbiano un nome di origine
etrusca; ma il computo dei giorni del mese
segue generalmente, a differenza
del calendario romano, una numerazione
consecutiva. Ogni santuario ed ogni
città doveva avere, come è logico, le
sue feste particolari: tale è appunto
il caso del sacni cilfh (santuario di
una città non altrimenti
identificabile), al quale fa riferimento il rituale
di Zagabria. Le
celebrazioni annuali del santuario di Voltumna presso
Volsinii avevano invece
carattere nazionale, come sappiamo dalla tradizione.
Tra le cerimonie e gli
usi sacri può ricordarsi quello della infissione dei
chiodi per segnare gli
anni (clavi annales) nel tempio della dea Nortia a
Volsinii, ricordato a
proposito dell'analogo rito del tempio di Giove
Capitolino a Roma. Anche per
intendere la natura e l'organizzazione dei
sacerdozi siamo costretti ad
avvalerci del confronto con il mondo italico e
romano.
Abbiamo in ogni
caso indizi per ritenere che essi fossero varii e
specializzati, strettamente
collegati con le pubbliche magistrature e
sovente riuniti in collegi. Il
titolo sacerdotale cepen (con le variante
cipen attestata in Campania),
particolarmente frequente nei testi etruschi,
è ad esempio seguito spesso da
un attributo che ne determina la sfera
d'azione o le specifiche funzioni:
come nel caso di cepen fhaurx, che senza
dubbio indica un sacerdote funerario
(da fhaura «tomba»). La dignità
sacerdotale in genere o specifici sacerdozi
sono designati anche con altre
parole: quali eisnevc (in rapporto con aisna,
l'azione sacrificale), celu,
forse santi, ecc. Si hanno inoltre i sacerdoti
divinatori: e cioè gli
aruspici (netsvis), rappresentati nei monumenti con un
costume
caratteristico composto di un berretto a terminazione cilindrica e di
un
manto frangiato, e gl'interpreti dei fulmini (trutnvt?). Il titolo
marun-,
è, come già sappiamo, in rapporto con funzioni sacrali, per esempio
nel
culto di Bacco (marunux paxanati, maru paxafhuras): si osservi il
doppio
titolo cepen marunuxva, che indica probabilmente un sacerdozio con
le
funzioni proprie dei maru. Si può ricordare anche il titolo zilx
cexaneri,
nel quale si è voluto intendere qualcosa come "curator sacris
faciundis",
(ma è congettura molto opinabile). Probabilmente a confraternite
si
riferiscono termini collettivi quali paxafhuras, formalmente analoghi
a
quelli che esprimono aggregati gentilizi (per es. Velfhinafhuras nel
senso
dei membri della famiglia Velfhina) o altri collegi.
A Tarquinia
esisteva in età romana un arda LX haruspicum veri similmente di
antica
origine. Uno degli attributi dei sacerdoti era illituo,
bastone
dall'estremità ricurva, che è però frequentemente rappresentato
nei
monumenti anche in rapporto ad attività profane, per esempio in mano
ai
giudici delle gare atletiche. L 'azione del culto è volta ad interrogare
la
volontà degli dèi, secondo le norme dell'arte divinatoria; e quindi
ad
invocare il loro aiuto e perdono attraverso l'offerta. È probabile che
l'una
e l'altra operazione fossero strettamente collegate tra loro; benche
sia
ricordata dalle fonti letterarie una distinzione tra vittime sacrificate
per
la consultazione delle viscere (hastiae cansultatariae) e vittime
destinate
all'offerta vera e propria, in sostituzione dei sacrifici umani
(hastiae
animales). Del pari intrecciate in complicati cerimoniali sembrano
le
offerte incruente (di liquidi e cibi) con quelle cruente di animali.
Il
grande rituale di Zagabria e il rituale funerario della Tegola di
Capua
descrivevano minuziosamente, in tono prescrittivo e con un
linguaggio
tecnico specializzato, queste liturgie; ma lo stato delle nostre
cognizioni
della lingua etrusca non ci consente di stabilire con esattezza
il
significato di molti 'termini impiegati nella descrizione dei riti
e,
pertanto, di ricostruirne in pieno lo svolgimento. La preghiera, la
musica,
la danza dovevano avere larga parte nelle cerimonie. Una scena di
culto con
offerte è rappresentata nella parete di fondo della Tomba del Letto
Funebre
di Tarquinia.
I doni votivi offerti nei santuari, per grazie
chieste o ricevute,
consistono per lo più di statue di bronzo, pietra,
terracotta, raffiguranti
le divinità stesse e gli offerenti, o anche animali,
in sostituzione delle
vittime, e parti del corpo umano; inoltre vasi, armi,
ecc. Questi oggetti
che erano ammassati in depositi o favisse, recano spesso
iscrizioni
dedicatorie. Essi variano per valore artistico e per pregio (la
massima
parte è costituita da modeste figuri ne di terracotta lavorate a
stampo):
ciò che indica, intorno ai grandi centri del culto, una diffusa e
profonda
religiosità popolare.
Il culto degli dei e
dei defunti
Dopo che i sacerdoti avevano ottenuto attraverso la
divinazione la
conoscenza del volere divino, si dava attuazione a tutto ciò
che ne derivava
dal punto di vista del comportamento, sulla base delle norme
che facevano
anch'esse parte della ''disciplina etrusca" ed erano oggetto di
trattazione
nei Libri Rituales. Queste norme si traducevano (e si esaurivano)
in una
serie impressionante di pratiche, cerimonie e riti rigidamente
codificati e
ripetuti meccanicamente fino a diventare puro e semplice
formalismo. Essi
toccavano sia gli aspetti religiosi della vita degli
etruschi sia quelli
civili, secondo il principio che ''ogni azione umana
doveva essere compiuta
in conformità della disciplina". E per ogni rito,
cerimonia di culto o
servizio divino doveva essere stabilito con precisione
il luogo, il tempo,
il modo, lo scopo, la persona preposta e, naturalmente,
la divinità che
veniva chiamata in causa. Le funzioni sacre si svolgevano
perciò in luoghi
rigidamente circoscritti e consacrati (templi, santuari,
altari) e il loro
svolgimento era codificato fin nei minimi particolari tanto
che, se veniva
sbagliato od omesso anche un solo gesto, tutta l'azione doveva
essere
ripetuta da capo. Musica e danza vi trovavano ampio spazio. Oltre
all'uso di
sacrificare bovini, ovini e volatili, particolarmente diffuso era
quello dei
doni votivi che potevano andare dagli ex voto (statue e statuine
di divinità
e di offerenti), alle prede di guerra (armi, carri), agli stessi
edifici
sacri (dedicazione di un tempio o di un sacello).
Tra le pratiche
di carattere religioso quelle destinate ai defunti avevano
presso gli
etruschi un carattere tutto particolare. Esse erano legate alla
concezione
(del resto diffusa in altre civiltà del Mediterraneo) che
l'attività vitale
del defunto, la sua ''individualità" continuasse anche
dopo la morte e che
questa sopravvivenza avesse luogo nella tomba. Spettava
però ai vivi, ai
familiari e dei parenti, garantire la sopravvivenza
dell'entità vitale del
defunto al quale doveva essere data una tomba, cioè
una nuova casa, e un
corredo di abiti, oggetti d'uso personali, cibi, di cui
si serviva
simbolicamente o magicamente. Per la stessa ragione vitalità e
forza venivano
trasmesse al defunto con giochi e gare atletiche che si
svolgevano in
occasione dei funerali o delle ricorrenze anniversarie della
morte. Quanto
alle pratiche proprie dei funerali, la prassi non era
dissimile da quella che
avveniva altrove: esposizione del cadavere al
compianto pubblico e alle
lamentazioni di donne appositamente pagate
(prefiche), corteo funebre e
banchetto presso la tomba. Il culto della
''sopravvivenza" nel sepolcro era
ulteriormente sviluppato nel culto degli
antenati e in particolar modo del
capostipite, specie delle famiglie
gentilizie. Tra il V e il IV secolo a.C.,
però, la fede della sopravvivenza
del morto nella tomba cambiò sotto
l'effetto delle suggestioni provenienti
dalla civiltà greca. Ad essa si
sostituì la concezione di un ''mondo dei
morti" (simile all'Averno o all'Ade)
dove le ''ombre" soggiornavano. Ai
defunti vennero allora dedicati
particolari riti di suffragio, stabiliti dai
Libri Acherontici, e offerte
alle divinità infere (in particolare il sangue
di alcuni animali) che
potevano consentire alle anime il conseguimento di
uno speciale stato di
beatitudine.
La ''disciplina etrusca"
Secondo gli
etruschi gli dèi condizionavano il mondo e ogni azione umana:
occorreva
quindi ''tradurre" la loro volontà andando in cerca dei segni
attraverso i
quali essa si manifestava. Perciò era necessario avere a
disposizione un
codice che interpretasse quei segni e un prontuario di norme
precise e
costanti che per ogni segno indicasse il conseguente comportamento
atto a
soddisfare (e quindi a seguire) la volontà degli dèi. Questo
complesso di
conoscenze fu chiamato dai romani ''disciplina etrusca" i cui
principi
ispiratori erano fatti risalire dagli etruschi all'intervento
rivelatore
della stessa divinità. Essa si sarebbe servita di esseri mitici o
semidei
(come il fanciullo Tagete o la ninfa Vegoe) i quali avrebbero
''dettato" le
verità soprannaturali e insegnato agli uomini l'arte di
avvicinarsi ad esse:
in pratica la divinazione. Appositi collegi
sacerdotali, che si tramandavano
la professione di padre in figlio, erano
preposti all'interpretazione dei
segni della volontà divine: i fulguratores
osservavano le traiettorie dei
fulmini, gli àuguri interpretavano i voli
degli uccelli, gli arùspici
leggevano il fegato delle pecore e di altri
animali sacrificati.
Le
dottrine divinatorie, e tutte le altre che formavano il corpus minuzioso
e
vastissimo dei riti etruschi, erano tramandati nei testi della
cosiddetta
''disciplina etrusca": i Libri Haruspicini, svelati dal fanciullo
Tagete,
trattavano la consultazione delle viscere degli animali; i
Libri
Fulguratores, il cui contenuto era stato manifestato dalla ninfa
Vegoe,
riguardavano la scienza dei fulmini; i Libri Rituales, svelati
anch'essi
dalla ninfa Vegoe, trattavano della suddivisione della volta
celeste, della
gromatica (ripartizione dei campi), dei riti e delle modalità
per la
fondazione delle città e per la consacrazione dei santuari, e infine
degli
ordinamenti civili e militari. Esistevano poi i Libri Acherontici,
svelati
da Tagete, che esponevano le credenze nell'oltretomba e dettavano le
norme
per i riti di salvazione. Infine v'erano i Libri Fatales, nei quali
si
trattava dei dieci secoli di vita assegnati dal Fato alla nazione etrusca,
e
i Libri Ostentaria che trattavano dell'interpretazione dei prodigi e
dei
fenomeni naturali.
L'interpretazione dei fulmini e
delle viscere
L'interpretazione dei fulmini
L'osservazione e
l'interpretazione dei fulmini era regolata da una casistica
alquanto
complessa. Grande importanza avevano il luogo e il giorno in cui
essi
apparivano, ma anche la forma, il colore e gli effetti provocati. Le
varie
divinità che avevano la facoltà di lanciarli disponevano, ciascuna, di
un
solo fulmine alla volta, mentre Tinia ne aveva a disposizione tre.
Il primo
era il fulmine "ammonitore" che il dio lanciava di sua spontanea
volontà e
veniva interpretato come avvertimento; il secondo era il fulmine
che
"atterrisce" ed era considerato manifestazione d'ira; il terzo era il
fulmine
"devastatore", motivo di annientamento e di trasformazione: Seneca
scrive che
esso "devasta tutto ciò su cui cade e trasforma ogni stato di
cose che trova,
sia pubbliche che private". I fulmini erano variamente
classificati a seconda
che il loro avviso valesse per tutta la vita o
solamente per un periodo
determinato oppure per un tempo diverso da quello
della caduta. C'era poi il
fulmine che scoppiava a ciel sereno, senza che
alcuno pensasse o facesse
nulla, e questo, sempre stando a quel che dice
Seneca, "o minaccia o promette
o avverte"; quindi quello che "fora", sottile
e senza danni; quello che
"schianta"; quello che "brucia", ecc. Ma Seneca
parla anche di fulmini che
andavano in aiuto di chi li osservava, che
recavano invece danno, che
esortavano a compiere un sacrificio, ecc. Con un
tale groviglio di
possibilità, solo i sacerdoti esperti potevano
sbrogliarsi. Plinio il Vecchio
arriva ad affermare che un sacerdote esperto
poteva anche riuscire a
scongiurare la caduta di un fulmine o, al contrario,
riuscire con speciali
preghiere, ad ottenerla.
Resta da dire che dopo la caduta di un fulmine c'era
l'obbligo di costruire
per esso una tomba: un piccolo pozzo, ricoperto da un
tumuletto di terra, in
cui dovevano essere accuratamente sepolti tutti i
resti delle cose che il
fulmine stesso aveva colpito, compresi gli eventuali
cadaveri di persone
uccise dalla scarica. Naturalmente, il luogo e la tomba
erano considerati
sacri e inviolabili ed essendo ritenuto di cattivo auspicio
calpestarli,
erano recintati e accuratamente evitati dalla gente, quali
"nefasti da
sfuggire", come scriveva nel I secolo d.C. il poeta romano Persio
originario
dell'etrusca Volterra.
L'interpretazione delle
viscere
Le viscere degli animali di cui si servivano gli Aruspici (dette
in latino
exta) erano di diverso tipo: polmoni, milza, cuore, ma specialmente
fegato
(in latino hepas). Esse venivano strappate ancora palpitanti dal corpo
degli
animali appena uccisi ed espressamente riservati alla
consultazione
divinatoria e quindi distinti da quelli immolati per il
sacrificio. Esse
venivano strappate ancora palpitanti dal corpo degli animali
appena uccisi
ed espressamente riservati alla consultazione divinatoria e
quindi distinti
da quelli immolati per i sacrifici. Si trattava in genere di
buoi e talvolta
anche di cavalli ma soprattutto di pecore.
Delle viscere
dovevano essere prese in considerazione la forma, le
dimensioni, il colore ed
ogni minimo particolare, specialmente gli eventuali
difetti. Quando non
rivelavano nulla di apprezzabile per la divinazione,
erano ritenute "mute" e
inutilizzabili; erano invece "adiutorie" quando
indicavano qualche rimedio
per scampare ad un pericolo; "regali" se
promettevano onori ai potenti,
eredità ai privati, ecc.; "pestifere" quando
minacciavano lutti e disgrazie.
L'osservazione era più minuziosa nel caso
del fegato, dato che in esso, per
l'aspetto generale e per la particolare
conformazione, veniva riconosciuto il
"tempio terrestre" corrispondente al
"tempio celeste". La sua importanza era
del resto connessa alla credenza
diffusa presso gli antichi che esso fosse la
sede degli affetti, del
coraggio, dell'ira e dell'intelligenza. Ritenuto che
nel fegato fosse
esattamente proiettata la divisione della volta celeste, si
trattava di
riconoscere a quale delle caselle di quella corrispondessero, nel
fegato, le
irregolarità. Le imperfezioni, i segni particolari o anche le
regolarità, e
quindi prendere in considerazione i messaggi della divinità che
occupava la
casella interessata. Per meglio riuscire nell'intento, per
l'istruzione dei
giovani aruspici, venivano utilizzati degli appositi modelli
di fegato, in
bronzo o in terracotta, sui quali erano riprodotte le varie
ripartizioni e
scritti i nomi delle diverse
divinità.
L'osservazione dei prodigi
La fama di
insuperabili interpreti di viscere e fulmini, della quale
godevano gli
Etruschi, era completata da quella che li riteneva anche
esperti conoscitori
del significato di ogni genere di prodigi. Il romano
Varrone, che desumeva
evidentemente da fonti etrusche, riferisce che tra i
prodigi si distinguevano
l'ostentum, che prediceva il futuro; il "prodigio",
che indicava il da farsi;
il "miracolo", che manifestava qualcosa di
straordinario; il "mostro", che
dava un avvertimento. Tra i prodigi più
frequenti erano annoverati la pioggia
di sangue, la pioggia di pietre e
quella di latte, gli animali che parlavano,
la grandine, le comete, le
statue che sudavano, ecc. In aggiunta alle
manifestazioni di carattere
straordinario, nelle categorie dei prodigi
rientravano anche fatti del tutto
naturali: c'erano perciò alberi e animali
"felici" o "infelici", cioè
portatori di cattivo o di buon auspicio, piante
commestibili che portavano
bene e piante selvatiche che portavano male. La
casistica era infinita: ad
essa tutti prestavano in genere molta attenzione,
magari per tradizione o
per rispetto della comune
opinione.
Libri Fulgurales
Seneca (II 32 ss.) e
Plinio (II,135 ss:) hanno conservato una larga parte di
excepta dai libri
fulgorales etruschi e della loro minuziosa casistica
(soprattutto delle opere
del volterrano Cecina). Il principio basilare e'
quello secondo il quale:
alcuni Dei posseggono le Manubiae, ovvero le
potesta' di scagliare i
fulmini.(Serv. Aen. I,42.) In particolare 9 dei
(Plin. n. h.,II,138), forse
da identificare con i misteriosi dii novensiles
o novensides della lista di
Marziano Capella, ma noti anche in dediche
romane.
I tipi di Fulmine sono
11 per 9 Dei, perche' Tinia (Tin = Giove) possiede 3
manubiae. (Plin. n.h.,
II, 138; Sen. n.q. II,41) Le 3 manubie possono
distinguersi per il loro
significato e per il fatto di essere scagliati da
Giove da solo o con il
"consiglio" degli altri Dei.
Prima manubia del Solo
Tinia
Seconda manubia di Tinia + i 12 Dei Consentes
Terza
Manubia di Tinai + Dei Involuti
I 3 tipi di fulmini possono essere
di natura fisica (Fest. p. 114 L; Sen.
n.q. II, 40) oppure per alcuni
(Serv. auct. Aen. VIII, 429)
ostentatorium = dimostrativo
(dopo
consultazione con i 12 Dei Consentes. Segno di Ira degli Dei.Utile e
dannoso
serve per impaurire).
peremptorium = perentorio
(Dopo consultazione con i
Dei superiores et involuti. Devasta. Indica che
tutto verra' radicalmente
trasforamato nella vita pubblica o privata.)
presagum = presago
(Di
avvertimento per suadere (convincere) o dissuadere (far cambiare idea)).
Da
Seneca ..manubia placata est et ipsius concilio iovis mittitur.
oppure per
altri (Serv. Aen. I, 230)
quod terreat = che atterisce
quod adflet =
che soffia
quod puniat = che punisce
Degli altri 9 Dei abbiamo solo
degli indizi,dalle fonti letterari, per 5 di
essi:
Uni =
Giunone
Menerva = (Mnrva,Menrua,Meneruva,Merva,Merua,Mera)=
Minerva
Sethlans = Vulcano
Mari = (Mars,Maris) Marte
Satres = (Satrs)
Saturno
La dottrina romana del fulmine attribuiva i fulmini notturni a
Summanus e
tenendo conto del fegato di Piacenza e cio' che dice Capella
probabilmente
il corrispondente etrusco potrebbe essere Cilen - Nocturnus.
Mentre
l'identita' tra Vetisl etrusco e Vediovis o Veiovis romano
farebbe
attribuire a questo una manubia infera, anche in considerazione di
uno Zeus
sbarbato munito di fulmine frequente nella iconografia etrusca.
Anche per i
fulmini vale la dottrina delle 16 regioni che vale per
l'epatoscopia.(Plin.
n.h. II, 143)
L'esame del fulmine (e del tuono) da
parte dell'aruspice prevedeva una
casitica precisa, enunciataci da Seneca
(n.q. II ,48 ,2 ):
1- Da parte di quale Dio proviene
2- quale = di che
tipo e'
3- quantum = la durata
4- ubi factum sit, cui = l' oggetto
colpito
5- quando, in qua re = in che circostanza
Per quel che
riguarda il tipo:
1 - di che colore era il fulmine
manubiae albae =
bianche = forse di Tinia
manubiae nigrae = nere = di Sethlans
manubiae
rubrae = rosse = forse di Mari
Provenienti dai Pianeti associati al nome
divino e non dal Dio.
I fulmini provenienti da Satres provenivano anche dalla
Terra in inverno ed
erano detti Infernali.
2 - genus:
l' acre del
fulmine, il grave del tuono, intensita' e capacita' erano di 3
tipi:
quod
terebrat = che perfora,sottile e fiammeggiante.
quod dissipat = che si
disperde,passante,capace di rompere senza perforare.
quod urit = che brucia
in 3 modi
come un soffio (afflat) e senza grave danno bruciando dando
fuoco
3 - C' erano fulmini Secchi - Umidi e Clarum (Plinio)
Per quel
che riguarda l'oggetto colpito i fulmini possono essere
fatidica = cioe'
portatori espressi di segni eventualmente comprensibili
(fata)
bruta =
privi di significato
vana = il cui significato si perde
l'oggetto puo'
essere
schiantato = discutere
non rompersi = terebrare
essere + o -
affumicato = urere
restare affumicato = fuscare
Per quel che riguarda
l'auruspice Seneca dice che il sacerdote procedeva
con l'analisi sistematica
= quomodo exploremus
con l'interpetazione dei segni = quomodo
interpretemus
con l'espiazione, propiziazione e purificazione = quomodo
exoremus
Ma soprattuto il sacerdote non era solo in grado di leggere i
segni
ma anche di evocarli con l'attirare (exorare) il
fulmine.
L'arte della divinazione
Il segno più
importante, la ''voce" più potente della divinità era il
fulmine, che
proveniva direttamente dal dio supremo Tinia; l'ars
fulguratoria, cioè quella
di trarre dalla sua osservazione tutte le
informazioni possibili, era quindi
al primo posto nella divinazione etrusca.
Era regolata da una casistica
alquanto complessa che teneva conto della
parte del cielo in cui il fulmine
appariva (la volta celeste era divisa in
sedici parti, abitata ognuna da una
divinità), della forma, del colore,
degli effetti provocati e del giorno
della caduta. Oltre all'osservazione
dei fulmini (cheraunoscopia) c'era
un'altra forma di divinazione molto
generalizzata alla quale era possibile
ricorrere ogni volta che fosse
ritenuto utile o necessario senza dover
attendere altre forme di prodigi
dipendenti invece dal caso, come appunto il
fulmine. Era l'epatoscopia, o
lettura del fegato degli animali sacrificati,
che i romani chiamavano
haruspicina. Il fegato, la cui immagine si riteneva
fosse proiettata la
divisione della volta celeste, veniva strappato ancora
palpitante dal corpo
dell'animale (pecora, bue, cavallo) e se ne osservavano
le regolarità e
irregolarità a ognuna delle quali era attribuito un
messaggio. Per questo
venivano usati degli appositi modelli in bronzo o in
terracotta sui quali
erano riprodotte le varie ripartizioni e scritti i nomi
delle divinità. Fra
i modelli giunti sino a noi il più celebre è il ''Fegato
di Piacenza". Oltre
al fegato gli arùspici leggevano anche altre viscere come
il cuore, i
polmoni, la milza.
Il rito di
fondazione
Fra i dettami della disciplina etrusca famoso in tutta
l'antichità era
quello della fondazione di città per il quale erano previste
meticolosissime
disposizioni. Gli aùguri cominciavano col delimitare una
porzione di cielo
consacrata proprio in funzione del rito (e definita con il
termine
significativo di templum) all'interno della quale trarre gli auspici
dedotti
dal volo degli uccelli che la attraversavano, dai fenomeni
meteorologici che
in quel perimetro potevano verificarsi, o da altre
manifestazione
considerate provenienti dalle divinità. Erano poi individuati
il centro
della città stessa e delle principali direttrici viarie scavando
fosse in
cui venivano deposte offerte e sovrapposti cippi che fungevano sia
da punti
di riferimento sia da luoghi sacrali. Veniva poi tracciato con un
aratro dal
vomere di bronzo un solco continuo che disegnava il perimetro
delle mura,
interrotto solo là dove si sarebbero aperte le porte delle città;
il solco
diventava subito linea inviolabile per tutti gli uomini e
attraversarlo
equivaleva ad attaccare la città. Lungo tutto il perimetro
delle mura
correva inoltre, tanto all'esterno quanto all'interno, un'ampia
fascia di
terreno (il pomerium) che non doveva essere né coltivata né
edificata e che
era dedicata alla divinità. Una solenne cerimonia di
sacrificio inaugurava
la città così prefigurata. La fondazione di Roma a
opera di Romolo e Remo
così come ce l'hanno tramandata le leggende è
un'applicazione puntuale del
rito etrusco: i gemelli che osservano il volo
degli uccelli per decidere chi
dei due dovesse dare il nome alla città, il
solco tracciato da Romolo,
l'uccisione di Remo che, saltando all'interno del
perimetro, profana i sacri
confini e ''invade" la nuova
fondazione.
Le pratiche rituali
Dal momento che
con le arti divinatorie veniva raggiunta la conoscenza del
volere divino, si
trattava di dare attuazione a tutto ciò che ne derivava
dal punto di vista
del comportamento. Occorreva cioè agire sulla base delle
norme prescritte
dalla "disciplina" e oggetto della trattazione specifica
dei "libri rituali".
Tali norme si traducevano in una serie interminabile di
pratiche, di
cerimonie, di riti. Si dovevano perciò determinare i luoghi, i
tempi e i modi
nei quali e con i quali doveva essere eseguito quello che
veniva chiamato il
"servizio divino" (aisuna o aisna, da ais che significa
dio),
nell'indicazione delle persone alle quali l'azione competeva e,
naturalmente,
prima di tutto, della divinità alla quale essa era dedicata. I
luoghi
dovevano essere circoscritti, delimitati e consacrati; i tempi
regolati dalla
successione cronologica delle feste e delle cerimonie
previste ed elencate
nei calendari sacri; i modi rispettati fin nei minimi
particolari, tanto che,
qualora fosse stato sbagliato oppure omesso un solo
gesto, tutta l'azione
avrebbe dovuto essere ripresa da capo. Nelle funzioni
trovavano ampio spazio
la musica e la danza; le preghiere potevano essere d'
espiazione, di
ringraziamento o di invocazione; i sacrifici cruenti
riguardavano particolari
categorie di animali; le offerte comprendevano
prodotti della terra, vino,
focacce e altri cibi preparati.
Particolarmente diffusa, tanto a livello di
religiosità "ufficiale" quanto a
livello di religiosità popolare, era
l'usanza dei doni votivi. Nel primo
caso poteva trattarsi di statue o altre
opere d'arte, di oggetti
particolarmente preziosi, di prede di guerra e di
edifici sacri; nel secondo
caso i doni erano solitamente piccoli oggetti, per
lo più di terracotta (ma
anche di bronzo, di cera e mollica di pane) che i
fedeli compravano nelle
apposite rivendite presso i
santuari.
Il rituale funerario
Durante il periodo
villanoviano, il corpo del defunto era spesso cremato; le
sue ossa combuste
venivano raccolte in un apposito vaso che per la sua forma
gli archeologi
hanno chiamato "biconico", poichè costituito da due coni
contrapposti,
collegati per le basi (museo archeologico-topografico, sala di
Roselle ecc.).
In genere, questo contenitore ha soltanto un' ansa (quando ve
n'erano due,
una veniva ritualmente spezzata). Inoltre, la sua bocca è
coperta da una
ciotola, anch'essa munita di una sola ansa; oppure, nel caso
che il defunto
fosse appartenuto alla classe dei guerrieri, è talvolta
coperta da un elmo.
Il vaso e il corredo funebre, composto dagli oggetti più
cari al defunto,
vengono deposti in un "pozzetto", scavato appositamente nel
terreno;
talvolta, le sue pareti vengono foderate con lastre di pietra e
l'apertura ne
è chiusa con un lastrone. In alcune zone dell'Etruria d'epoca
villanoviana i
cinerari hanno la forma di capanna, le cosiddette "urne a
capanna" appunto
(museo archeologico-topografico, sala di Vetulonia), quasi
a voler
ricostruire per il defunto la sua casa terrena.
Il corredo mostra alcune
differenze, soprattutto a livello di sesso: spesso
la presenza di un rasoio
distingue la deposizione dell'uomo, mentre quella
della donna è evidenziata
da oggetti usati per la filatura, come un fuso o
una fuseruola.
Successivamente, nell'VIlI secolo a.C. il corredo che
accompagna il defunto
diventa più prezioso, aumentano gli oggetti di
metallo, soprattutto in
bronzo, e compa- provenienti dalla Grecia;
cominciano inoltre altri tipi di
sepolture, contraddistinte da dimensioni
maggiori, come le tombe a fossa,
nelle quali viene deposto il defunto
inumato. Con l'inizio di questo tipo di
sepoltura, il rito cambia; in-
fatti, il corpo del defunto non è cremato, ma
è deposto in una fossa scavata
nel terreno, munita talvolta di pareti
foderate con lastre di
pietra -Sovana-, come i "pozzetti". In alcune aree
dell'Etruria, per esempio
a Vetulonia, più tombe di questo tipo vengono
riunite entro circoli di
pietre, quasi a voler tener uniti i membri di una
medesima famiglia.
La differente ricchezza presente nei contesti funebri è un
dato molto
importante perche segnala, all'interno della società etrusca, il
formarsi di
una diversa stratificazione sociale rispetto alla più omogenea
situazione
del periodo villanoviano. Nel periodo orientalizzante, nel VII
secolo a.C.,
troviamo tombe costruite o scavate nella roccia; la scelta fra
le due
possibilità è dovuta ai diversi tipi di formazione geologica presenti
nelle
differenti aree e, per molti decenni, i membri di una stessa famiglia
(gens)
vengono sepolti all'interno di una medesima tomba . I corredi
raggiungono
talora livelli di ricchezza eccezionali; la tomba assume
carattere
monumentale, manifestando così la potenza della famiglia a cui
appartiene.
Un lungo dròmos (corridoio) porta all'interno della tomba, in cui
è scavata
o costruita la camera funeraria sotterranea; all'esterno la
protegge un
tumulo artificiale di terra, contenuto da un "tamburo" (un muro
circolare)
di pietra. Dal VI secolo a.C. diminuiscono le dimensioni delle
tombe,
scompare il loro aspetto monumentale e si assiste talvolta a una
specie di
"pianificazione edilizia" all'interno della necropoli, come quella
della
Necropoli del Crocifisso del Tufo a Orvieto. Il dato archeologico ci
fa
comprendere, in tale caso, che la grande aristocrazia, quella
proprietaria
dei monumentali tumuli, ha perso potere in quest'area, lasciando
spazio a un
ceto medio. Le costruzioni monumentali permangono in uso solo in
alcune zone
dell'Etruria. A Populonia troviamo nella seconda metà del VI
secolo un tipo
di costruzione piuttosto origi nale, la cosiddetta "tomba a
edicola", il cui
esterno è simile a una piccola casa munita di un tetto a
doppio spiovente.
Nel periodo ellenistico ci sono ancora tombe di proporzioni
monumentali,
come quelle di Sovana o di Norchia, le note e affascinanti tombe
rupestri
scavate nella roccia tufacea. Le loro facciate imitano quelle dei
templi o
dei palazzi, come si rileva per la tomba Ildebranda a Sovana.
S'intendeva
evidentemente eroizzare il defunto, deponendo il suo corpo
all'interno di un
vero e proprio "tempio"; vicino alla tomba vi possono
essere altari per le
celebrazioni cultuali dei defunti. Nello stesso periodo,
a Volterra le tombe
vengono scavate nella roccia tufacea; sulle loro
banchine, ricavate nella
pietra, troviamo urne contenenti le "ceneri" dei
defunti di una medesima
gens . Tali "urnette", prodotte dalle botteghe locali
in alabastro o tufo,
sono decorate sulla cassa con rilievi più o meno alti,
raffiguranti scene
mitologiche tratte dal repertorio greco (Iliade, Odissea,
ecc. ) oppure
legati al mondo etrusco (il congedo del defunto dai propri
cari, mostri
dell'aldilà ecc.). Il coperchio "rappresenta" in genere il
defunto/a disteso
sul letto da banchetto. Il viso della persona effigiata non
è inteso quale
ritratto nel senso proprio del termine, ma piuttosto una
"tipologia" di
volto, che raffigura per esempio una "giovane donna" oppure
un "uomo
anziano".
Nel II secolo a.C., accanto a questo tipo di urna
cineraria, rivolta a una
committenza appartenente a un ceto "medio",
compaiono urnette in terracotta,
provenienti dal territorio di Chiusi,
realizzate a matrice e deposte in
tombe a "nicchiotto" semplicemente scavate.
Furono fatte per una classe
sociale economicamente meno rilevante, che
tuttavia ebbe notevole fortuna
politica nell'Etruria Settentrionale del
tempo. In alto, sulla cassa, è
scritto il nome del defunto, a testimoniare la
diffusione
dell'alfabetizzazione, ormai raggiunta anche da ceti sociali
"subalterni".
L'antropomorfizzazione e le statue cinerario
Il
Museo Archeologico di Firenze rivela al visitatore un aspetto
interessante
della civiltà etrusca, talvolta non del tutto conosciuto. Il
fenomeno
riguarda in particolare la città di Chiusi, le cui manifestazioni
connesse
all'arte e all'artigianato rivelano, già nel VII secolo a.C., una
tendenza
all'antropomorfizzazione: i vasi canopi. Sono ossuari realizzati in
genere
con ceramica di impasto, ma talvolta anche in metallo (bronzo),
cinerari che
presentano per coperchio una raffigura zione stilizzata della
testa del
defunto; qualche volta, il "vaso" ha due piccole braccia disegnate
a rilievo
e può essere collocato sulla rappresentazione miniaturizzata di un
sedile
(Museo archeologico-topografico, sala di Chiusi). Qualcosa di simile
troviamo
anche nel periodo Villanoviano, quando per coperchio del vaso
biconico è
posto un elmo, quasi a voler restituire un 'integrità fisica
al
defunto.
Successivamente, nel V secolo a.C., questa tendenza diventa
ancora più
evidente con la presenza, sempre nella città di Chiusi, di statue
cinerario:
grandi sculture, come quella della Mater Matuta, scolpite in
pietra, che
ospitano in una cavità interna le "cene ri" del defunto, mentre
la testa
amovibile della statua funge da "chiusura".
La tomba come
casa del defunto
Gli scavi archeologici delle necropoli ci hanno fornito
molti dati sulla
civiltà etrusca. Un fattore costante nell'ideologia
funeraria etru- sca
risulta la tomba, sentita come dimora del defunto.
Abbiamo già riferito di
alcune urne cinerarie conformate "a capanna", ma
anche taluni monumenti
funerari possono denotare questo aspetto. L'ingresso
della tomba può essere
costituito da una porta in pietra con tanto di
battenti e, a guardia di essa
come a custodia di un'abitazione terrena, sono
poste statue di animali
fantastici, quali sfingi leonine, o più vicini alla
realtà, come i leoni;
oppure, a testimonianza dell' importanza del defunto,
troviamo statue
rigididamente composte di prefiche. Talvolta le camere
sotterranee delle
tombe gentilizie riproducono fedelmente la pianta e
l'interno di
un'abitazione, il cui "arredo" viene allora "scolpito"
nell'interno: sedie,
letti, porte modanate, le stesse suppellettili, nonche i
tetti a doppio
spiovente con l'orditura delle travi del soffitto. Medesima
decorazione si
riscontra nella forma e nel coperchio di alcune urne
cinerarie, che hanno l'
aspetto esteriore identico a quello di una casa. Da
tutto ciò emerge
chiaramente l'immagine di un mondo dell'aldilà molto
prossimo a quello
terreno. Gli oggetti che facevano parte del corredo funebre
testimoniano la
volontà degli Etruschi di ricreare nell'oltretomba la realtà
di ogni giorno.
Un'ulteriore testimonianza di ciò è notoriamente
rappresentata dalle pitture
delle tombe, che spesso riproducono scene di vita
quotidiana e in
particolare di banchetto.
Il culto dei
morti
Tra le pratiche di carattere religioso, un posto del tutto
particolare
occupavano quelle che avevano come destinatari i defunti. Nei
primi tempi,
esse erano legate alla concezione della continuazione dopo la
morte di una
speciale attività vitale del defunto. A tale concezione si
accompagnava l'
idea che quell'attività avesse luogo nella tomba e fosse in
qualche modo
congiunta alle spoglie mortali. Dato però che tutto dipendeva
dalla
collaborazione dei vivi, i familiari del defunto erano tenuti a
garantire,
agevolare e prolungare per quanto possibile la "sopravvivenza" con
adeguati
provvedimenti.
La prima esigenza da soddisfare era quella di dare
al morto una tomba, che
sarebbe diventata la sua nuova casa; subito dopo
veniva quella di fornirgli
un corredo di abiti, ornamenti, oggetti d'uso e,
insieme, una scorta di cibi
e bevande. Il resto era un arricchimento e poteva
variare a seconda del
rango sociale del defunto e delle possibilità
economiche degli eredi. Si
poteva così foggiare la tomba nell'aspetto sia
pure parziale o soltanto
allusivo della casa, e dotarla di suppellettili e
arredi, e magari
affrescarla sulle pareti con scene della vita quotidiana o
dei momenti più
significativi della vita del defunto. Quanto alle pratiche
proprie dei
funerali, esse andavano dall'esposizione al compianto pubblico al
corteo
funebre al banchetto davanti alla tomba. Tutte queste pratiche,
insieme alle
cerimonie e ai riti che dovevano essere compiuti in onore di
divinità
connesse con la sfera funeraria, facevano parte di un autentico
culto dei
morti, sacro da rispettare e da venerare. La situazione tuttavia
cambiò con
il tempo: infatti, per effetto delle suggestioni provenienti dal
mondo
greco, nel corso del V secolo a .C., alla primitiva fede di
sopravvivenza
del morto nella tomba, si sostituì l'idea di uno speciale regno
dei morti.
Questo fu immaginato sul modello dell'Averno (o Acheronte) greco,
il regno
dei morti, governato dalla coppia divina di Aita e Phersipnai (Ade
e
Persefone greci).
ALCUNE OPERE:
ARRINGATORE
Tratto dal testo della
sovrintendenza del Museo Archeologico di Firenze
Provenienza: Il grande
bronzo entrò a far parte, nel 1566, delle collezioni
del Granduca Cosimo de'
Medici. Scrive a tal proposito Vasari, in una
lettera datata 20 settembre
1566, al Borghini: "Il Duca ha avuto una statua
di bronzo intera che non gli
manca niente, d'uno Scipione Minore" - (l
'identificazione era errata) -"di
braccia 3 incirca in atto di locuzione".
Non conosciute le circostanze del
recupero, il luogo di rinvenimento rimane
incerto tra quello tradizionale,
Sanguineto (PG) sulla riva settentrionale
del lago Trasimeno, e Pila, presso
Perugia, località emersa da fonti
archivistiche.
Stato di
conservazione e tecnica: grande statua in bronzo eseguita con
tecnica a cera
perduta, a fusione cava, in sette parti (testa e collo,
tronco in due pezzi,
braccio destro, mano sinistra, le due gambe) poi
saldate e, nel caso delle
gambe, inferiormente piene per maggior robustezza,
fissate con chiodi alla
toga. Gli occhi, in diverso materiale (avorio, osso
e/o pasta vitrea) erano
inseriti a parte e sono oggi perduti. Ciocche di
capelli, bordi della toga,
iscrizione ed altri particolari sono incisi. La
mano destra fu spezzata al
momento del primo rinvenimento.
Datazione: primi decenni del I sec.
avanti Cristo.
Soggetto: la statua, a grandezza naturale, rappresenta un
uomo maturo, con i
capelli aderenti alla testa pettinati a ciocche, vestito
di una corta toga
(toga exigua), praetexta, e, a contatto con la pelle, di
una tunica bordata
da una stretta banda (angustus clavus; vedi il braccio
destro). Indossa dei
calzari (calcei). Il suo rango è dichiarato dall' anello
che porta alla
sinistra.
La destra è alzata, la mano aperta nel gesto del
silentium manu lacere: il
personaggio è ritratto nel momento in cui,
apprestandosi a parlare in
pubblico, chiede l'attenzione, di qui il nome con
cui la statua è
universalmente nota, l"'arringatore".
Il personaggio,
un etrusco, come vedremo dall'iscrizione, si atteggia e
veste ormai alla
maniera romana: la sua veste, pur riportabile alla tebenna
etrusca, è ormai
accostabile alla toga romana; i calzari presentano la
caratteristica
linguetta (lìngula) e le corregge (corrigiae) dei calcei
senatorii
romani.
L'iscrizione: incisa su tre righe sul bordo della toga, è un
'iscrizione di
carattere "pubblico": la grafia è composta e ben curata, le
lettere
presentano appendici (apicature) destinate a renderle più belle e
ricercate.
Il tipo di alfabeto usato è quello presente, in epoca tardo
etrusca, nell
'area di Chiusi e Cortona.
aulesi .metelis .ve. vesial.
clensi cen .jleres .tece .sansl. terine tu ines
.chisvlics
così
interpretabile: "per Aule Metelifiglio di Vel e di una Vesiquesto
(oggetto
sacro) al dio Tece Padre è posto (o simile) dal pago (o vico) di
Chiusuli".
Certa è l'interpretazione della prima riga, incerta quella delle
altre;
quanto basta comunque per capire che ci troviamo di fronte ad una
statua
comnemorativa di un uomo pubblico, politico, Aulo Metello appunto,
offerta in
suo onore da una qualche comunità in un santuario della zona di
Perugia o,
più probabilmente, del Trasimeno.
Il ritratto: l'iscrizione dichiara con
evidenza che, con questa statua, si
voleva ricordare, e rappresentare, un
uomo ben preciso, Aulo Metello. Anche
il volto dunque si sarà voluto
avvicinare alle fattezze del personaggio,
accentuandosi in questo una
tendenza stilistica di pronunciato verismo di
influenza, ancora, romana.
Lungo e dibattuto è il problema del nascere e del
fiorire del genere
artistico del ritratto, e, soprattutto, il problema di
quando si possa
parlare, per una testa dipinta o scolpita, di ritratto,
nella "moderna"
accezione del termine. Nella sua evoluzione sono state
individuate le
seguenti tappe:
l) ritratto intenzionale: il primo impulso al ritratto, che
si manifesta
nella sua forma più ingenua, attribuendo un nome determinato ad
una immagine
generica;
2) ritratto tipologico: la genericità dell'immagine
si riduce, cercandosi di
indicare con essa la classe di appartenenza del
personaggio raffigurato (un
re, un guerriero, un dio), e la sua età (vecchio,
giovane).
La III e la IV tappa tendono ad imitare precisamente le fattezze
individuali
del soggetto, riproducendone veristicamente i tratti somatici
(ritratto
fisionomico) ed infine cercando di conferire ad essi
un'espressione
psicologica che meglio ricordi il personaggio: è il ritratto
fisionomico,
ritratto nella sua accezione moderna, che affonda però le sue
radici nei
fermenti della Grecia del IV sec., quando, sullo stimolo della
sofistica, si
abbandonano le più antiche remore ideologiche che avevano fino
ad allora
impedito dieternare con un tale tipo di ritratto un individuo
isolandolo al
di sopra della massa di suoi pari, per giungere ora ad un più
pieno
apprezzamento della individualità del singolo. Se ancora per il
sarcofago
dell"'obeso" siamo incerti se ci troviamo di fronte ad un
ritratto
fisionomico, e non piuttosto ad un ritratto tipologico di dominus
adagiato
sulla sua kline, per la nostra statua è ormai chiara, nella cura
minuziosa
dei dettagli, la potente influenza del verismo ritrattistico di
Roma. Il
collo è lungo, la fronte è solcata da profonde rughe, il taglio
degli occhi
prosegue lateralmente in sottili incisioni e la loro intensità è
aumentata
dall'ampiezza delle guance, magre e glabre; la bocca, ben
disegnata, è
sottolineata da un mento piuttosto deciso.
Aule Meteli, un
etrusco (lo dichiara, l'iscrizione) che veste, si fa
ritrarre alla maniera
romana. Un etrusco, dunque, ormai pienamente
romanizzato, come giuridicamente
romanizzata è, proprio in questi anni,
l'Etruria che, con la Lex Iulia e
laLex Calpurnia de civitate (90 a.C.),
acquisisce la cittadinanza romana. La
nostra statua è dunque un monumento
che possiamo prendere a simbolo dello
scomparire di una civiltà, quella
etrusca, lentamente ed inesorabilmente
assorbita da quella romana. Con
debita prudenza possiamo quasi riassumere in
questo bronzo un'epoca: " Aulo
Metello, nato etrusco, cittadino
romano".
CHIMERA
Tratto dal testo della sovrintendenza del Museo
Archeologico di Firenze
La storia
La Chimera fu scoperta nel 1553
(secondo il Vasari nel 1554), durante la
costruzione di fortificazioni
medicee alla periferia della città. Il
ritrovamento avvenne il 15 novembre
1553 e dopo il rinvenimento fu subito
trasportata a Palazzo Vecchio. Questa
scoperta sensazionale ebbe larga eco
tra artisti e letterati dell'epoca, come
ad esempio il Cellini, il Vasari,
Tiziano ecc. ela notizia si diffuse assai
rapidamente, tanto che nella
seconda metà del'500 la Chimera divenne
l'interesse precipuo e la mèta di
numerosi viaggiatori stranieri che ne
parlarono in appunti di viaggio
corredati spesso da disegni dell'opera.
Da
alcuni disegni più antichi e da notizie sul ritrovamento nell'Archivio
di
Arezzo risulta che solo la coda, rintracciata dal Vasari, mancava e che
non
fu ricomposta. Così viene anche a cadere la leggenda che vedeva nel
Cellini
l'esecutore del restauro integrativo delle zampe che dovevano quindi
essere
complete seppur danneggiate. Dopo il rinvenimento si cominciò la
ricerca di
testimonianze iconografiche che garantissero che si trattasse
proprio della
Chimera di Bellerofonte, indirizzando l'indagine soprattutto
sui reperti
numismatici. Dal Vasari (Ragionamenti sopra le invenzioni da lui
dipinte in
Firenze nel palazzo di loro Altezze Serenissime, Firenze 1558, ed
Arezzo
1762, pp. 107-8) si ricava e si ha testimonianza del metodo seguito
per
giungere ad affermare che il "leone" scoperto ad Arezzo era proprio
la
Chimera. Ad un interlocutore che domanda se si tratta proprio della
Chimera
di Bellerofonte, come dicono i letterati, il Vasari così
risponde:
"Signor sì, perche ce n'è il riscontro delle medaglie che ha il
Duca mio
signore, che vennono da Roma con la testa di capra appiccicata in
sul collo
di questo leone, il quale come vede V.E., ha anche il ventre di
serpente, e
abbiamo ritrovato la coda che era rotta fra que' fragmenti di
bronzo con
tante figurine di metallo che V.E. ha veduto tutte, e le ferite
che ella ha
addosso, lo dimostrano, e ancora il dolore, che si conosce nella
prontezza
della testa di questo animale...".
Quindi, per risolvere i
problemi interpretativi che si erano venuti a creare
con il ritrovamento
della statua, l'indagine non si limitò alle
testimonianze letterarie e
mitologiche, ma progredì nella ricerca di
documentazioni iconografiche
antiche, particolarmente per quello che
concerneva la documentazione
numismatica. E non si può escludere che la
ricerca di medaglie avesse come
fine ultimo quello di scoprire un modello
per restaurare la statua che
mancava della coda. Infatti, furono trovate
delle monete d'argento di Sicione
recanti l'immagine della Chimera. Queste
monete, ora nel Medagliere del Museo
Archeologico di Firenze, facevano
presumibilmente parte delle Collezioni
Granducali. Esse mostrano la Chimera
con la giusta posizione della coda,
formata dal serpente. La coda con la
testa di serpente doveva avventarsi
minacciosa contro l'avversario e non
mordere un corno della testa della
capra: si tratta infatti di un restauro
sbagliato eseguito, in epoca
neoclassica, da Francesco Carradori nel 1785.
I Medici e la Chimera
La
Chimera, come abbiamo detto sopra, fu subito portata a Palazzo Vecchio
nella
sala di Leone X: si trattava di un'operazione non solo artistica (in
quanto
si adattava al progetto decorativo stabilito dal Vasari) ma
anche
"strategica"; in questo senso la Chimera, l'opera più
importante
dell"'etruscheria" toscana, stava anche a simboleggiare le fiere
che Cosimo
aveva combattuto e domato per costruire il suo regno.
Il
mito
Chìmaira, in greco, letteralmente significa capra. Ed infatti questo
mostro
della mitologia greca con il corpo e la testa di leone, talvolta
alato, con
la coda a forma di serpente, portava nel mezzo della schiena una
testa di
capra. Omero (II. VI, 181-182) ed Esiodo (Theog., 321-322) narrano
che era
figlia di Tifone. La Chimera fu uccisa dall'eroe Bellerofonte,
ritenuto da
alcuni addirittura figlio di Posidone; Bellerofonte riuscì a
catturare e
domare il cavallo alato Pègaso, con il quale riuscì ad uccidere
la Chimera.
La statua bronzea del Museo Archeologico di Firenze rappresenta
la Chimera
ferita in atto di avventarsi sul suo aggressore, mentre la testa
di capra si
reclina, morente, per le ferite ricevute.
La coda con la testa
di serpente, come abbiamo detto, è un restauro non
giusto: doveva avventarsi
minacciosa contro l'avversario e non mordere un
corno della testa della
capra. Probabilmente, la Chimera faceva parte di un
gruppo con Bellerofonte
sul Pegaso che colpiva dall'alto, come fa supporre
la ferita sanguinante sul
collo della capra. Però non si può escludere
completamente 1 'ipotesi che si
trattasse di un dono votivo a se stante.
La datazione
Molto si è
discusso sull'appartenenza della Chimera all'arte etrusca, tesi
ormai
accettata senza riserve dagli studiosi. La "maniera etrusca" già
notata dal
Vasari si riflette in quel misto di naturalismo (nella
muscolatura e nelle
vene rilevate, rese con calligrafico realismo, del corpo
teso del leone) e di
stilizzazione (nella testa con fauci spalancate in atto
di feroce aggressione
e nel pelame della criniera e del dorso, reso con
ciocche dette
convenzionalmente "a fiamma"); di conservatorismo (negli
elementi
convenzionali arcaizzanti della testa e della criniera) e di
intensa
espressività (nell'aggressività feroce del muso del leone e nel
patetico
abbandono della testa della capra). Altro elemento a favore della
etruschità
di questa opera d'arte è la iscrizione sulla branca anteriore
destra,
tracciata sul modello ed eseguita insieme alla fusione. Vi si legge
tinscvil,
cioè dono votivo al dio Tinia (assimilabile al Giove dei Romani).
Si tratta
di un'iscrizione dedicatoria con caratteristiche grafiche
appartenenti
all'area etrusco-settentrionale, cosa che avvalorerebbe
l'ipotesi di una
offi- cina nord-etrusca, localizzata ad Arezzo o in zona
contigua. Per quanto
riguarda la datazione, quella finora consueta della
fine del V secolo a.C. è
universalmente abbassata ai primi decenni del IV
sec. a.C.
La
collocazione al Museo Archeologico
Come abbiamo detto sopra, la Chimera
rimase a lungo, come un simbolo, a
Palazzo Vecchio e solo molto tempo dopo,
nel 1718, venne trasportata nella
Galleria degli Uffizi, proprio come oggetto
da esporre in museo. Non a caso
fu trasportata agli Uffizi: in questo
periodo, la famiglia Medici non era
più quella potente di una volta e
cominciava anche, lentamente, uno studio
più serio sull"'etruscheria", che
andava ben oltre la semplice curiosità.
Dopo il 1879 ci furono forti
pressioni perche tutto il materiale antico
fosse collocato nel Palazzo della
Crocetta, l'odierna sede del Museo
Archeologico. Lo scopo fu raggiunto solo
in parte, ma tra le opere
trasferite ci furono l'Idolino, la Chimera ed altri
bronzi classici (1890).
MATER MATUTA
Provenienza: Chianciano (Siena).
Venne scoperta probabilmente nel 1846 o nel
1847 da Luigi Dei in un terreno a
1 krn. a sud di Chianciano, in località
'La Pedata'.
Stato di
conservazione: lacunoso, con numerose reintegrazioni.
Datazione: 450-440
a.C
La statua-cinerario aveva subìto un primo restauro ad opera di
restauratori
chiusini dell'800, i quali, seguendo il gusto e la moda
dell'epoca, avevano
integrato le parti mancanti con tasselli, scolpiti nella
stessa 'pietra
fètida' della scultura (pietra arenaria a grana finissima,
tipica delle cave
esistenti nelle vicinanze di Chiusi), tenuti insieme da un
impasto di
polvere di pietra fètida e di gomma collosa di natura organica, in
modo da
ottenere l'effetto di integrità.
A causa dei danni rilevanti
arrecati alla Mater Matuta dall'alluvione del
1966, fu necessario un nuovo
intervento di restauro, effettuato con tecnica
perfezionata e rigore
scientifico, che ha pennesso di discernere le parti
autentiche del monumento
dai posticci del restauro ottocentesco ( eliminati,
quindi, nella nuova
ricostruzione).
Il cinerario è in fonna di statua femminile, che regge sul
grembo un
bambino, avvolto in un panno. La figura è seduta su un trono, di
fonna
cubica, con i braccioli pieni a fonna di finge accosciata con le ali
aperte.
La testa, mobile, fungeva da coperchio; ugualmente mobili sono i
piedi. Il
corpo, che fa un tutt'uno con il tronco, fu probabilmene ricavato
da un
unico blocco di pietra. Nell'interno della statua, secondo Milani,
furono
rinvenuti l'oinochòe plastica a testa femminile e lo spillo d'oro
con
decorazione granulare, conservati nella vetrina adiacente.
La
statua-cinerario di Chianciano, variamente identificata con una
divinità
(Bona Dea; Tujltha, la dea degli Etruschi protettrice dei morti,
Proserpina;
o Mater Matuta) con tutta probabilità rappresenta una defunta con
il suo
bambino. Dal punto di vista stilistico si nota una tale discrepanza
tra
l'esecuzione della testa e quella del corpo (fenomeno, questo,
tuttavia
frequentissimo nell'arte etrusca, che si rinnova, anche in epoca
posteriore,
nelle figure dei defunti sui coperchi delle urne), da far pensare
che siano
stati prodotti in botteghe diverse. Il corpo, massiccio, si stacca
appena
dal blocco cubico del trono; il panneggio del chitone e del himàtion è
reso
con vivo plasticismo e senso volumetrico nelle ampie e pesanti
pieghe
accentuate soprattutto sulle gambe. Molto bella è la testa, con
capelli
spartiti sulla fronte, trattenuti da una tenia e ricadenti sulle
tempie in
bande ondulate; volto ovale con grandi occhi a mandorla,
sottolineati da
palpebre pesanti; naso diritto; bocca con labbra carnose,
leggermente
aggettanti, che ne accentuano l'espressione serena e pensosa, che
riflette
una eco della grande arte greca del V sec. a.C. La datazione è stata
molto
discussa, oscillando tra la metà del V ed il IV sec a.C. Gli oggetti
del
corredo (la oinochòe a testa femminile, datata dal Beazley a1470-450 a.C.
e
lo spillo d'oro granulato, datato nel 2° venticinquennio del V sec.a.C.)
ed
i dati iconografici sembrano confermare la datazione della Mater Matuta
al
450-440 a.C. Per il suo uso come cinerario, la Mater Matuta si collega
ai
canopi chiusini.
Il canopo (o più propriamente "ossuario antropòide")
non è che un 'urna
cineraria con copertura a testa umana, tipica e
caratteristica della regione
chiusina. A sua volta, il canopo si riallaccia
ad una lunga tradizione, che
sorge nella civiltà villanoviana. Infatti, la
copertura ad elmo di alcuni
ossuari villanoviani (generalmente coperti da
ciotola-coperchio monoansata)
non è che un principio di antropomorfizzazione,
che troverà il suo pieno
sviluppo proprio nell'ossuario antropoide chiusino.
Cronologicamente, i
canopi vanno dalla metà del VII al principio dell'età
ellenistica (IV
sec.a.C.). I canopi, come le statue-cinerario, hanno una
testa mobile, che
chiude il vaso contenente le ceneri; anche essi sono posti
su di un sedile
di trono, spesso in terracotta, talora in lamina bronzea, più
modesto dei
troni delle statue-cinerario, ma indicante una chiara intenzione
di onorare
il ricordo del defunto. Sia i canopi che le statue-cinerario sono
peculiari
dell'ambiente chiusino e attestano la continuità coerente e
costante di una
cultura artistica che può aver determinato il fiorire in
Chiusi di una
scuola scultorea di notevole importanza. Ciò è dovuto
prevalentemente al
tipo di fiorente economia agraria, che Chiusi sviluppa in
modo particolare,
ma che si ritrova anche in altre città dell'Etruria interna
(a differenza di
quanto troviamo nei centri dell'Etruria costiera, la cui
florida economia
commerciale e marittima subisce un arresto ed una
conversione da mercantile
ad agraria soltanto dopo la sconfitta etrusca a
Cuffia del 474 a.C. e la
conseguente perdita del dominio sul mare).
Il
SARCOFAGO di LARTHIA SEIANTI
Provenienza: tomba a camera della gens
Larcna, rinvenuta nel 1877 in loc.
Martinella, un km a NE di
Chiusi.
Stato di conservazione: il sarcofago, pressochè intatto,
conserva gran parte
della policromia antica, frequente in monumenti del
genere, ma spesso
sbiadita irrimediabilmente dal tempo e dalle condizioni di
giacitura dei
reperti. Realizzato in terracotta, fu confezionato in quattro
parti distinte
(e poi giustapposte) per l'impossibilità di cuocere insieme il
grande
coperchio e la grande cassa. La figura è stata eseguita a mano libera;
per
la decorazione della cassa si è probabilmente fatto uso di
stampi.
Datazione: secondo quarto delll secolo a.C.
Soggetto: la
defunta è immaginata semidistesa sulla kline, il busto tenuto
eretto
puntellando il braccio sinistro su due cuscini a bande gialle,
bianche e
violacee (nell'indicazione dei colori seguiremo anche le
descrizioni del
pezzo al momento della scoperta, quando essi erano più vivi)
dalle lunghe
frange gialle e viola. Tiene nella mano sinistra aperta, dalle
dita
inanellate, uno specchio circolare: la superficie riflettente interna è
in
azzurro, la cornice perlinata in giallo e deve quindi essere
immaginata
aurea. La destra discosta dal volto, in un gesto di pudicizia, un
lembo
dell'ampio mantello bianco, bordato da una striscia violacea tra due
minori
verdi, che le avvolge le spalle, i fianchi e le gambe, coprendo una
tunica,
pure bianca, decorata da tre bande verticali (due laterali violacee
ed una
verde centrale) e da una banda a V che sottolinea la scollatura.
Stringe la
tunica, poco sotto il seno, una cintura annodata, gialla,
frangiata, con
motivi rilevati a fulmine ed a dischetto, con punto centrale
rosso (forse ad
indicare l'inserzione di una qualche pietra dura). I piedi,
con calze verdi,
calzano sandali con legacci verdi decorati con borchiette
gialle. La chioma,
a corte ciocche regolari che incorniciano la fronte, reca
un diadema (o
forse una ghirlanda) di fiori in giallo; ricordano l'oro la
collana a
girocollo con pendente, la bulla a testa di Medusa sullo scollo, le
due
armille sul braccio destro. Gli orecchini, a disco con pietre rosse,
hanno
un pendente a ghianda.
Il fronte della cassa è decorato secondo un
chiaro partito architettonico,
generato forse dalla particolare ideologia
funeraria etrusca (la tomba vista
come casa del defunto), o forse, più
semplicemente, mediatovi come elemento
decorativo. E' ripartito in quattro
settori da cinque pilastrini scanalati
con capitelli compositi, che
sorreggono una fila di ovoli ed un listello
piatto su cui è impresso il nome
della defunta. I pilastrini inquadrano
spazi rettangolari decorati con due
rosoni a rilievo violacei e rossi,
intercalati a due pàtere umbelicate
dipinte di giallo.
Il ritratto: come vedremo, l'iscrizione tracciata sul
sarcofago al momento
della sua esecuzione, venne poi sostituita, prima
dell'uso effettivo, da un'
altra, con un diverso nome: il fatto rende
ancorpiù evidente il problema
dell'eventuale valore ritrattistico della
figura sul coperchio. In effetti
lungo e dibattuto è, in generale, il
problema del ritratto, del suo nascere
e fiorire e, soprattutto, di quando si
possa parlare, per una testa, di
ritratto nella "moderna" accezione del
termine. Nella sua evoluzione sono
state individuate le seguenti tappe: 1)
ritratto intenzionale: il primo
impulso al ritratto, che si manifesta nella
sua forma più ingenua,
attribuendo un nome determinato ad una immagine
generica; 2) ritratto
tipologico: la genericità dell'immagine si attenua,
cercando di indicare con
essa la classe di appartenenza del personaggio
raffigurato (un re, un
guerriero, un dio, una matrona), e la sua età
(giovane, vecchio). La III e
la IV tappa tendono ad imitare precisamente le
fattezze individuali del
soggetto, riproducendone veristicamente i tratti
somatici (ritratto
fisionomico) ed infine cercando di conferire ad essi un'
espressione
psicologica che meglio connoti il personaggio: è il ritratto
fisionomico, il
ritratto come oggi lo concepiamo.
Nel monumento, la
caratterizzazione del volto è piuttosto scarsa e non
sembra andare oltre la
generica rappresentazione di una giovane matrona
pomposamente recumbente
sulla sua ricca kline, nello sfoggio della sua
ricchezza. La notevole
somiglianza del volto stesso con quello dell'analogo
sarcofago di Seianti
Tanunia conservato presso il British Museum di Londra,
ci convince ad
assegnarlo all'ambito del semplice "ritratto tipologico". L'
iscrizione:
larqia:seianti:s.i:sve.(impressa nell'argilla); ...ti
a:lar...lisa: niasa
(dipinta sullo stucco che ha coperto la prima): vedi
Corpus Inscriptionum
Etruscarum 1215.
Impressa sul listello superiore della cassa prima della
cottura, quando
l'argilla era ancora cruda, l'iscrizione indica il nome della
defunta, o
forse il nome del personaggio che commissionò il sarcofago, senza
poi
usarlo. L'iscrizione, in effetti, risultava, al momento della
scoperta,
parzialmente riempita e ricoperta da uno strato di stucco (alcune
lettere
sono ancora mal leggibili) sul quale era stato dipinto un secondo
nome,
diverso dal primo, oggi quasi completamente scomparso. Poco chiaro
per
questo il reale rapporto tra la defunta seppellita nel nostro sarcofago
e
gli altri personaggi sepolti nella stessa tomba, sicuramente pertinente
alla
famiglia larcna.
Il corredo: attorno al sarcofago furono
rinvenuti i seguenti oggetti.
Argento: craterisco in lamina; padella; doppio
pettine; tre pàtere; tre
spilloni; un cucchiaino per cosmetici; tre aghi
(forse frammento di una
fibula); un paio di pinzette; vetro: cinque pedine da
gioco, di vario
colore; alabastro: due anforischi; bronzo: una fiaschetta in
lamina; un asse
romano.
Possiamo agevolmente distinguere tre gruppi di
materiale: il vasellame da
mensa miniaturizzato, gli oggetti da toeletta, la
moneta. Proprio quest
'ultima, presente nel corredo come obolus Carontis,
cioè come offerta che la
defunta elargirà al traghettatore degli Inferi al
momento di esser
trasportata nel mondo dei morti, ci fornisce un utile dato
cronologico per
la datazione della tomba: il monetiere che ha curato la sua
coniazione è
infatti M. Titinius, che sappiamo attivo a Roma tra il 189 ed il
180 a.C..
La sepoltura sarà dunque di poco posteriore a tale epoca, visto che
la
datazione tipologica degli altri oggetti di corredo non può scendere
molto
nel II sec. a.C. I ricchi oggetti da toeletta non fanno che
completare,
stavolta con l' oggetto reale, la ricca parure già esibita dalla
figura sul
coperchio.
Il vasellame da mensa, miniaturistico, rimanda al
mondo del banchetto
aristocratico: una delle manifestazioni tipiche del
vivere gentilizio,
esaltata nei cicli pittorici delle tombe di Tarquinia
(Tomba del Triclinio,
Tomba dei Leopardi...) come anche e soprattutto dalla
figura sdraiata a
banchetto dei grandi sarcofagi maschili ( cfr. quello
dell'obesus ) e delle
piccole urne cinerarie. Il particolare pregio del
metallo con cui tali
oggetti di corredo sono stati realizzati costituisce
un'ulteriore prova
della estrema ricchezza della defunta. Una ricca signora,
dunque,
debitamente onorata anche nell ' oltretomba: uno dei tanti indizi
della
particolare considerazione della donna nel mondo etrusco. Una
considerazione
spesso esagerata da certi moderni, specie influenzati dalla
propaganda
"scandalistica" della storiografia greca. Una società
rigidamente
androcentrica non poteva che stigmatizzare negativamente la
libertà ad essa
concessa, ancor più se questa lo era da un mondo
economicamente in
competizione, quale quello etrusco. Al di là di facili
esagerazioni possiamo
comunque riscontrare numerose prove di un diverso ruolo
rivestito dalla
donna etrusca rispetto ad altre civiltà antiche,
assolutamente
androcentriche. Un esempio tra tutti, quello offertoci
dall'onomastica. Le
formule onomastiche antiche citano il nome del padre, il
patronimico; quelle
etrusche citano talvolta anche il nome della madre, il
metronimico (che però
mai sostituisce il primo!). Si veda, come esempio,
l'iscrizione tarquiniese
CIE 5471:
Larth Arnthal Plecus clan Ramthasc
Apatrual..., cioè Larth, figlio di Plecus
e di Ramtha Apatrui.
Mentre la
donna romana, inoltre, non possedeva un prenome, cioè un nome
proprio,
diverso dal nome familiare (ossia il gentili zio che, volto al
femminile, la
designava), la donna etrusca aveva invece il proprio prenome
al pari
dell'uomo. Il diverso rilievo della donna etrusca nell'ambito delle
società
antiche ci è poi confermato anche da altri indizi, anche storici: è
l'etrusca
Tanaquilla, moglie di Tarquinio Prisco, che, alla morte del
marito, impone a
Roma il regno di un sovrano ne appartenente alla linea
dinastica, ne voluto
da (almeno apparenti) forze politiche interne: Servio
Tullio (vedi Livio,
1,34).
La Lingua
L'etrusco è una lingua costruita in un alfabeto di
origine greca e affine
all'alfabeto latino. Le incognite che ancora oggi la
lingua etrusca presenta
sono da attribuire alla sua estraneità rispetto ai
gruppi linguistici noti.
A detta degli antichi, tra cui lo storico Dionigi di
Alicarnasso, la lingua
parlata dagli Etruschi era diversa da tutte le lingue
conosciute. Dopo la
conquista romana, essa fu a poco a poco sostituita dal
latino, fino ad
uscire completamente dall'uso.
Il presunto
mistero
Il materiale: entità e caratteristiche delle testimonianze
superstiti
Documentazione diretta
Documentazione indiretta
II processo
interpretativo
Alfabeto etrusco
Piccolo vocabolario
etrusco
Trascrizione delle iscrizioni
Iscrizioni indicanti
alfabeti
Il presunto mistero
Contrariamente a
quanto molti ancora suppongono, i documenti della lingua
etrusca sono
tutt'altro che 'indecifrati' o 'indecifrabili': scritti con un
alfabeto di
derivazione greca, di tipo euboico ('rosso', cioè occidentale,
secondo la
divisione stabilita da A. Kirchhoff delle scritture dei Greci),
fin dal
secolo scorso si leggono senza nessuna particolare difficoltà; ma
anche in
precedenza, salvo qualche dubbio relativo a singoli segni, l'
epigrafia aveva
rappresentato il capitolo forse più solido nell'intero
panorama
dell'etruscologia.
Sappiamo dunque che già nel tardo VIII secolo a.C. gli
Etruschi erano
certamente in possesso d'un alfabeto, introdotto in Italia
centrale da
coloni euboici dell'isola d'Ischia e comprendente ventisei
lettere, come si
desume da una tavoletta d'avorio, dalla finalità
evidentemente scolastica,
ritrovata a Marsiliana d'Albegna (Grosseto). Ma
quattro lettere non sono
effettivamente impiegate (la b, la d, la s sonora e
la o, che si confondeva
col suono u), mentre per il suono f dal VI secolo
a.C. è introdotto un segno
apposito. La scrittura procede normalmente da
destra verso sinistra; assai
più raramente, da sinistra a destra ovvero con
andamento bustrofèdico, cioè
alternato riga per riga. In epigrafi meno
antiche si possono incontrare
puntini di separazione tra le parole. In realtà
il problema è un altro ed è
un problema d'interpretazione linguistica, non di
decifrazione epigrafica:
quello d'intendere il significato dei testi, redatti
in una lingua che non
sembra imparentata con nessun altra delle antiche o
moderne proposte alla
comparazione, e di elaborare, possibilmente, una
descrizione grammaticale,
morfologica e sintattica, di questa lingua, che è
poi la condizione stessa
della sua conoscenza effettiva. E, da tale punto di
vista, bisogna ammettere
che, nonostante lo sforzo grandioso di molte
generazioni di studiosi, i
risultati sicuri permangono pochi e settoriali; e
ciò non per insufficienza
d'impegno o per inadeguatezza dei metodi adottati,
ma per la qualità
medesima dei documenti disponibili. Infatti le iscrizioni
etrusche, anche se
numerose (circa 10.000), vengono in grandissima parte da
necropoli; sono
perciò di carattere funerario e generalmente molto brevi.
Esse ci danno
perciò soprattutto, se non soltanto, nomi di persona e
indicazioni
anagrafiche elementari, pur essendo in gran parte abbastanza
facilmente (ma
talvolta approssimativamente) traducibili.
I pochissimi
testi etruschi più complessi - un rituale scritto su un rotolo
di tela poi
utilizzato per avvolgere una mummia, ora al Museo di Zagabria;
una tegola
iscritta, proveniente da Capua, a Berlino; il Cippo di Perugia -
suscitano
invece gravi difficoltà nell'interpretazione, anche perché non si
conoscono
per il momento ampi documenti bilingui a carattere di traduzione
letterale
(del tipo della Stele di Rosetta). Ciononostante la pazienza degli
indagatori
conduce pian piano a singole acquisizioni che, pur nei limiti
quasi
invalicabili imposti dalla quantità e dalla qualità dei documenti (ai
testi
epigrafici bisogna aggiungere le parole etrusche riportate dagli
scrittori
antichi), possono organizzarsi in un disegno generale abbastanza
ben
definito. Dopo l'esperienza dei metodi 'etimologico' (che presupponeva
la
parentela dell'etrusco con altre lingue conosciute) e 'combinatorio'
(rivolto
ad analizzare solo per via interna la 'combinazione' degli
elementi
costitutivi del testo), in anni recenti hanno trovato sviluppo due
nuovi
modi d'accostare il problema linguistico: il cosiddetto
'bilinguismo',
promosso specialmente da Massimo Pallottino, che integra
l'analisi
combinatoria con l'uso di fonti interpretative esterne (per
esempio, il
confronto con formule di dedica latine e greche); e lo
'strutturalismo' di
Helmut Rix, che reputa sufficiente una descrizione della
'struttura' dei
testi a chiarirne anche il significato. Della grammatica
dell'etrusco non è
qui il caso di parlare diffusamente, perché
c'introdurrebbe in un terreno di
ardua e complicata spiegazione. Preferiamo
dare al lettore l'esempio di una
declinazione di sostantivo ormai
sufficientemente accertata (secondo gli
schemi di lingue più note, come il
greco e il latino e quello di un
'epigrafe funeraria abbastanza
traducibile.
Ecco il modello di declinazione del sostantivo methlum (che
significa 'nome
'): methlumes ('del nome'); methlumth ('nel mome', con valore
locativo);
methlumeri ('al nome'). Ed ecco invece l'esempio di epigrafe
funeraria (si
tratta dell'iscrizione incisa su un sarcofago da Norchia e
riportata sia nel
Corpus Inscriptionum Italicarum di A. Fabretti, N. 2070,
sia nel nuovo
Corpus Inscriptionum Etruscarum, N. 5874): Arnth Churcles
[Arnth Churcle],
Larthal [di Larth] clan [figlio] Ramthas Nevtnial [(e) di
Ramtha Nevtni],
zilc parchis [pretore] amce [fu] marunuch [appartenente al
collegio dei
'maroni'] spurana [urbano] cepen [sacerdote] tenu [ha
esercitato], avils [di
anni] machs [cinque] semphalchls [(e) settanta] lupu
[è morto].
Il materiale: entità e caratteristiche delle
testimonianze superstiti
Si è già detto che uno dei fondamentali fattori
negativi per la conoscenza
della lingua etrusca (e potremmo aggiungere più
generalmente della civiltà
etrusca) è costituito dalla ristrettezza della
documentazione. Tuttavia
questa documentazione è tutt'altro che trascurabile:
si tratta infatti del
più ingente complesso di testimonianze scritte di una
lingua antica parlata
in Italia, e nell'intero Mediterraneo
centro-occidentale, a parte il greco,
il fenicio-punico e il latino; in età
arcaica gareggia per entità con i
resti epigrafici di queste stesse lingue;
ed è in continuo aumento. Proprio
il flusso delle nuove scoperte ravviva la
speranza che il futuro, anche
prossimo, possa riservarci ulteriori sorprese.
È più che probabile che il
sottosuolo etrusco nasconda ancora un ricco
patrimonio di iscrizioni. Non si
può escludere che un' attenta indagine nelle
aree dei maggiori centri urbani
porti al ritrovamento di testi epigrafici di
carattere pubblico,
storico-commemorativo o giuridico eventualmente redatti
in etrusco e in
latino (ciò che è ben possibile per le fasi più recenti
dell'Etruria
sottomessa o federata a Roma).
Rimarrà naturalmente comunque
l'incolmabile lacuna dell'assenza di testi
letterari, per cui ci è preclusa
la possibilità di conoscere l'etrusco alla
stessa stregua delle altre lingue
del mondo classico. In teoria documenti
letterari etruschi potrebbero
scoprirsi nel futuro in papiri dell'Egitto o
di Ercolano (se si tien conto
del già avvenuto miracolo - che di un vero
miracolo dobbiamo parlare - del
rinvenimento di un testo etrusco sulle bende
di tela di una mummia egiziana);
ma si tratta purtroppo di possibilità tanto
tenui e remote da potersi
definire chimeriche.
Documentazione diretta
Le
testimonianze che attualmente possediamo aifini della conoscenza della
lingua
etrusca si distinguono in dirette e indirette. Testimonianze dirette
sono i
testi: in gran parte editi nel C.I.E.. in altre raccolte e
rassegne
specifiche, ed in varie pubblicazioni monografiche e periodiche;
alcuni
pochi ineditì (soprattutto quelli che continuamente vengono in luce,
nella
fase che segue immediatamente la loro scoperta). Si tratta di
materiale
tutto di carattere epigrafico, cioè di iscrìzioni sopra monumenti
od oggetti
di scavo, salvo i frammenti del libro della mummia di Zagabria,
che ha
tuttavia anch'esso una provenienza archeologica.
Quest'ultimo
documento è di importanza eccezionale non soltanto per la
civìltà etrusca, ma
anche più generalmente per le antichità classiche,
trattandosi dell'unico
libro sacrale su tela (liber linteus) che ci sia
stato conservato per il
mondo greco ed italico-romano. Aveva originariamente
la forma di un panno
rettangolare ripiegato, quale è riconoscibile in alcuni
monumenti funerari
etruschi. Fu poi tagliato in strisce ed impiegato per
avvolgere la mummia di
una donna egiziana, di età tolemaica o romana,
scoperta probabilmente nel
medio Egitto (ma il luogo di ritrovamento è
incerto). Questa utilizzazione,
nella quale andarono perduti importanti
frammenti del testo originario, è
senza dubbio secondaria; ignoriamo quali
precedenti circostanze abbiano
determinato la presenza di un libro religioso
etrusco in Egitto. La mummia fu
portata in Europa da un viaggiatore croato e
poi dònata al Museo Nazionale di
Zagabria, dove J. Krall riconobbe la
scrittura delle fasce come etrusca.
Riaccostando tra loro queste bende, si è
potuto ricostruire un testo scritto
entro i limiti di almeno dodici colonne
verticali: esso consta attualmente di
circa 1200 parole più o meno
chiaramente e completamente leggibili, alle
quali si può aggiungere almeno
un centinaio di altre parole che si
ricostruiscono dal contesto. Data la
frequenza delle ripetizioni, il numero
delle parole sicure diverse fra loro
si riduce a poco più di 500. Comunque il
libro di Zagabria è senza paragone
il più lungo ed il più importante di tutti
i documenti etruschi finora in
nostro possesso.
Le iscrizioni, scoperte
soprattutto nell'Etruria tirrenica, campana e
padana - in minor numero o
eccezionalmente nel Lazio, in territorio umbro e
fuori d'Italia (Africa,
Francia meridionale) -, sono incise o dipinte sopra
elementi architettonici,
pareti di tombe, cippi, sarcofagi, urne, tegole,
statue, arredi, laminette
metalliche, vasi, ecc. Esse ammontano ad oltre
diecimila; ma solo pochissime
sono di entità rilevante. Tra queste alcune
hanno il carattere di documenti
autonomi non legati alla natura
dell'oggetto, nel senso cioè che il loro
supporto mobile ha la funzione di
una specifica superficie scrittoria (non
diversa da quelle di materiale
deperibile come i volumi di tessuto o di
pelle, le tabelle e i dittici
lignei, ecc., che vediamo frequentemente
riprodotti nei monumenti figurati
etruschi, ma che nella realtà sono andati
perduti a causa del nostro clima,
mentre il clima secco dell'Egitto ha
salvato illiber linteus di Zagabria).
La più lunga è inscritta sopra una
lastra di terracotta in forma di tegola
proveniente da Capua e
successivamente passata ai Musei di Berlino: esso
consta di 62 righe
conservate, divise in dieci sezioni, con quasi 300 parole
leggibili; la
seconda parte del testo è molto rovinata; la scrittura è
tracciata a righe
alternativamente rovesciate in modo da imitare il
procedimento detto
bustrofedico. Un testo graffito su ambedue le facce di un
lungo nastro di
lamina di piombo, purtroppo trovato in frammenti, è venuto
recentemente alla
luce in un piccolo santuario presso Santa Marinella (C. I.
E. 6310): vi si
leggono tracce di almeno 80 parole, di cui solo una
quarantina leggibili
integralmente; ed è inciso con lettere di proporzioni
miniaturistiche. Una
laminetta lenticolare anch'essa di piombo rinvenuta a
Magliano e conservata
nel Museo Archeologico di Firenze (C. I. E. 5237) è
caratterizzata da una
iscrizione incisa, sui due lati, a spirale con
movimento dal margine esterno
verso il centro: vi si contano almeno 70
parole (talvolta non è facile
distinguere se un gruppo di lettere contiene
una o due parole).
Un
carattere del tutto particolare, per la loro materia e la loro
importanza
linguistica e storica, hanno infine le lamine d'oro scoperte nel
santuario
di Pyrgi, già più volte citate, di cui due scritte in etrusco una
in fenicio
(C.I.E. 6314-6316); l'etrusca più lunga, di 15 righe e 36 o 37
parole,
corrisponde a quella fenicia (nel senso di una bilingue, come già
sappiamo);
mentre la più breve è di 9 righe e 15 parole). Non mancano altri
documenti
di un certo sviluppo su lamine metalliche, come le tabellae
defixionis (cioè
consacrazioni a divinità infere di persone che si vogliono
maledire:
specialmente quelle di Monte Pitti C.I.E. 5211 e di Volterra C.I.E.
52) e
alcune di contenuto non precisabile.
Fra i titoli propriamente
epigrafici eccelle il cippo di pietra, pro-
babilmente confinario, del Museo
di Perugia (C.I.E. 4538), che pre- senta su
due facciate una lunga e bella
iscrizione scolpita di 46 righe e 136 parole.
Tra le iscrizioni funerarie
alcune sono estese come quella del sarcofago di
Laris Pulenas del Museo di
Tarquinia (C. I. E. 5430), tracciata sul rotolo
aperto esibito dal defunto
scolpito sul coperchio, con 9 righe e 59 parole;
ma ne esistono anche altre
non meno lunghe e rilevanti, benche più rovinate,
dipinte sulle pareti delle
tombe di Tarquinia. Esistono inoltre diverse
epigrafi di sepolcri, sarcofagi,
cippi che presentano alcune righe di testo
ed una certa varietà di parole; ma
la grandissima maggioranza consta di
poche parole ed è redatta secondo
formule fisse; non mancano alcune brevi
bilingui etrusco-latine. Le
iscrizioni dedicatorie su oggetti mobili si
distinguono in un gruppo arcaico,
con proprie formule ed il nome del
dedicante, e in un gruppo più tardo in cui
è più frequente il nome della
divinità; ma, tolte le leggende piuttosto
estese di alcuni vasi arcaici,
sono anch'esse generalmente brevi e
stereotipe. Dobbiamo ricordare infine le
innumerevoli leggende esplicative
delle figurazioni tombali, dei vasi
dipinti, degli specchi, ecc., le
iscrizioni su monete, proiettili di piombo
e altri oggetti minimi, le marche
di fabbrica, in gran parte con nomi
propri. Si aggiungano, per la loro
singolarità, i famosi dadi da giuoco di
avorio detti provenire da Tuscania e
conservati nella Bibliothèque Nationale
di Parigi, con parolette (certamente
numerali) su ciascuna delle sei facce.
Documentazione
indiretta
Fonti indirette per la conoscenza dell'etrusco sono: 1) le
glosse, ed altre
informazioni offerte dagli scrittori classici e
postclassici; 2) gli
elementi etruschi passati nel latino e gli elementi
comuni etrusco-italici;
3) gli elementi etruschi sopravvissuti nella
toponomastica; 4) i supposti
frammenti di versioni latine da testi originari
etruschi.
Le glosse sono parole etrusche delle quali è data la traduzione
latina o
greca: citate occasionalmente in testi di autori classici o inserite
in veri
e propri dizionari. Se ne contano una sessantina; ma il loro valore
come
elementi traduttori esterni, ai fini dell'interpretazione dell'etrusco,
è
piuttosto limitato: proprio come nel caso delle bilingui
etrusco-latine.
Glosse di carattere vario ci provengono da Varrone (de lingua
latina), da
Verrio Flacco (de verborum significatione), da Isidoro
(Etymologicum) e
specialmente nel Lessico di Esichio. A speciali categorie di
vocaboli
appartengono le glosse etrusche con nomi di piante medicinali e con
nomi di
mesi (Papia, Liber Glossarum di Leida) che pare si ritrovino anche
nei testi
etruschi: es. Aclus = giugno, cfr. nel testo di Zagabria.
Osservazioni di
carattere fonetico e grammaticale sull'etrusco, di
scarsissimo valore,
risalgono a Varrone, all' Ars de orthographia di M.
Cappella. Per alcune
parole l'origine etrusca è esplicitamente testimoniata
dagli scrittori
classici (mantisa. histrio. /ucumo. atrium. ecc.); per altre
è ipotetica e
si può anche pensare ad una formazione analogica, cioè a parole
latine che
imitino nella terminazione i derivati etruschi, come pure a
relitti del
generale substrato preindoeuropeo d'Italia, piuttosto che ad
imprestiti
dall'etrusco nella sua fase storica. Preferibilmente si riterranno
o
sospetteranno etrusche quelle parole latine di etimologia oscura e
di
terminazione etruscheggiante che si riferiscono al linguaggio tecnico
del
culto, delle istituzioni civili e militari, della tecnica, ecc. :
teniamo
presente il fortissimo influsso culturale esercitato dall'Etruria su
Roma
primitiva in questi settori. Ne mancano esempi di vocaboli per i
quali
l'etrusco è stato probabilmente intermediario tra il greco e il latino:
per
es. groma (nome di uno strumento di orientazione e misurazione dei
campi).
Non è da escludere neanche qualche limitato influsso dell'etrusco
sulla
fonetica e sulla morfologia del latino. Il problema in tutto il
suo
complesso meriterebbe un nuovo più attento esame, anche ai
fini
dell'ermeneutica etrusca. Ancora meno chiara è la questione di
eventuali
dirette sopravvivenzelessicali etrusche in volgari italiani;
mentre
l'ipotesi di una derivazione etrusca dell'aspirazione toscana è
accettata da
diversi linguisti.
La difficoltà fondamentale consiste
soprattutto nel distinguere tra i
diversi strati e le diverse aree di
diffusione dei toponimi preindoeuropei:
ad esempio tra voci toponomastiche di
tipo «mediterraneo» o «paleoeuropeo»
generale, diffuse anche nell'Italia
centrale (come i derivati dalle basi
carra-, pala-, gav-, ecc.), e voci
toponomastiche che invece derivano
dall'etrusco di età storica direttamente o
attraverso una forma latina come
alcuni nomi di città (per es. Bolsena da
Volsinii, etr. Velsna-). Vanno
infine menzionati gl'ipotetici esempi di
versioni in latino dall'etrusco.
Già sappiamo che il corpo dei libri sacri
etruschi fu tradotto o compendiato
in latino. Nelle congerie di riferimenti
indiretti, riassunti, rifacimenti
di scritti etruschi, dei quali qualche eco
è giunta fino a noi, si notano
alcuni brani che ci interessano non soltanto
per la conoscenza della
letteratura e della civiltà etrusca, ma anche per le
forme di espressione
che potrebbero riflettere una particolare struttura di
linguaggio: per
esempio il frammento tratto dai Libri Vegoici e riportato dai
Gromatici con
insegnamenti della Lasa Vegoia sulla divisione dei
campi.
II processo interpretativo
È evidente che
il nostro interesse si concentra soprattutto sulla
documentazione diretta,
cioè sui testi etruschi, mentre le fonti indirette
potranno se mai
considerarsi come dati accessori e ausiliari. Il problema
che intendiamo
affrontare in modo specifico a questo punto è dunque
essenzialmente quello
dell'interpretazione dei testi (o «ermeneutica» in
senso proprio, volendo
usare il termine tradizionalmente diffuso negli studi
etruscologici), cioè
della comprensione del significato dei documenti,
indipendentemente
dall'obiettivo della conoscenza della struttura della
lingua dei cui
risultati si darà conto nel capitolo successivo.
Il punto di partenza è la
constatazione ormai pacificamente e
incontrovertibilmente acquisita in sede
scientifica (contro ogni residua
disinformazione in materia) che esiste da
tempo una generale e basilare
capacità di leggere e capire, individuandone la
qualità e il senso o il
contenuto certo o approssimativo, ogni testimonianza
scritta etrusca che
costituisca l'illustrazione di monumenti figurati (nomi
di divinità e di
eroi, di persone, ecc.), o ricordi i defunti menzionandone
la genealogia,
l'età, la qualità o le azioni, o indichi l'appartenenza e la
destinazione di
singoli oggetti con particolare riguardo alle dediche votive,
e così via;
mentre per alcuni testi più lunghi di carattere rituale (è il
caso
specialmente del manoscritto della mummia di Zagabria, della tegola
di
Capua, della laminetta di piombo di Magliano si pensi al Cippo di
Perugina)
possiamo accostarci alla comprensione complessiva del valore del
documento,
talvolta alla sua articolazione in settori, paragrafi o frasi, e
perfino
alla interpretazione di singoli brani.
Il fondamentale ostacolo a
maggiori approfondimenti eprecisazioni è
rappresentato dalla incertezza dei
valori semantici di una parte notevole
del lessico etrusco, cioè del
significato di molte parole e radici, talvolta
anche ricorrenti con frequenza
e perciò sicuramente riferibili a concetti
importanti (per esempio la serie
di voci diffusissime ar, ara, aras, arce,
art?, ecc. , di cui, nonostante
tante autorevoli e motivate ipotesi, non
crediamo ancora possibile
considerare accertato il senso); ed in questi casi
occorrerà onestamente
confessare la nostra ignoranza. Di molte parole si sa
la rispondenza a
concetti generici senza possibilità di precise
oggettivazioni: così nei testi
rituali ricorrono termini con funzione
verbale dalle basi hec-, sac-, acas-,
ecc. , indicanti azioni di culto, più
o meno nel senso di offrire, porgere,
sacrificare, consacrare, forse
invocare; mentre termini come fase, cleva,
tartiria, acazr, debbono
corrispondere a singoli tipi di cerimonie e di
offerte a cose concretamente
offerte, sacrificate o donate, per altro non
distinguibili. Si sa d'altra
parte che la nozione generale di offrire,
donare, dare (nell'ambito sacro,
eventualmente votivo, ma anche
presumibilmente in quello profano) è espressa
con assoluta certezza dai
«verbi» mul-. tur-. al-: il cui reciproco
rapporto, di diversa sfumatura o di
diverso impiego preferenziale nel tempo
o di pura sinonimia, resta tuttavia
incerto. Il fatto è che per «tradurre»
esattamente non poche parole etrusche
occorre, od occorrerebbe, conoscere la
realtà dei concetti che ad essi si
sottendono sul piano religioso,
istituzionale, sociale, tecnico: problema,
dunque, non tanto linguistico
quanto piuttosto storico-culturale.
Ma i
nostri sforzi per intaccare questo grosso nucleo di oscurità del
lessico
etrusco, per precisare il significato di parole e di frasi
vagamente
intelligibili, e conseguentemente per interpretare sempre più
puntualmente e
sempre in maggior numero i testi, sono in continuo, seppur
lento e limitato,
progresso, soprattutto a seguito dell'ininter- rotto
acquisto di nuovo
materiale di studio, divenuto particolarmen- te sostanzioso
nel corso degli
ultimi anni, come già si è rilevato nel capitolo precedente.
Si può citare
come esempio tra i più istruttivi il caso della scoperta della
già
menzionata iscrizione ceretana «dei Claudii», che con l'espressione
apa-c
ati-c, manifestamente significante «e il padre e la madre» ( =
latino
paterque materque), conoscendosi già con certezza il valore ati =
«madre» e
l'uso della copulativa enclitica -c, ha consentito di
accertare
definitivamente il senso della parola apa = «padre», in precedenza
vagamente
sospettato e per così dire avvicinato e circuito, ma rimasto
nella
nebulosità dell'ipotesiI6. Analoga considerazione, come ben s'intende,
vale
per quanto si è detto a proposito della prova del valore ci = «tre»,
fornita
dalla corrispondenza bilingue delle lamine di Pyrgi. I risultati
finora
conseguiti si estendono naturalmente dal signi- ficato delle parole
alle
loro funzioni e correlazioni, che danno senso ai contesti. A
questo
proposito esistono alcune certezze elementari, come il rapporto
di
appartenenza o discendenza indicato da un suffisso di «genitivo»
nelle
usuali formule onomastiche: Larces clan «di Larce figlio».
Diremo
che esistono due soli principi di evidenza in assoluto: 1)
riconoscere
comechessia il significato e la funzione di singole parole; 2)
constatare la
natura del documento e, conseguentemente, desumerne il
contenuto complessivo.
Si tratta di approcci fondamentalmente diversi e, nei
loro sviluppi,
addirittura opposti. Il primo è basato su dati analitici, dai
quali,
attraverso un'indagine linguistica strutturale e combinatoria, si
tende alla
ricomposizione e ricostruzione del senso generale del testo (o
del contesto).
Il secondo, al contrario, considera i testi sinteticamente
per quanto essi
possano voler dire, partendo dalle loro caratteristiche
archeologiche e
affinità culturali, per poi discendere ai particolari della
valutazione
linguistica dei singoli elementi che li compongono.
Le prime parole
riconosciute e riconoscibili dell'etrusco sono i nomi
propri. Essi
costituiscono di fatto l'enorme maggioranza delle parole
presenti nelle
iscrizioni etrusche ed hanno rappresentato il fondamento
iniziale di ogni
loro tentativo d'interpretazione. Per quanto riguarda
l'onomastica personale
appariva ed appare immediata l'identità formale con
elementi onomastici
latini, prenomi (Marce: lat. Marcus) e nomi gentilizi
(Vipi: lat. Vibius); si
è constatata altresì un'analoga costruzione con
formula bimembre (prenome e
gentilizio) o trimembre (prenome, gentilizio,
cognomen) e presenza del
patronimico. Con altrettanta facilità si
riconoscono nomi divini comuni al
latino e all'etrusco (Menerva: lat.
Minerva. Selvans: lat. Silva- nus) e nomi
greci di divinità e personaggi
mitologici (Alexsantre, Elina, Elinai).
Aggiungiamo i toponimi ravvisabili
dalla loro forma latina (Pupluna: lat.
Populonia) e loro derivati con valore
di etnici (rumax «romano» da Ruma-
«Roma»).
Diverso è il caso per quel che riguarda tutto il resto del
patrimonio
lessicale etrusco, estraneo all'onomastica, cioè le parole comuni
o
appellativi. È qui che s'incontrano le difficoltà di fondo. Non
possiamo
contare su strumenti diretti di traduzione se non per le scarse e
malsicure
nozioni fornite dalle glosse. Si vorrebbe perciò ricorrere al
confronto con
radici e formazioni di parole di altre lingue, supponendo una
loro origine
comune, nel senso del vecchio metodo etimologico.
Passiamo
ora all'esame dell'altra possibilità di cogliere l'espressione di
un testo, o
di parte di esso, nella sua globalità partendo da indizi
esterni. Il tipo del
monumento o dell'oggetto inscritto è stato sempre, fin
dall'inizio, una guida
sicura per delimitarne il senso: tanto ovvia e
istintiva da restare per lungo
tempo sottintesa (se ne è avuta coscienza
critica soltanto con la
teorizzazione del metodo bilinguistico). È evidente
che l'epigrafe di un
sarcofago o di un loculo tombale non può che riferirsi
ad un defunto,
formulandosi presumibilmente nello stesso schema dei testi
funerari latini:
ciò che era stato avvertito già a partire dalle
osservazioni degli eruditi
del Settecento, con tutte le conseguenze relative
(onomastica personale,
rapporti e termini di parentela come clan = figlio,
sex = figlia, e così
via). Altrettanto evidente è che sugli oggetti mobili
(vasi, statuette di
bronzo, ecc.) debbono necessariamente comparire
annotazioni di proprietà o di
destinazione o, soprattuto se il luogo di
provenienza è un santuario, dediche
a divinità, implicanti la presenza del
nome dell'offerente, dei termini
esprimenti l'azione dell'offerta,
eventualmente del nome divino, come nelle
analoghe iscrizioni greche o
latine. Ancora più evidente è che le parole
scritte accanto a figure di
divinità o di eroi, per esempio in scene di
specchi o in pitture, sono
didascalie che notificano il personaggio
(cosiddette «bilingui figurate»).
Le parolette incise su ciascuna delle sei
facce dei dadi da giuoco «di
Tuscania» rappresentano senza il minimo dubbio
le prime sei unità numerali.
Ogni scarto da questi elementi di certezza non
può che condurre ad
interpretazioni aberranti.
L'evidenza «obiettiva»
desunta dall'accostamento di testi etruschi a testi
di altra lingua in
ambienti culturalmente vicini e per casi di dimostrabile
o presumibile af-
finità di contenuto può estendersi, sia pure con cautela,
anche a documenti
per i quali sono meno significativi gl'indizi offerti
dalla natura
archeologica dell'oggetto o del luogo, quale è soprattutto il
libro su tela
di Zagabria, le cui formule rituali sono state studiate
tentando di stabilire
paralleli con formule rituali umbre delle Tavole
Iguvine, o latine degli Atti
dei Fratelli Arvali, del de agricultura di
Catone, e altre.
Richiami
culturali e storici valgono talvolta a legittimare confronti anche
più
lontani, come quello fra il titolo di magistratura etrusca zilafh mexl
rasnal
(ricorrente con lievi varianti formali in iscrizioni del IV-III
secolo a.C.)
e il titolo onorifico latino di età romana imperiale praetor
Etruriae o
praetor (Etruriae) quindecim populorum, di cui si è già parlato:
esempio
significativo di una rispondenza generale che dà l'impressione di un
vero e
proprio «calco linguistico», ma che è più difficile analizzare nel
senso e
nel rapporto delle singole parole dei populi etruschi. Lo stesso
«principio
dei testi paralleli» come fonte primaria d'interpretazione
globale vale
ovviamente, per le vere e proprie bilingui. Le quali tuttavia,
salvo il caso
speciale di Pyrgi, sono poche e brevissime. Si tratta di
iscrizioni funerarie
redatte in etrusco e in latino, che presentano
corrispondenze di nomi
personali e solo eccezionalmente dati utili per la
conoscenza del lessico e
della grammatica. Assai più ampio e complesso è
naturalmente il contributo
che hanno offerto e possono offrire le lamine
d'oro di Pyrgi inscritte in
fenicio e in etrusco (A), per le quali potrebbe
essere discutibile la
definizione come «bilingue» in senso tecnico,
trattandosi di oggetti distinti
(comunque uguali e trovati insieme); ma che
a parte alcune indiscutibili
divergenze tra i due testi, hanno in sostanza
lo stesso contenuto: cosicche
la versione etrusca risulta più o meno
efficacemente illuminata da quella
fenicia, con risultati di grande
importanza ermeneutica già in parte rilevati
e di cui si tratterà ulterior-
mente più avanti in uno specifico esame di
queste iscrizioni.
Partendo dalle certezze di base sin qui descritte (valore
di singole parole
con particolare riguardo all'onomastica e significato
d'insieme dei testi),
il processo interpretativo si sviluppa ulteriormente, a
livello di ipotesi,
attraverso più approfonditi tentativi di analisi
contestuale e strutturale,
nei quali consiste l'essenza di ciò che, più o
meno vagamente, suole
intendersi come metodo combinatorio: com- plesso di
operazioni che non ha,
dunque, capacità di rivelazioni ermeneutiche primarie,
ma svolge una
funzione secondaria di verifica, precisazione ed estensione dei
dati
acquisiti. Si tratta di controllare la ricorrenza delle singole
parole,
valutarne la posizione e i rapporti, studiarne le forme, prospettarne
le
funzioni, distinguere frasi e partizioni dei testi, e così via. Molte
volte
i risultati di queste indagini ricostruttive sono ovvii o
altamente
probabili: quasi un semplice prolungamento delle nozioni di
partenza, con
conseguente ampliarsi delle zone di traducibilità praticamente
sicura. Altre
volte invece si tende a costruire ipotesi ingegnose, ma non
dimostrabili,
spesso contrastanti tra loro, o a costruire ipotesi sopra
ipotesi, e a
sostenerle puntigliosamente, sino a dare l'impressione di una
gigantesca
macchina girante a vuoto: ciò che costituisce appunto il limite
degenerativo
di tanta parte dei tentativi «combinatorii» degli ultimi
decenni, cui va
reagito con un maggiore senso di misura e di
prudenza.
Occorre infine riconoscere e sottolineare con chiarezza che non
soltanto
tutte le conquiste sino ad oggi realizzate nel processo
d'interpretazione
dei testi etruschi, ma anche l'intero patrimonio di
conoscenze sulle
caratteristiche e sulla struttura della lingua etrusca di
cui si darà conto
nel capitolo successivo derivano in ultima analisi da quei
dati di evidenza
primaria sui quali si è ritenuto opportuno insistere nelle
pagine che
precedono. Lo studio linguistico è nettamente conseguente
all'originaria
certezza dei significati, e non
viceversa.
Alfabeto etrusco
Si riporta brevemente
l'alfabeto etrusco, visto nelle diverse fasi del
periodo
etrusco:
Nella seguente tabella si confrontano gli alfabeti delle
principali lingue
del mondo classico:
Inoltre, si confrontano
gli alfabeti delle principali lingue
italiche:
Etrusco
Osco
Umbro
Volsco
Piccolo
vocabolario etrusco
In questo vocabolario, uso le due lettere sh per
rappresentare la lettera M
Etrusca, scritto normalmente con s'.
ais,
plurale
aisar, dio.
am, esser.
an, egli, ella.
apa, padre.
ati,
mader.
avil, anno.
clan, figlio.
eca, questo.
fler, offerta,
sacrificio.
hinthial, anima.
in, esso.
lauchum, re.
lautun,
famiglia.
mi, mini, Io, me.
mul-, offrire, dedicare.
neftsh,
nipote.
puia, moglie.
rasenna or rasna, Etrusco.
ruva,
fratello.
spur- or shpur-, città.
sren or shran, figura.
shuthi,
tomba.
tin-, giorno.
tular, confini.
tur-, dare.
zich-,
scrivere.
zilach, un tipo di magistrato.
Numerali:
1. thu
2.
zal.
3. ci.
4. sha.
5. mach 6. huth.
7. semph.
8. cezp.
9.
nurph.
10. shar.
Trascrizione delle
iscrizioni
Le trascrizioni delle lettere etrusche qui adottate sono
conformi agli usi
più comuni tra gli etruscologi. Ciò a comportato la
composizione di
segni-immagini appositamente create , , , etc. che
potessero essere viste
con qualsiasi sistema operativo. La soluzione non è
molto elegante sul piano
tipografico, ma non crea confusioni di lettura
rispetto ai simboli
tradizionali.
Per la trascrizione delle spiranti si
sono impiegati i simboli tradizionali
(quelli del Thesaurus Linguae Etruscae
e del Corpus Inscriptionum
Etruscarum), sebbene vari autori si siano adeguati
al sistema del Prof.
Helmut Rix, sistema che dà luogo a qualche arbitrarietà,
poiché presuppone
una precedente ipotesi sulla provenienza dell'iscrizione. I
valori delle
lettere dell'alfabeto etrusco sono noti da parecchio tempo anche
nelle
varietà locali. L'unico problema riguarda il suono marcato dal san o
tsade
nell'area meridionale che equivale al suono marcato dal sigma comune a
tre
tratti al Nord e al sigma a quattro tratti usato a Caere. Il prof. H.
Rix
ha riportato in auge una vecchia ipotesi di A. Pauli, secondo cui
l'etrusco
ha una spirante postdentale [s] e una spirante palatale [ ]
(quella di it.
sci, ingl. shape, franc. chou etc.). Questa tesi va
acriticamente prendendo
piede presso altri etruscologi, sebbene non possa
basarsi su alcuna prova
epigrafica e linguistica. Secondo un'altra ipotesi,
sostenuta da M. Durante
(in Studi in onore di V. Pisani, I, Brescia 1969, pp.
295-306) e caldeggiata
da M. Cristofani (Introduzione allo studio
dell'etrusco, Firenze 1991), i
grafemi suddetti marcano /ss/: lo
dimostrerebbe il fatto che il suffisso
patronimico e gamonimico -sa (al Nord)
o - a (al Sud) è trascritto in
caratteri latini come -ssa.
L'ipotesi
che il san meridionale e il sigma settentrionale esprimano [ss]
potrebbe
essere accettata senza grosse obiezioni quando tale grafema non è
all'inizio
della parola; ma per i numerosi termini "meridionali" che
iniziano col san e
"settentrionali" che iniziano col sigma occorrerebbe
supporre una "tensione
dei muscoli orali" (per usare le parole del
Cristofani) che contrasta con le
regole dell'economia fonetica. È probabile
che nell'etrusco recente questo
potesse essere uno degli esiti del suffisso
suddetto. Occorre però notare che
a volte il suffisso è scritto -za sia in
caratteri latini che etruschi e che
anche altri dati epigrafici (ad es. la
serie ut(u)s e / u uze / utu e /
utuse) mostrano come i grafemi in questione
marcassero un'affricata
postdentale o un suono confondibile con essa. A
nostro avviso il san
meridionale (Volsinii, Vulci, Tarquinia, Campania), il
sigma al Nord
(Chiusi, Perugia, Cortona, Siena, Volterra, Vetulonia,
Populonia, Emilia,
Adria) e il sigma a quattro tratti di Caere marcano
appunto un suono
affricato postdentale, che spesso è l'esito di un incontro
s+t o di un
originario gruppo st- . Come afferma ad es. André Martinet, in
latino i
gruppi -ts- originari si risolsero in -ss-. Quindi anche nel tardo
etrusco la
particolare affricata posdentale marcata dai simboli suddetti,
forse più
prolungata di /z/, si sarebbe risolta ora in -ss- ora in -zz-
(sorda)
quand'era in posizione intervocalica.
In alcune iscrizioni
della zona di Cortona, e in particolare
nella Tabula Cortonensis, è usata una
e rovesciata che qui viene riprodotta
con lo stesso simbolo. Dall'esame
della Tabula Cortonensis si deduce che
essa marca tre diversi suoni:
1)
una e con indebolimento verso i, come nei derivati di *pet- (p tkeal, p
tr-),
in t csinal, s tmnal etc.
2) una tendenza all'atonìa a favore della liquida o
nasale successiva (p
rkna, t rsna, c n, t n a) o una colorazione verso o (ad
esempio i casi in
cui si ha lat. ol, rispetto a etr. el : nel gruppo vel- di
V l, V lara, V l
inal, V l ur, V lusina, V l e e poi in F l ni, liunt , t l;
in C latina e
anche in pru che pare avere la base di lat. oper-.
3) una e
lunga e chiusa in Sc va < Skaiva, Sc v < Scevai , An < Anei ,
sparz
te < *sparzaite che corrisponde all'uso del digrafo ei nell'umbro
scritto
in caratteri latini.
In alcune iscrizioni dell'area senese e nel
Fegato di Piacenza è usata
una particolare forma a U o V rovesciato ( ) per
marcare /m/. Ad esempio le
iscrizioni
si leggono
1 = l . hepni .
hermes 2avial
2 = herme . hereni 2 lar al.
Nell'iscrizione 2 sono
notevoli le forme di m e di h ; in 1 sono notevoli le
legature di lettere che
realizzano ep e me.
Iscrizioni indicanti
alfabeti
Si riportano brevemente esempi di alfabeti rinvenuti
su reperti
archeologici
1. a b c d e v z h i k l m n s o p s q r
s t u
2. a b c d v e z h i k l m n o r s q s t u
1 Alfabeto modello
inciso su una tavoletta di avorio, da Marsiliana (agro di
Vulci; VII sec. a.
C.). Si notino le spiranti , M, , X.
2 Alfabeto inciso sull'anforetta di
Formello (presso Veio; VII sec. a. C.)
con le spiranti , M, , X.
3
Parte di alfabeto scritto su un bucchero del VI secolo a. C., trovato
a
Ferentum.
a c e v z i k l
4. Alfabeto inciso sul letto
funerario di una tomba di Magliano (Toscana),
VI sec. a. C.
a e v z h
i k l m n p r s t u f
5. Alfabeto inciso su un vaso perugino
della seconda meta' del VI secolo a.
C.
a e v z h i k l m n p r s t
u
Dopo l'alfabeto sono scritte 4 lettere, in senso opposto: tafa
(altri
leggono abat o afat).
6. Alfabeto su ciotola proveniente
dagli scavi presso Roncoferraro
(Mantova). L'alfabetario, che risale
al
IV sec. a. C., rispecchia fedelmente le norme ortografiche dell'
Etruria
padana, da Spina a Bologna.
a e v z h i k l m n p r s t u
f
7. Alfabeto scritto su un fondo di vaso trovato a Poggio Moscini
(Bolsena)
e datato al II secolo a. C. ] c e v z h i l m n p r s t u
[
Il Cippo di Perugia
E' un cippo rettangolare di
travertino, ritrovato nei dintorni di
Perugia e conservato ora al Museo
archeologico della città.
L'iscrizione corre per 24 righe sulla facciata e
continua su una delle
supertìci per 22 righe, per un totale di 128
parole.
La scrittura è quella in uso a Perugia tra III e II secolo a.C.
Il
testo, a carattere giuridico, e la trascrizione su pietra di una
sentenza
relativa a questioni di proprietà tra le famiglie perugine dei
Velthina e
degli Aftuna.
Il Fegato di Piacenza
L'argomento è stato
già affrontato nella sezione archeologica relativa a
Piacenza. In questo
paragrafo affronteremo l'aspetto linguistico e la
sua
interpretazione.
Il fegato etrusco di bronzo ha le seguenti
dimensioni: mm 126 x 76 x 60.
Per l'esame delle viscere esso veniva
capovolto di sotto in su perché la
parte inferiore era ritenuta la più
importante, su questa si alzano tre
protuberanze che sporgono: la più piccola
a forma semi mammellare (il
processus papillaris), la seconda piramidale (il
processus pyramidalis), la
terza è la cistifellea.
Su questa
superficie si trovano quaranta iscrizioni che si riferiscono a
nomi di
divinità tra le quali sono identificate: Tin (Giove), Uni (Giunone),
Neth
(Uns), (Nettuno), Vetisi (Veiove), Satres (Saturno), Ani (Giano),
Selva
(Silvani), Mari (Marte), Futlus (Bacco), Cath (Sole), Herole (Ercole),
Mae
(Maius) e altri cinque o sei che non hanno corrispondente nella
religione
romana. Nella parte convessa si trovano due iscrizioni, una su di
un lobo
(Usils = parte del sole), l'altra sull'altro (Tivs = parte della
luna). Il
fegato di bronzo reca attorno al margine esattamente sedici
caselle
contenenti ciascuna il nome di una divinità e queste sedici
caselle
corrispondono alle altrettante parti in cui gli Etruschi dividevano
il
cielo.
Fegato di fronte e trascrizione
Sul fegato
etrusco sono stati fatti molti studi, i più importanti furono
quelli dei
ricercatori tedeschi Deecke (1880), Korte (1905), Thulin (1906)
che misero in
risalto l'importanza di questo cimelio archeologico
definendolo un documento
fondamentale per la conoscenza della religione e
della lingua etrusca. Ma a
che cosa serviva questa riproduzione bronzea di
un fegato di pecora con tante
iscrizioni in lingua etrusca? Il Korte lo
confrontò con il coperchio di
un'urna cineraria ritrovata a Volterra che
rappresentava un sacerdote (3°
secolo a.C.) che tiene in mano un fegato come
quello ritrovato a Ciavernasco
di Settima, vicino al ponte della Ragione.
Dunque il nostro bronzo è uno
strumento originale della "disciplina";
l'aruspice interpretava il volere
divino da segni particolari riscontrati
nel fegato della vittima sacrificata,
cioè poteva prevedere se un'impresa si
sarebbe compiuta sotto influssi
favorevoli o sfavorevoli, confrontando il
viscere ancora caldo col modello
bronzeo inscritto, che fungeva da guida, da
prontuario.
Il Fegato Etrusco
risale al periodo tra il secondo e il primo secolo avanti
Cristo (come
denunciano le caratteristiche delle scritture usate nelle
iscrizioni) e non
all'epoca della dominazione etrusca nella Pianura Padana
(V - IV - sec.
a.C.). Quindi il fegato non è da ritenersi un documento della
dominazione
etrusca nella provincia di Piacenza, ma un oggetto prodotto
successivamente
da nuclei etruschi presenti nelle colonie tra Pesaro e
Rimini o nella stessa
Piacenza, oppure è da ritenersi un oggetto erratico
perduto da un auspice che
seguiva una legione romana (Ducati). La sua
relativa "tardità" nulla toglie
all'interesse che desta in noi, perché
rappresenta una lunga tradizione
conservatasi intatta attraverso i secoli
(Terzaghi). Più di quaranta saggi
sono stati pubblicati in tutto il mondo
sul Fegato piacentino, ciò testimonia
la "fama" a livello mondiale del
nostro reperto, unico esemplare nella sua
forma (esiste un altro Fegato di
Alabastro al museo Guarnacci di Volterra);
modelli di fegato con le stesse
caratteristiche suddivisioni, sono stati
ritrovati a Babilonia, nella valle
del Tigri e dell'Eufrate e ad Hattusas la
capitale degli Ittici. Questi sono
in terra cotta ma utilizzati con lo stesso
scopo religioso di quello di
Piacenza.
Esiste anche un'interpretazione
geografica del fegato, di cui si riporta una
breve descrizione:
·
le scritte sulla parte posteriore della mappa indicano le due
regioni
principali della mappa, la parte meridionale LIVR (o TIVR, non e'
chiara la
lattera iniziale) diventa YHDS (oppure T-HDS) che ricorda sia la
parola GIUDA
che la HADESH (Kadesh) storicamente famosa e attualmente
localizzata
erroneamente nella Siria mediorientale
· la regione settentrionale
viene invece denominata YSILS che
diventa P^HY^, leggibile come PNHYN (in
queste scritte le due lettere S
etrusche appaiono unificate e quindi c'e'
equivalenza tra la N semitica e la
sua quasi uguale ^, la lettera "muta"), la
regione del monte PAN-Cervino
nonche' legata alla questione punica Tra le
scritte delle singole regioni
appaiono evidenti le seguenti
interpretazioni:
· la montagna a forma di conoide, il monte Cervino,
si presenta con
la scritta TLUS che diventa TYP^ (TYPN), il nome della
divinita' TIFEO
(TIFONE)
· Tifeo-Tifone e' legato storicamente ai
vulcani dell'Italia
meridionale, dall'area vesuviana al vulcano Etna e
difatti nella mappa
compare la scritta TYP^ esattamente nel settore che
corrisponde alla
Campania e nello spicchio esterno corrispondente alla
Sicilia
· tra la regione Sicilia (TLUS che diventa TYP^) e la
regione
Calabria c'e' un segno lungo che indica chiaramente lo stretto di
Messina
· la regione Calabria, indica con il nome LEThA tale stretto
di
Messina e la parola diventa YG-ZB
· a prescindere dal
significato suo originale (per esempio Z-B,
"questo e' il padre"), ZB e' lo
ZEB famoso nelle cronache assire, un fiume
che nasce dal Monviso, scorre
nell'Adriatico, passa dallo stretto di Messina
e arriva a sfociare
nell'oceano Atlantico
· che la parola ZB sia legata a questo fiume
appena descritto lo
ritroviamo nella parola accanto al Monviso, che anch'essa
la si legge come
YG-ZB-K (LEThAM etrusco)
· sappiamo per certo che
il fiume ZEB erano due, uno meridionale e
uno settentrionale, e difatti
troviamo aldila' della catena alpina, dove
nasce il fiume Danubio, la parola
CAThA che diventa tB-ZB, il "doppio Zeb",
o meglio l'altro Zeb da
identificare come Danubio
· nella parte centrale del fegato abbiamo
la catena alpina e sotto
di essa abbiamo il fiume che nasce dalla
protuberanza a sinistra, il Po e il
Monviso
· la catena montuosa
alpina si abbassa nella parte occidentale
· l'ultima lingua della
protuberanza rappresenta la striscia
morenica all'imbocco della valle d'Aosta
(la piu' grande morena glaciale
d'Europa, un panorama unico che lo si nota
fin da lontano)
· si raggiunge cosi' la zona della grande piramide,
cosi' alta da
essere visibile da tutta la pianura
· finche' siamo
in pianura la piramide e' rappresentata dal
Monterosa (un riferimento unico
per come si distingua nettamente dal resto
della catena)
· girando
dietro la morena ed entrando nella valle d'Aosta la vera
montagna-piramide la
identifichiamo con il monte Cervino
· la regione Toscana appare come
YD^Y, chiaramente legata a Giuda e
la parola successiva contiene il DG che
contraddistingue la civilta'
etrusca, il VEL che diventa appunto DGY, con DG
uguale a "pesce" ma anche ai
successivi DOGI
· la regione delle
Marche appare come "tHYGL", chiaramente legata ai
TIGLAT assiri di cui
troviamo tracce nei reperti Piceni
· la regione degli Abruzzi appare
come NGY-DB e sembra legata
all'influenza della lingua ungherese (non e' un
caso che sia cosi' dato che
il popolo Israelitico abitava a fianco di altre
popolazioni e gli stessi
Edomiti balcanici presero il loro posto durante le
deportazioni), SELVA
diventa NGY-DB, il "grande dio" ("nagy
deba")
· la stessa scritta NGY-DB la ritroviamo difatti nella
zona
balcanica a mostrare il collegamento di questa regione italica con
quelle
balcaniche-danubiane
· nelle regioni tedesche, nella parte
settentrionale della mappa,
troviamo riferimenti ai "fasci", P-Sh (con la P
che semiticamente si tramuta
facilmente in F, come Fenici e
Punici)
· la parte piu' settentrionale, all'incirca la Danimarca,
viene
scritta come TINSRNE che diventa THLNS-LG, i "luoghi di Atlans" e mi
sembra
ovvio come questo abbia portato a considerare anticamente Atlante
colui che
sostiene il mondo (e' questa la regione dove si e' piu' vicini al
cielo
della stella polare) e anche Atlantide trova qui la sua
localizzazione
Le Lamine di Pyrgi
Nel 1964, a Santa Severa, cittadina
che sorge sull'antica Pyrgi, il porto di
Caere, vennero alla luce, durante
gli scavi diretti da Massimo Pallottino,
tré lamine d'oro: su una era inciso
un testo in lingua punica, sulle altre
due un testo etrusco. Le lamine erano
state accuratamente nascoste,
all'epoca della distruzione del santuario, in
una vasca scavata fra il
tempio A ed il tempio B. Se è vero che il testo in
lingua punica non
presenta problemi insormontabili, nessuno ci dice che
l'etrusco ne
costituisca la traduzione. Possiamo solo comparare i nomi propri
che
figurano nei due testi. Ad esempio, nella lamina punica un personaggio
è
definito "re delle genti di Caere": ora, sappiamo che in quell'epoca
la
città non aveva re.
(scrive il dott. Massimo Pittau, insigne
linguista) Il solo dato certo è
che le due versioni parlano dello stesso
argomento, cioè di un trattato
stipulato fra Caere e Cartagine; i contraenti
invocano a testimoni del patto
le divinità tutelari di entrambe le nazioni.
Nei due testi si riconosce il
nome del magistrato di Caere, Thefarie
Velianas, che avrebbe dedicato un
santuario ad Uni. Sappiamo che le cerimonie
religiose celebrate a
conclusione dell'accordo si svolsero secondo il rito
punico. Purtroppo nella
lamina in punico non esiste la traduzione di un solo
termine etrusco per noi
nuovo. Si riporta il testo redatto dal Prof . Massimo
Pittau, studioso di
lingua etrusca. Circa 40 anni fa, e precisamente nel
1964, si è avuta una
scoperta archeologica e linguistica che ha colpito in
maniera immediata e
notevole il mondo degli studiosi specialisti della
civiltà antiche, e non
soltanto questi: a Pirgi, cioè nel porto della città
etrusca di Cere
(attuale Cerveteri), durante gli scavi condotti in un
santuario di cui si
aveva già notizia per antiche testimonianze storiche, nei
resti di un
piccolo locale interposto fra i due templi, sono state trovate
tre lamine
d'oro. Su queste risultano incise delle scritte, due in lingua
etrusca ed
una in lingua punica o fenicia, le quali sono state riportate alla
fine del
sec. VI od ai primi anni del V
a.C.
Etrusco
Punico
La notizia rimbalzò da un capo all'altro nel mondo dei dotti, anche
per
l'immediata prospettiva che si intravide di avere finalmente
trovato
iscrizioni etrusche abbastanza ampie con la traduzione in un'altra
lingua
conosciuta e quindi con la speranza di vedere proiettate sulla
lingua
etrusca, scarsamente conosciuta, nuove ed importanti cognizioni da
parte
della lingua fenicio-punica, che invece è conosciuta in maniera
discreta.
Senonché questa speranza cadde quasi immediatamente, quando si
intravide che
l'iscrizione in lingua fenicio-punica e quella maggiore in
lingua etrusca si
corrispondono tra di loro, sì, ma non costituiscono affatto
un esatta
"traduzione" l'una dell'altra, cioè si intravide che si ha da fare
non con
un «testo bilingue etrusco-punico», bensì con un «testo
quasi-bilingue
etrusco-punico», nel quale cioè i due testi si corrispondono
solamente a
grandi linee.
D'altronde quella speranza cadde in larga
misura, anche per la circostanza
negativa che pure il testo punico si rivelò
subito scarsamente aggredibile
in fatto di interpretazione e di traduzione
effettiva e minuta. Dopo circa
un quarantennio di studio ermeneutico molto
intenso delle lamine di Pirgi,
condotto sia dagli specialisti della lingua
etrusca sia da quelli della
lingua punica, le conclusioni alle quali si è
alla fine pervenuti sono che
da un lato alla conoscenza dell'etrusco sono
venute dal testo punico alcune
conferme significative, ma purtroppo anche
molto ridotte in quantità e in
qualità, dall'altro la traduzione dei due
testi, condotta in maniera
comparativa, implica purtroppo numerosi e grandi
punti oscuri sia per l'uno
che per l'altro. E la presa di posizione ultima
che gli specialisti delle
due lingue hanno assunto, in maniera esplicita od
anche implicita, è che
convenga mandare avanti l'analisi e la interpretazione
e traduzione di
ciascuno dei due testi in maniera sostanzialmente
indipendente l'uno
dall'altro, nella quasi certezza che si ha da fare con due
versioni alquanto
differenti di un identico messaggio relativo ad un certo
evento storico: la
consacrazione, da parte di Thefario Velianio, lucumone o
principe-tiranno di
Cere, di un piccolo edificio religioso in onore della dea
Giunone-Astarte.
Per parte mia premetto che il mio presente intervento sui
testi etruschi
delle lamine di Pirgi trova la sua motivazione in due
importanti
circostanze: in questi ultimi quasi quarant'anni che ci separano
dalla
scoperta delle lamine, la conoscenza dell'etrusco ha effettuato
numerosi ed
importanti passi in avanti, conseguenti sia al ritrovamento di
altro
materiale documentario e quindi ad una più ampia e più esatta
documentazione
della lingua etrusca, sia al conseguente ulteriore
approfondimento
scientifico che ne hanno effettuato gli specialisti,
soprattutto quelli di
estrazione propriamente linguistica. Procedo adesso a
presentare il testo
delle tre lamine prima nella loro effettiva
documentazione epigrafica e dopo
nel loro ordinamento propriamente
linguistico, infine la mia traduzione ed
il mio commento storico-linguistico
di ciascuna.
1ª lamina con iscrizione in lingua
etrusca
cioè
Traduzione: «Questo thesaurus e queste
statuette sono divenuti di
Giunone-Astarte. Avendo la protettrice della Città
concesso a Thefario
Velianio due [figli] da Cluvenia, (egli) ha donato a
ciascun tempio ed al
tesoriere offerte in terreni per i tre anni completi di
questo Reggente,
offerte in sale (?) per la presidenza del tempio di questa
(Giunone)
Dispensatrice di discendenti; ed a queste statue (siano) anni
quanti (sono)
gli astri!».
tmia «thesaurus, tesoro di santuario», da
confrontare col greco tameîon
«tesoro o tesoreria» (vedi sotto tameresca); si
trattava di una di quelle
edicole che una città o il suo regnante costruiva
accanto ai grandi santuari
per esporvi i doni offerti alle rispettive
divinità, anche con finalità
propagandistiche di immagine esterna nei
confronti dei numerosissimi
frequentatori dei santuari. ita tmia icac
heramasva «questo thesaurus e
queste statuette». Il pronome dimostrativo ita
«questo» corrisponde
perfettamente ad ica «questo», per cui è da escludersi
che in questo passo
dietro le due varianti esista una qualche distinzione.
L'uso così
ravvicinato che lo scrivano ha fatto delle due varianti può essere
stato
determinato, al livello di meccanismo inconscio, dalla attrazione
delle
consonanti vicine: ita t- e ica-c.
heramasva «statuette», in cui
-s(a)- è una variante del noto suffisso
diminutivo -za, mentre -va è la
ugualmente nota desinenza del plurale (vedi
avanti heramve). Probabilmente le
statuette erano due, una per ciascuno dei
figli di Thefario Velianio, e
ancora probabilmente raffiguravano i due
bambini oppure due animali che
simbolizzavano altrettante vittime da
immolare alla divinità.
vatiekhe
«sono venuti, sono divenuti», forse da confrontare col lat. vadere;
è al
preterito debole attivo, in 3ª persona plurale.
unialastres, da distinguere
in unial-astres «di Giunone-Astarte», è da
confrontare con fuflunsul pakhies
«di Funfluns-Bacco» dell'iscr. TLE-TET
336, prove evidenti, l'una e l'altra,
di interpretazione od assimilazione
sincretistica di dèi stranieri in origine
differenti. Una spiegazione
unitaria del vocabolo in senso totalmente etrusco
è da respingersi perché
inspiegabile dal punto di vista morfologico;
d'altronde anche l'iscrizione
punica nella prima riga richiama esplicitamente
Astarte: L'STRT.
vatiekhe unialastres «sono divenuti di Giunone-Astarte»,
cioè, dopo la
dedicazione e la consacrazione ormai «appartengono a
Giunone-Astarte».
themiasa probabilmente significa «che ha concesso, avendo
concesso»,
participio passato attivo (LEGL 124), da connettere con thamuce
«concesse»
della 3ª lamina.
mekh il contesto ci spinge a reintegrare una l
morfema del genitivo, cioè
mekhl «della città, della città-stato, dello
Stato, del Popolo», in questo
caso "della città-stato di Cere"; vedi mekhl
dell'iscr. CIE 5360 di
Tarquinia e della Tabula Cortonensis (capo
I).
thuta «tutore, protettore-trice, patrono-a»; cfr. ati thuta
«madre
protettrice» dell'iscr. TLE-TET 159; è da confrontare col lat.
tutor,
tutrix, che è privo di etimologia (DELL s.v. tueor) e che pertanto
potrebbe
derivare proprio dall'etrusco.
thefariei è un prenome maschile,
che corrisponde a quello lat. Tiberius; è
in dativo asigmatico (LEGL 80, 2°).
In velianas non compare la desinenza del
dativo a norma della "flessione di
gruppo"; invece la -s è quella
dell'originario genitivo patronimico ormai
fossilizzata (LEGL 78).
sal «due». Non si può affatto escludere che questo
sia l'esatto significato
di sal con la considerazione che la compresenza di
zal e sal nel Liber
linteus della Mummia vieterebbe che i due vocaboli
avessero il medesimo
significato, come ha scritto M. Pallottino, Saggi, 648;
infatti l'alternanza
zal/sal «due» si riscontra anche nella Tabula
Cortonensis (capo I).
cluvenias gentilizio femm. (in genitivo), che trova
riscontro in quello lat.
Cluvenius (RNG).
munistas «del monumento o
edificio o tempio», letteralmente «di questo
monumento ecc.», da distinguere
in munis-tas (in epoca recente sarebbe stato
munists), in genitivo di
donazione (LEGL 104, 136).
thuva(-s) probabilmente aggettivo riferito a
munistas e pur'esso in
genitivo; siccome sembra derivato da thu «uno»,
probabilmente significa
«singolo», «ciascuno», con riferimento a ciascuno dei
due templi che
costituivano il complesso sacrale di Pirgi.
tameresca
(tameres-ca) «e del tesoriere» del tempio, anch'esso in genitivo
di
donazione; vedi tamera «dispensiere, tesoriere, questore» delle iscr.
TLE-TET
170, 172, 195, da confrontare col greco tamías «dispensiere». Per
la
congiunzione enclitica -ca vedi hamphisca, laivisca del Liber linteus
e
fariceka dell'iscr. TLE-TET 78.
ilacve «offerte» (plur.) (LEGL
69).
tulerase «in terreni» e sarebbe il dativo sigmatico plur. di tul
«confine,
terreno, territorio», plur. tular = lat. fines «confine,-i» e
«terreno,-i,
territorio» (LEGL 80, 1°).
nac «per, in», preposizione che
nella frase ci avil khurvar «per i tre anni
completi», avente un implicito
valore "temporale", mostra di reggere
l'accusativo, mentre nella frase
seguente nac atranes zilacal «per la
presidenza del tempio», avente un
implicito valore "finale", mostra di
reggere il genitivo.
khurvar siccome
richiama il lat. curvus, è probabile che significhi
«circolari», ma qui col
significato di «completi» (aggettivo plur.) (LELN
122).
tesiameitale, da
confrontare con tesinth «curatore, comandante, capo»
dell'iscr. TLE-TET 227
(LEGL 124); lo traduco «di questo Reggente» per il
fatto che non si riesce a
capire quale fosse l'esatta posizione
giuridico-istituzionale di Thefario
Velianio rispetto alla città-stato di
Cere, anche se si ha l'impressione che
fosse un "Principe-Tiranno", come
quelli che di volta in volta si
impadronivano del potere in numerose poleis
greche. Inoltre è ragionevolmente
ipotizzabile che egli fosse stato aiutato
dalla potente Cartagine nella sua
conquista del potere a Cere; ed in questo
modo e per questa ragione si
comprenderebbero bene sia la assimilazione
effettuata nella lamina tra la
etrusca Giunone e la fenicia Astarte, sia la
versione in lingua punica
dell'iscrizione etrusca di questa 1ª lamina. In
proposito è appena da
ricordare la notizia data da Erodoto (I 166, 167; VI
17) della lega
politico-militare che si era stabilita fra Cere e Cartagine,
la quale aveva
attaccato i Focesi della colonia greca di Alalia, in Corsica,
nella battaglia
navale del Mare Sardo (circa 535 a.C.) e, pur con un esito
militare incerto,
li aveva costretti a sloggiare dalla Corsica. Il vocabolo
è da distinguere in
tesiame-itale, con -itale genitivo del pronome
dimostrativo ita «questo-a» in
posizione enclitica; in epoca più recente
sarebbe stato -itle e cioè
*tesiameitle (cfr. il seguente seleitala).
alsase «in sale» (?), in dativo
sigmatico come tulerase, ma al sing.; in
questa supposizione sarebbe da
richiamare il greco áls ed il lat. sal,
inoltre il nome della città etrusca
di Alsium sulla costa tirrenica presso
Cere andrebbe spiegato con riferimento
alla estrazione del sale. È appena da
ricordare il grande valore che aveva il
sale in epoca antica, anche per la
conservazione delle carni e dei pesci. In
subordine prospetto che ilacve
alsase significhi «offerte (in terreni) ad
Alsium».
atrane(-s) sembra un aggettivo derivato dall'etr.-lat. atrium
«atrio» ed
anche «tempio», per cui significherebbe «templare, del tempio»
(in
genitivo).
zilacal (zilac-al) «della prefettura o presidenza» templare
o del tempio.
seleitala «di questa Dispensatrice», da confrontare con selace
«ha elargito»
della 3ª lamina; è da distinguere in sele-itala, con -itala
ancora genitivo
del pronome dimostrativo ita in posizione enclitica e forse
al femm. (cfr.
venala dell'iscr. TLE-TET 34); in età più recente sarebbe
stato *seleitla
(cfr. tesiameitale) (LEGL 107).
acnasvers probabilmente
«d(e)i discendenti o successori» (genit. plur.), da
confrontare con acnanas
«che lascia, lasciando», acnanasa «che ha lasciato,
avendo lasciato» (LEGL
123, 124).
itanim (itani-m) probabilmente «ed a questi-e», dativo plur. di
ita
«questo-a», da confrontare con etan «questo-a» (accusativo; TLE-TET 620,
Cr
3.24). Però potrebbe corrispondere al più recente etnam «poi, inoltre,
in
verità» = lat. etenim «(e) infatti, in realtà, in verità», per cui la
frase
andrebbe tradotta: «In verità le statue (abbiano tanti) anni quanti
(sono)
gli astri!». In ciascuna delle due soluzioni si deve pensare ad una
frase
ottativa, che per ciò stesso spiegherebbe l'ellissi del verbo. È del
tutto
errato affermare - come ha fatto un archeologo - che non
esistono
proposizioni ottative che sottintendano il verbo: ne esistono in
tutte le
lingue, ad es. la locuzione italiana Alla salute! sottintende questo
sia o
torni alla tua (vostra o nostra) salute!; la frase augurale Auguri
agli
sposi e figli maschi! sottintende ed abbiano figli maschi!
heramve
«statue» (plur.), quelle offerte a Giunone-Astarte da Th. Velianio
per i suoi
due figli, probabilmente due, cioè una per ciascuno; è da
confrontare col
greco hérma «erma, base, sostegno, puntello, cippo (anche
funerario), cippo
con figura di Ermes», dio Hérmes «Ermes», fiume Hérmos
della Lidia (finora
privi di etimologia, ma probabilmente anatolici e lidî;
GEW, DELG) ed inoltre
con la glossa etr. Ermius «agosto» (ThLE 416).
eniaca
«quanti-e».
pulumkhva «astri, stelle» (plur., LEGL 69), significato
assicurato da un
corrispondente vocabolo della iscrizione punica.
2ª
lamina con iscrizione in lingua fenicio-punica
«Alla signora Astarte
questo sacello ha fatto e donato Tiberio Velianio re
di Cere, nel mese di
Zebah, come dono nel tempio e nella cella, perché
Astarte ha favorito il suo
fedele, nel terzo anno del suo regno, nel mese di
KRR, nel giorno della
sepoltura della divinità. E gli anni della statua
della divinità siano tanti
quanti (sono) gli astri».
Questa traduzione della 2ª lamina è
stata da me derivata da
quelle correnti prospettate da specialisti della
lingua fenicio-punica, ma
adattata alla mia personale traduzione della 1ª
iscrizione in lingua
etrusca. Su questa mia traduzione però non intenderei
insistere, per il
motivo che sono consapevole di non avere una sufficiente
competenza su
questa lingua, tale da osare di confrontarmi coi colleghi
semitisti. L'unica
cosa che mi sento di dire è che quasi certamente lo scriba
che ha stilato
l'iscrizione fenicio-punica era un cartaginese, il quale non
comprese bene
l'iscrizione stilata dal suo collega etrusco; e soprattutto da
questo fatto
saranno derivate le discrepanze tra le due iscrizioni.
3ª lamina con iscrizione in lingua etrusca
cioè:
«Così
Thefario Velianio ha concesso l'offerta del corrente mese di dicembre
(ed) ha
fatto elargizioni a Giunone. La cerimonia degli anni del thesaurus è
stata la
undicesima (rispetto a)gli astri». Oppure «Così Thefario Velianio
ha
concesso l'offerta del corrente mese di dicembre a Giunone (ed) ha
fatto
elargizioni (al tempio). La cerimonia degli anni del thesaurus è stata
la
undicesima (rispetto a)gli astri».
Sia il cambio di grafia
fra le due lamine scritte in etrusco
sia la differenza tra la forma del
gentilizio Velianas della prima e
Veliiunas di questa ci assicurano che
ciascuna delle due lamine è stata
scritta da un differente scrivano.
Probabilmente il nome del committente in
realtà suonava Vélinas, cioè con
l'accento sulla prima sillaba e con la
vocale posttonica
indistinta.
thamuce «concesse, ha concesso»; nell'iscr. CIE 5357 compare come
thamce,
cioè sincopato (vedi themiasa della 1ª lamina).
etan(-al)
interpreto «(del) presente o corrente», intendendolo come derivato
dal
pronome dimostrativo eta «questo».
masan probabilmente «dicembre» oppure, in
subordine, «novembre», e
corrisponde alla forma sincopata masn del Liber
linteus.
tiur «mese». masan tiur sono privi della desinenza del genitivo ai
sensi
della "flessione di gruppo" (LEGL 83-84).
unia(-s) «(di) Giunone» in
genitivo di donazione o dedicazione (LEGL 136).
vacal «rito sacro,
cerimonia»; nel Liber linteus figura sincopato in vacl.
tmial «del thesaurus»
(genit.); vedi 1ª lamina.
avilkhval (avil-khva-l) «degli anni», in genitivo
plur. (LEGL 74).
amuce «fu, è stato».
pulumkhva «per, rispetto agli
astri», i quali segnavano il passare del
tempo; è un complemento di tempo con
morfema zero.
snuiaph «undici»; già Marcello Durante aveva intravisto che si
tratta di un
numerale. Secondo G. Giannecchini («La Parola del Passato»,
1997),
indicherebbe il numero «dodici»; io lo escluderei, visto che in
etrusco
«dodici» molto probabilmente si diceva sranczl (LEGL 96). Comunque
questo
divario di un numero non implicherebbe alcuna differenza effettiva,
per
effetto del modo in cui la gente spesso effettua la numerazione,
cioè
saltando sia il terminus a quo sia il terminus ad quem. Dunque
la
commemorazione della prima fondazione e dedicazione del thesaurus
venne
fatta undici/dodici anni dopo, secondo un numero che nei tempi antichi
aveva
anche una valenza sacrale in virtù delle dodici lunazioni della luna. E
per
questo motivo si spiega la diversità dello scrivano della 1ª lamina
rispetto
a quello della 3ª.
Molto notevole è il fatto che in questa 3ª
lamina non si faccia alcun
riferimento alla fenicia Astarte e che a questa
iscrizione etrusca non ne
corrisponda una analoga punica: nella verosimile
supposizione che ho fatto a
proposito della 1ª lamina, evidentemente Thefario
Velianio negli
undici/dodici anni trascorsi aveva ormai rafforzato il suo
potere su Cere,
per cui non aveva più bisogno dell'aiuto di Cartagine e tanto
meno di
ringraziarla pubblicamente.
La Mummia di Zagabria
Il
manoscritto della "Mummia di Zagabria" è un "liber linteus" eseguito
a
inchiostro con un pennello su di un drappo di lino. E' suddiviso in
dodici
riquadri rettangolari ognuno con 34 righe della scrittura. Il drappo
veniva
ripiegato "a fisarmonica" seguendo le linee verticali dei riquadri
che
funzionavano dunque come le pagine di un libro.
Attualmente si
conserva al Museo Archeologico di Zagabria ma è stato
ritrovato in Egitto,
dove era stato "riciclato" tagliandolo orizzontalmente
in lunghe strisce, che
furono utilizzate come bende per una mummia.
Solo alcune delle strisce
sono conservate, per cui il manoscritto ha grosse
lacune. Il testo è in
assoluto il più lungo tra quelli etruschi, esso consta
infatti di 230 righe e
di circa 1350 parole. Il testo ha una storia molto
curiosa: verso la metà
dell'Ottocento un collezionista croato (Mihail de
Brariæ, scrittore della
Regia cancelleria ungherese) aveva riportato in
patria dall'Egitto, secondo
l'uso dell'epoca, alcuni oggetti antichi, fra i
quali una mummia. Qualche
tempo dopo ci si accorse che le bende del reperto
erano coperte da un testo
scritto con l'inchiostro nero. Solo nel 1892
questo testo, di oltre 1200
parole, venne studiato dall'egittologo Brugsch e
identificato come etrusco.
Dal 1947 mummia e bende vennero trasferite al
Museo di Zagabria. L'ultimo
restauro è stato curato da un'équipe italiana
nel 1997.
Si tratta di un
calendario rituale che specifica le cerimonie da compiere
nei giorni
prestabiliti in onore di varie divinità. Le prescrizioni di
carattere
religioso sono tipiche dell'area tra Perugia, Cortona e Lago
Trasimeno. La
scrittura, molto precisa e accurata, è quella in uso
nell'Etruria
settentrionale tra il III e il lI secolo a. C. Un esempio
dalla III colonna,
riga 3: " celi huthis zathrumis flerxva Nethunsl sucri"
"Settembre sei venti
offerte a Nettuno si dedichino " ossia " il 26
settembre si dedichino venti
offerte a Nettuno" Si pensa che questo libro di
lino, conosciuto come liber
linteus di Zagabria, appartenesse a un aruspice,
e che sia stato poi ridotto
in strisce per fasciare la mummia.
La Tabula Cortonensis
Una delle più
lunghe iscrizioni in lingua etrusca, la "Tabula cortonensis"
(la tavola di
Cortona) del III-II secolo a. C., la cui clamorosa scoperta è
stata
annunciata all'inizio della scorsa estate a Firenze, ha cominciato a
svelare
i primi "segreti". Nel testo non si parla di defunti o riti
funerari, come
succede in genere con i reperti degli Etruschi riemersi dal
sottosuolo, ma di
un concreto e articolato passaggio di proprietà fra
etruschi ben in vita e
preoccupati di tutelare le proprie ricchezze. Solo
quattro mesi fa Francesco
Nicosia, ispettore centrale del ministero dei Beni
culturali, ha reso nota
l'esistenza di una tavola bronzea, misteriosamente
ricomparsa nel 1992, con
una fitta iscrizione di 32 righe, spezzata in sette
frammenti, la cui
decifrazione sta fornendo importantissimi elementi per la
conoscenza della
ancora in gran parte misteriosa lingua degli Etruschi.
Ora un articolo della
rivista "Archeologia viva" rende noti i significativi
passi in avanti nella
decrittazione delle parole della "Tabula Cortonensis",
grazie agli studi del
professor Luciano Agostiniani, docente di glottologia
all'università di
Perugia. L'ipotesi al momento più fondata è che la "Tavola
di Cortona"
racconti di una transizione tra la famiglia Cusu, di cui farebbe
parte il
personaggio Petru Scevas, da una parte, e un gruppo di quindici
persone,
dall'altra. È stato decodificata anche una serie di numeri: il 10
(sar), il 4
(sa) e 2 (zal), che potrebbero indicare quantità di cose o
estensioni di
terreno. È possibile, secondo Agostiniani, che si tratti
dell'atto di vendita
di un terreno da parte dei latifondisti Petru Scevas e
Cusu a piccoli
proprietari compratori.
Molti sono gli elementi eclatanti in questa
straordinaria iscrizione.
Anzitutto la formula di datazione con il nome degli
eponimi, attestata qui
per la prima volta per l'Etruria settentrionale. Il
primo dei personaggi che
compare nell'ultimo elenco è accompagnato
dall'epiteto della carica
rivestita, assai importante e attestata sempre per
la prima volta
nell'Etruria settentrionale: si tratta dello "Zilath Mel
Rasnal", il
magistrato supremo dello Stato, che intervenne nella stesura
dell'atto di
compravendita. Il professor Agostiniani ha ipotizzato, inoltre,
in base a
numerosi riscontri, l'esistenza sulla "Tavola di Cortona" di tre
elenchi di
nomi: il primo rappresenta i venditori, il secondo i compratori e
il terzo i
garanti della regolarità del contratto.
I garanti del contratto
erano il magistrato supremo e i figli e i nipoti
delle due parti. Ciò
significa che nel diritto orale etrusco, chi garantiva
la regolarità del
contratto e i pagamenti non lo faceva solo per sé, ma
anche per i suoi
discendenti. Insomma, in caso di disgrazia o di insolvenza,
il figlio o il
nipote doveva garantire l'esecuzione del contratto.
La Tegola
Capuana
Il testo della famosa "Tegola di Capua" (conservata al Museo di
Berlino)
rappresenta la più estesa di tutte le epigrafi etrusche mai
ritrovate, se si
eccettuano le bende della "mummia di Zagabria", che
costituiscono un vero e
proprio libro. Si tratta di una lastra di terracotta
(di centimetri 60 x
50), scoperta nel 1898 nella necropoli di Santa Maria
Capua Vetere e recante
una lunga iscrizione graffita, di cui restano
leggibili circa treo cento
parole.
Suddiviso in dieci sezioni da una linea
orizzontale, risulta attualmente
costituito da 62 righe, alcune in parte
perdute, e da circa 390 parole, non
tutte conservate per intero. È suddiviso
in dieci sezioni da una linea
orizzontale.
La scrittura è quella in uso in
Campania intorno alla metà del V secolo a.C.
Si tratta, come nel caso della
Mummia di Zagabria, di un "calendario
rituale" dove vengono prescritte
cerimonie da compiere in certe date e in
certi luoghi a favore di alcune
divinità. Nel 1985 ne è stata presentata una
bella edizione nel testo di
Francesco Roncalli, Scrivere etrusco, che
contiene anche il "libro di
Zagabria" e il "cippo di Perugia".
Sui problemi dell'interpretazione del
contenuto il riferimento più recente e
importante è il libro Tabula Capuana
(1995), uno degli ultimi lavori
lasciati dall'archeologo Mauro Cristofani. La
redazione del documento si può
datare al 470 a.C., sebbene esso si debba
ritenere la copia (o comunque la
trascrizione) di un testo certamente molto
più antico. In effetti sulla
tegola è graffito un calendario festivo
risalente all'età arcaica: un
calendario di prescrizioni cultuali relativo a
celebrazioni pubbliche e
diretto, secondo il Cristofani, alla stessa comunità
capuana. Il calendario
è diviso in dieci sezioni, corrispondenti ai dieci
mesi del calendario
antichissimo e comincia da marzo (in etrusco,
probabilmente, Velxitna).
Anche il calendario romano (da cui deriva il
moderno) ebbe, in origine,
dieci mesi e certamente cominciava da marzo; ciò è
provato al di là di ogni
dubbio dai nomi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre, che oggi si
trovano al nono, decimo, undicesimo e dodicesimo
posto.
Le fonti antiche dicono che gennaio e febbraio furono aggiunti dal re
Numa;
nel De die natali di Censorino (20, 30) si legge: «I quali ritenevano
che i
mesi siano stati dieci, come un tempo succedeva presso gli Albani, da
cui
ebbero origine i Romani. Quei dieci mesi (degli Albani) avevano in tutto
304
giorni, così distribuiti: marzo 31, aprile 30, maggio 31, giugno
30,
quintìle 31, sestìle e settembre 30, ottobre 31, novembre e dicembre
30».
Ecco dunque alcuni estratti del calendario festivo di Capua.
I
nomi dei mesi etruschi sono noti sostanzialmente attraverso alcune
glosse, la
"tegola di Capua" e il "libro di Zagabria" (l'asterisco indica le
forme
ricostruite, in quanto conosciute soltanto da glosse e non ancora
attestate
nei documenti etruschi originali): marzo = *velxitna; aprile =
apiras( a);
maggio = anpili(a) o ampner; giugno = acalva o acal(a); luglio =
*turane o
par-{}um; agosto = *hermi; settembre = celi; ottobre = *xesfer.
La Stele
di Lemno
Come già detto, alcuni autori antichi condivisero l'idea di
un'origine
orientale degli Etruschi. Ellanico, un altro storico, vissuto nel
V secolo
a.C., in un brano delle sue storie, sostiene che Ceare (attuale
Cerveteri)
in origine si chiamava Agylla e fu fondata dai Pelasgi,
provenienti dalla
Tessalia; quando poi i Lidi, al seguito di Tirreno,
assalirono Agylla, uno
degli assedianti si avvicinò alle mura e domandò il
nome della città; dalle
mura, uno dei Tessali, invece di rispondere, lo
salutò con la parola
"chaere". Così i Tirreni, appena presa la città, le
cambiarono nome in
Caere. In seguito, gli studiosi sostenitori dell'origine
orientale,
affermarono che per la trasformazione dei villaggi villanoviani in
città
fortificate, avvenuta all'epoca dell'inizio della civiltà etrusca,
sono
state necessarie tecniche e abilità amministrative ben maggiori di
quelle
dimostrate dai villanoviani stessi; ne consegue che tali competenze
furono
necessariamente arrivate dall'esterno. Altri riscontri archeologici a
favore
di questa ipotesi sono le somiglianze trovate tra alcune tombe
etrusche e
alcune tombe dell'Asia minore, nonché alcuni aspetti della civiltà
etrusca
che sembrano più orientali che italici: il piacere del lusso, l'amore
per le
feste e per le danze, alcune pratiche come
l'epatoscopia.
Più che a un'invasione in massa, avvenuta in un unico
momento, si può anche
pensare al graduale arrivo dall'esterno di gruppi della
stessa popolazione,
che a poco a poco si integrò con la base villanoviana
portando i suoi usi e
la sua cultura, in seguito adottati totalmente. Come
riscontro archeologico
a quest'ipotesi, nell'isola di Lemno, nei pressi della
città di Kaminia, si
può citare il ritrovamento di una stele funeraria
recante un'incisione in
una lingua non greca, che è stata interpretata solo
grazie alla sua
somiglianza con l'etrusco, segno di un collegamento con
l'idioma in uso a
Lemno nel VI sec. a.C., che pur non essendo la stessa
lingua, probabilmente
ha delle radici comuni.
|
|
|
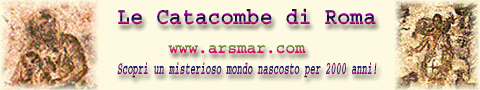
|
|
|
|
|
 | |