 |
|
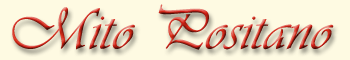 |
|
STORIA DEGLI
ETRUSCHI, LE GUERRE CONTRO ROMA E L'ARTE
|
|
|
|
GLI ETRUSCHI |
Pagina precedente
L'epilogo etrusco: i Galli e Roma
In questo paragrafo analizziamo in modo
più approfondito il rapporto tra
Roma e gli Etruschi. Abbiamo già detto che
l'Etruria perde la supremazia sui
mari a scapito di Siracusa e vede fallire
il suo progetto di alleanza con i
Cartaginesi ed (a livello più ampio) con i
Persiani sconfitti a Salamina
dagli ateniesi (filo-siracusani). Infatti
presso Cuma, in particolare a Capo
Miseno, la flotta etrusca è sconfitta dai
siracusani, che, successivamente,
saccheggiano le coste toscane, in
particolare Populonia e Vetulonia, e l'
isola d'Elba e prendono la Corsica e
Ischia (454 a.C.). In Sicilia, presso
Imera, stavolta per via di terra, gli
Etruschi perdono di nuovo contro i
siracusani e contemporaneamente a Salamina
la Grecia sconfigge i Persiani.
Fallisce così l'alleanza tra Etruschi,
Cartaginesi e Persiani che voleva
contrapporsi a quella tra Greci e
Siracusani. Nel 350 a.C. alcuni
ambasciatori tirreni si recano in Mesopotamia
da Alessandro Magno, per
chiedere aiuto, ma non ricevettero una pronta
collaborazione: Alessandro
avrebbe preparato un'invasione dell'occidente solo
dopo circa dieci anni.
Dopo Veio, testimone della scarsa coesione tra le
città della lega, cadono
le altre città, una dopo l'altra, tra cui Falerii,
capitale dei Falisci e
gli avamposti di Tarquinia. Nel 387 a.C. i Celti di
Brenno sconfiggono i
Romani ad Allia, devastano l'Etruria e Roma, che si
ricostruisce, anche se
in un primo momento, nel quale Camillo si oppose, si
pensava di spostare la
capitale da Roma a Veio. Nel 350 a.C. i siracusani
depredano Pyrgi e Caere,
Roma conquista Tarquinia, con forti rappresaglie ed
i Galli dilagano in
Valle Padana, non trovando la minima resistenza. Tutte le
città della lega
del nord sono prese, ad eccezione di Spina e Mantova. Spina
ed Adria
verranno poi prese dai greci che nel frattempo avevano fondato
Ancona. L'
economia agricola è distrutta: non si produce più vino,
ricompaiono le
paludi in Valle Padana, il sistema idrico è distrutto, cresce
solo del grano
che la città di Spina commercia con la Grecia (non si
producono più vasi
attici, anche perché la città greca di Marsiglia ha una
florida attività con
i Liguri e i Galli). Per rappresaglia contro i Galli,
alcuni etruschi
eseguono atti di pirateria sui carichi di grano.
Nel 310
a.C. i Romani, comandati da Q. Fabio Rulliano, invadono e
saccheggiano la
Selva Cimina ritenuta sacra e inviolabile. Gli Etruschi non
seppero sfruttare
le guerre sannitiche: nel 295 a.C. subirono in particolare
una sconfitta a
Sentinum, non interagendo bene con gli Umbri. E' anche vero
che i Romani
separarono geograficamente le varie tribù sannitiche tra loro e
queste, a
loro volta, dagli Etruschi, mantenendo neutrale la striscia di
territorio dei
Peligni (Sulmona-Chieti). Nel nel 283 a.C. assoldarono
(dapprima venendo
depredati) i Galli per combattere contro Roma vicino
Bassano in Teverina, sul
lago Vadimone, ma furono sconfitti, tanto che le
acque del Tevere si tinsero
di rosso. In tale occasione furono cacciati dall
'Italia i Galli Senoni (che
subirono un genocidio nei pressi di Rimini), con
la fondazione di Sena
Gallica (Senigallia) ed i Boi. Si ribellarono ai
Roamni ad Arezzo, ma furono
annientati. Sperarono inutilmente in Pirro, che
dopo aver vinto ad Eraclea
(Basilicata) nel 282 a.C., perse a Maleventum.
Sostennero Annibale vanamente
nel 210 a.C., subendo ritorsioni e processi
sommari dai Romani. Eseguirono
azioni di sabotaggio, di frode e di pirateria
contro Roma.
I Romani
fondarono colonie di controllo in Etruria: Rusellae, Castrum Novum
(Porto
Clementino), Alsium, Fregene, Saturnia e Graviscae. Nel 225 a.C. i
Galli
devastano di nuovo l'Etruria e sono sconfitti dai Romani a Talamone,
la
Maremma non si riprenderà più dalla devastazione: il grande sistema
idrico di
bonifica è stato distrutto e si lascia il posto a paludi e
zanzare. Si
racconta che Ansedonia, Graviscae, Rusellae erano città
inospitali, con aria
insalubre. L'Etruria pagò a caro prezzo le azioni di
guerriglia e di
favoreggiamento dei vari condottieri, scesi in Italia per
combattere i
Romani: confische di beni, tribunali, persecuzioni, liste di
proscrizione.
Fino al 100 a.C. i Tirreni godevano ancora di un'agiata
economia e di una
certa ricchezza, segno di una continua attività
commerciale, seppure sempre
più debole. Osserviamo che in questa fase il
destino dei Tirreni è molto
simile a quello dei Sanniti, entrambi in lotta
contro Roma. Il latifondismo
riduce alla fame il Sannio e l'Etruria: il
prezzo del grano si è ridotto,
visto che tanti oramai sono i paesi dell'
impero che lo producono. Con
l'avvento di Caio e Tiberio Gracco viene
proposta la riforma agraria e si
fonda un partito d'ispirazione popolare,
per porre un freno a questa piaga
della società. A seguito della loro
uccisione nel 130 a.C. l'Italia conosce
il flagello della guerra sociale. Il
console Lucio Giulio Cesare, per evitare
la guerra, propone la lex julia:
abroga il latifondo e concede la
cittadinanza romana, anche se non con
diritto di voto, ai popoli si schierano
per la pace. Gli Etruschi si
accontentano ed evitano di scendere in
combattimento al fianco dei Sanniti,
che assieme ai Piceni e Marsi avevano
fondato una capitale a Corfinium, in
Abruzzo. Tale evento è ricordato a
Perugia nell'Ipogeo dei Volumni.
Cessata la guerra tale legge fu respinta dal
Senato e scoppiò la guerra
civile che vide come protagonisti Mario, popolare,
vittorioso sulle tribù
celtiche dei Cimbri e Teutoni, e Silla, uomo degli
ottimati (patrizi), abile
e astuto stratega. Nonostante il popolo si fosse
schierato per il primo,
Silla, dopo aver massacrato i Sanniti, marciò su Roma
e prese il potere.
Pompeo intanto sconfisse truppe tirrene in Val di Chiana e
ad Arezzo (88
a.C.). Mario, assieme a Cinna, altro popolare, approfittando
della guerra
che Silla aveva mosso a Mitridate in Grecia, riprende il potere.
E' un buon
periodo per tutti i popoli italici. Mario e Cinna muoiono tra l'86
e l'84
a.C.. Silla ritorna e nell'82 a.C. sconfigge i popolari a Prenestae,
dove
avviene una strage di Sanniti, e poi a Porta Collina (Monte
Antenne-Roma)
con un altro famoso massacro. Silla si dirige in Etruria, dove
subisce l'
unica sconfitta a Saturnia, ma poi si vendica a Chiusi con l'aiuto
di
Pompeo. Fino al 79 a.C., anno della caduta di Volterra, ci sono
state
rappresaglie, liste di proscrizione, con premi per chi uccideva
i
proscritti, inibizione dalle cariche pubbliche, confische di beni,
riduzione
dei territori ad Arezzo, Fiesole e Chiusi. L'Etruria era alla fame.
Solo più
tardi, Cicerone riuscì a far ridare terre a Volterra ed
Arezzo.
Nel 62 a.C. alcuni abitanti di Fiesole e Arezzo si unirono vanamente
a
Catilina e furono sconfitti a Pistoia. Come si vede, l'Etruria, è
stata
sempre sede di sommosse. Il periodo di Cesare (49-44 a.C.) è ottimo per
i
Tirreni: c'è rispetto, pace e riprendono le attività commerciali. Del
resto
Arezzo si mostrò simpatizzante il generale, accogliendo le coorti
spedite in
avanscoperta prima di passare il Rubicone. Con la morte di Cesare
finisce il
nono secolo etrusco. Con l'avvento di Augusto si assiste alla
distruzione di
Perugia del 40 a.C. per aver appoggiato il fratello di Marco
Antonio,
sconfitto ad Azio da Agrippa nel 31 a.C., con la deportazione di
300
perugini, trucidati nel Foro Romano. Mecenate consigliò l'imperatore
di
ricostruire Perugia, che si chiamò Augusta Perusia. Comincia per
l'Etruria
uno sviluppo nel turismo, di moda già all'epoca. Famose erano le
fonti
termali Fontes Clusini presso Chianciano e Aquae Populoniae
presso
Populonia.
Nacquero le provincie, le colonie, le regioni romane ed
i processi di
latinizzazione presero sempre più piede. L'ultimo imperatore
amico dei
tirreni fu Claudio, loro grande studioso, morto nel 54 a.C., che
compose i "
Tyrrhenica ", studi di etruscologia, mai trovati. Dunque gli
Etruschi
insegnarono moltissimo ai loro discepoli romani, che li distrussero
e
perseguirono una politica di propaganda e di denigrazione nei
loro
confronti: tecnica adottata nei confronti di tutti i popoli vinti,
in
particolare dei tirreni che erano stati i fondatori dell'urbe.
I
Personaggi
Riportiamo brevemente la storia di alcuni personaggi
caratteristici della
storia etrusca. Come già ricordato nel capitolo
precedente, è importante
tenere presente che le notizie storiche pervenuteci
sono state filtrate dal
mondo culturale filo romano (tranne nel caso della
vicenda del mitico
Mastarna e dei Vibenna), per cui è lecito supporre che per
alcuni tratti le
vicende riportate si siano arricchite di leggenda, al fine
di esaltare la
cultura romana che aveva sconfitto quella etrusca.
Cicerone
Marco Tullio
Fabia (gens)
Furio Camillo Marco
Mastarna ed i
Vibenna
Mecenate Caio Cilno
Ocresia
Porsenna
Ravnthu
Servio
Tullio
Spurinna (gens)
Tanaquilla
Tarquinio Lucio Prisco
Tarquinio
Lucio il Superbo
Tullia
Velia
Virgilio Publius Maro
Vulca
MARCO
TULLIO CICERONE
Marco Tullio Cicerone nacque nel 106 a.C. in territorio
di Arpino, da
famiglia equestre nella villa paterna alla confluenza del Liri
col Fibreno e
sempre si considerò un puro Arpinate, quasi continuatore del
grande
conterraneo Mario. Nell'orazione Pro Plancio esprime vivo
l'attaccamento
viscerale alla sua terra di origine quando ricorda quale
affetto leghi gli
Arpinati fra di loro e con quale partecipazione questi
seguano le sue
vicende politiche. Lì, sui monti dei Volsci, aggiunge, è la
forza d'Italia,
perché ha conservato gli antichi costumi, senza malevolenze,
senza finzioni
e conclude: "La nostra patria è rozza e montuosa ma semplice e
fedele".
E nel momento del suo esilio indica alla moglie Terenzia, quale
rifugio
sicuro, la villa di Arpino e al suo unico figlio egli darà la toga
virile
non in Roma, ma nel foro dell'antica città volsca. Cicerone ben presto
fu
inviato a Roma dove studiò Retorica e Diritto, ma anche Filosofia e
Lettere
e completò la sua preparazione ad Atene e a Rodi. Il suo cursus
honorum
iniziò nel 76 a.C. con una rapida e inarrestabile ascesa: fu questore
nella
Sicilia orientale, poi edile curule, pretore nel 66 a.C. e console nel
63.
La sua oratoria robusta ed euritmica gli aveva aperto la strada
alle
affermazioni politiche. Nel periodo turbolento che viveva la Repubblica
dei
suoi tempi, Cicerone fu personaggio controverso: ora acclamato pater
patriae
dopo aver sventato la congiura di Catilina, ora esiliato per la
vendetta di
Clodio. In bilico fra il vecchio ed il nuovo fu incerto nello
schierarsi, ma
se la sua fede politica sembra mutare, sempre costante fu la
sua fedeltà ai
valori morali e alla Repubblica.
Nella lotta fra Cesare e
Pompeo si schiera con Pompeo, ma dopo Farsalo si
riavvicina a Cesare. Le Idi
di Marzo lo trovano dalla parte dei tirranicidi
e con le Filippiche si
scaglia contro Antonio.
Quando questi si accorda con Ottavio, Cicerone
capisce che la sua ora è
suonata. E allora tutto, indecisione, incertezza,
opportunismo, fu
riscattato dalla sua morte affrontata consapevolmente, anzi
cercata, e alte
suonano le parole della seconda Filippica: "Ed ora per me, o
Senatori, la
morte rappresenta un desiderio ... Una sola cosa desidero: di
lasciare
libero morendo il popolo romano. Niente di più bello può essermi
concesso
dagli dei immortali". Infatti raggiunto a Formia dai sicari di
Antonio, gli
fu troncata la testa che egli aveva sporto dalla lettiga.
Era
il 7 dicembre del 43 a.C. Le Verrine, le Catilinarie, le Filippiche
furono i
momenti più alti della sua oratoria; il De legibus, il De Officiis,
il De
Republica, le Tuscolanae sono l'espressione del Cicerone pensatore,
studioso,
interprete dell'anima latina. Le Epistolae, infine, sono il
documento che ci
rivela l'umanità, l'inquietudine, i dubbi e le angosce
dell'uomo
Cicerone.
FABIA (Gens)
La gens Fabia possedeva dei territori nella zona a
ridosso di Veio e presto
la lotta per il predominio territoriale divenne
inevitabile. Nel 478 a.C. la
famiglia dei Fabii, aveva chiesto e ottenuto
l'autorizzazione al Senato, per
combattere una sorta di guerra privata contro
la la rivale etrusca. 306
membri della prestigiosa famiglia romana,
accompagnati da una guarnigione di
4000 uomini, probabilmente loro clienti,
si accamparono a poca distanza da
Veio, sulle rive del fiume Cremeria, un
piccolo affluente del Tevere.
Da lì conducevano una guerra fatta di piccoli
scontri, incursioni e razzie
di bestiame. Il 13 febbraio del 477 a.C.,
caddero in un'imboscata preparata
dai veienti: 305 componenti della famiglia
dei Fabii, caddero sotto i colpi
dei nemici. Solo un giovane si salvò e
garantì in questo modo la discendenza
dalla famiglia che rimase comunque una
delle gens più importanti dell'antica
Roma.
FURIO CAMILLO
Marco
Generale e uomo politico romano (fine del V sec. a.C.- 365 a.C.).
Censore
nel 403, sei volte tribuno militare con potestà consolare tra gli
anni 401 e
381, dittatore nel 396 a.C., si segnalò nella guerra contro gli
Etruschi,
conquistando Veio già assediata da dieci anni e raddoppiando il
dominio
territoriale di Roma. Tre anni dopo aver concluso la pace con i
Falisci, in
seguito a una condanna, andò in esilio ad Ardea (391).
Secondo
una tradizione poco verosimile, sarebbe tornato nel 390, dopo la
presa di
Roma da parte dei Galli, interrompendo le trattative di riscatto
con la
famosa frase « Non con l'oro ma con il ferro si salva la patria » e
avrebbe
ricacciato gli invasori. Attese, quindi, alla ricostruzione di Roma
e
diresse, nel 389 a.C., le guerre contro gli Equi, gli Ernici e i
Volsci;
inoltre aumentò l'effettivo dell'esercito romano, introducendo lo
stipendio
per i nullatenenti, e circondò il Campidoglio di potenti
fortificazioni.
Grande personalità ebbe il soprannome di Secondo Fondatore di
Roma e la
leggenda ne abbellì la figura e le gesta.
MASTARNA ed i
VIBENNA
Riflessi sulla storia di Roma
Quello di cui ci accingiamo
ora a parlare è un capitolo della storia di Roma
che manca completamente nei
racconti degli storici di età tardo-repubblicana
e imperiale, cioè nella
storiografia ufficiale romana, pur trattandosi di un
capitolo d'importanza
non trascurabile, come vedremo. È questo un esempio
tra i più evidenti della
distanza che intercorre tra le memorie dei tempi
protostorici c arcaici e la
grande stagione della letteratura latina. Dei
fatti in questione abbiamo
tuttavia qualche sentore più che dalle opere di
storia dagli scritti di
erudizione: frammenti di notizie sparse e
perfinodiscordanti, fra le quali
tuttavia non mancano spunti di autorevole
credibilità e alle quali documenti
archeologico-epigrafici originali offrono
un appoggio determinante. Nella sua
forma più semplice il racconto si
riferiva ad un nobile condottiero etrusco
chiamato Caele o Caelius Vibenna
venuto a Roma ai tempi di Romolo per dargli
aiuto contro i Sabini, ovvero al
tempo del re Tarquinio (s'intende Prisco), e
che in ogni caso avrebbe dato
il suo nome al Monte Celio da lui occupato e
abitato. La prima variante
cronologica è riportata essenzialmente da Vatrone
(de lingua Lat. V, 46),
accolta per cosl dire incidentalmente da Dionisio di
Alicarnasso là dove si
parla di Romolo, e altrimenti piuttosto nota e
diffusa. Ma questa versione
faceva genericamente riferimento agli Etruschi o
ai Lucumoni o a personaggio
denominato Lucumone (Cicerone in de Republica II,
8,14). L'altra versione
che abbassa l'avventura di Vibenna all'età dei
Tarquinii cioè al VI secolo
ha dalla parte l'autorità di Tacito, Annali IV,
65,1-2 e soprattutto l'
importantissimo anche se estremamente mutilato
frammento di Festo sotto
Tuscum Vicum, 486,12-19, in cui si parla di Cele e
di un fratello Vibenna
originari di Vulci (se l'aggettivo etnico che li
definisce va reintegrato
Volcientes come è pressochè certo sulla base di
altre fonti), e con loro di
un Maxtarna (del cui nome sono conservate solo le
prime tre lettere, ma la
cui completa restituzione non dovrebbe dar luogo a
dubbi).
C'è poi una.testimonianza il cui valore supera quello di ogni
altro
argomento, e cioè l'annotazione contenuta in un discorso al
senato
dell'imperatore Claudio (riportato nelle tavole di bronzo di Lione),
nel
quale si affèrrria che secondo autori etruschi Servio Tullio era stato
in
origine un personaggio chiamato Mastarna, fedelissimo sodalis e compagno
di
ogni avventura del duce Caelius Vivenna, del cui esercito variamente
provato
dagli eventi ed uscito dall'Etruria egli avrebbe condotto i resti
ad
occupare il Monte Celio; cambiato nome avrebbe poi ottenuto il regno di
Roma
con grande vantaggio per lo stato. L'autorità di questa fonte, rispetto
ad
ogni altra attestazione letteraria, è garantita dalla certezza del
testo,
dalla ufficialità della sede e dalla solennità dell'occasione in cui
fu
pronunciata l'orazione claudiana, tali da escludere ogni
irresponsabile
fantasia, infine ovviamente dalla pedantesca competenza
dell'imperatore
etruscologo.
Tutti questi dati della tradizione sono
confermati, collegati e per così
dire illustrati da quel singolare documento
che è il fregio dipinto della
Tomba Francois di Vulci, databile intorno agli
ultimi decenni del IV secolo
a.C., che è quanto dire poco più di due secoli
dopo gli avvenimenti
presumibilnente descritti. Le figure sono accompagnate
dalle didascalie con
i nomi relativi. Il fregio si sviluppa su tre tratti di
parete; vi è
rappresentato un combattimento con cinque coppie di personaggi,
in gran
parte in nudità o seminudità (eroica?): partendo da sinistra (vicino
alla
porta della cella iella tomba), Caile Vipinas {Celio Vibenna) liberato
da
Macstrna (Mastarna) che gli taglia i ceppi alle mani con la spada ed
ha
pronta per lui un'altra spada; seguono Larfs UIfes (Larth
Ulthes),
indossante una tunica, che trafigge Laris Papasfnas Velznax, cioè
Laris
Papathnas di Volsinii; Rasce in atto di colpire Pesna Arcmsnas Sveamax,
cioè
Pesna Arcmsna di una città chiamata *Sveama, forse Sovana, avvolto in
un
nanto listato che gli copre il capo; Avle Vipinas, cioè Aulo libenna,
che
afferra la chioma e infila la spada sotto il braccio di un nemico
di
apparente chioma bionda, designato da ma scritta mal conservata
come
Vensficau... plsaxs (nome inidentificabile: si è pensato anche ad un
etnico
Venthi per Veletus, e città d'origine anch'essa non riconoscibile);
infine
Marce Camitlnas che ha atterrato o sorpreso a terra e tiene per i
capelli
Cneve T arxunies RumaX, cioè Gneo Tarquinio di Roma che abbiamo
già
menzionato, il quale tenta di fermare con la destra la spada che sta
per
inferirgli il colpo fatale. Analizziamo la scena cominciando dai
personaggi.
L'ultimo duello è per noi il più significativo perchè ci
garantisce
l'ancoraggio cronologico dell'intera storia con l'età dei
Tarquinii, oltre
che il suo diretto rapporto con Roma, offrendo così il più
puntuale
riscontrò con le fonti di Claudio e di Tacito. Un altro dato
importante è
l'apparizione di Aulo Vibenna, il fratello di Celio che dalle
fonti
letterarie citate non era contemplato se non nel tormentato passo di
Festo
dove peraltro non è leggibile il prenome. Ma la coppia dei due
fratelli
torna a presentarsi comunque chiaramente appaiata, con le
relative
didascalie (Caile Vipinas e Avle Vipinas), in procinto di aggredire
un
giovane cantore vaticinante di nome Cacu (ma quanto diverso dal Caco
feroce
brigante della leggenda romana!), nella figurazione di uno specchio
del
Museo Britannico proveniente da Bolsena; lo stesso tema si riscontra
in
rilievi di urne cinerarie di Chiusi ma senza i nomi. È evidente da
queste
figurazioni che i due personaggi sono considerati eroi ed entrati nel
mito.
Considerando ora tutto il complesso del fregio vulcente
distinguiamo
chiaramente le due parti in conflitto. Sei figure costituiscono
il gruppo
vincente: oltre Macstrna che libera Caile Vipinas, quattro
combattenti che
colpiscono i nemici con la spada, di cui soltanto uno
tunicato (Larth
Ulthes), gli altri nudi (Rasce, Avle Vipinas, Marce
Camitlnas). Va
sottolineato che la maggior parte di questi personaggi è
designata con la
formula onomastica bimembre, prenome e gentilizio, rivelando
con ciò la sua
appartenenza alla classe dotata di diritti civili, cioè i due
Vibenna, Larth
Ulthes (l'unico che sia parzialmente vestito) e Marce
Camitlnas; mentre
Macstrna e Rasce hanno un unico nome individuale e
dovrebbero quindi
ritenersi di condizione servile o comunque inferiore,
secondo quanto
sappiamo del sistema onomastico etrusco. I loro quattro
avversari
soccombenti sono tutti caratterizzati da prenome e gentilizio, cui
si
aggiunge un terzo elemento in posizione di cognomen (ma non con
le
caratteristiche morfologiche di un cognomen, e perciò piuttosto un
derivato
con valore di « etnico ») indicante la città di provenienza o
di
appartenenza: Volsinii per Laris Papathnas, *Sveama- per Pesna Arcmsna,
nome
non leggibile per Venthicau..., Roma per Cneve Tarchunies.
L'intenzionalità
della precisazione etnica per i quattro sconfitti è
evidente: si direbbe che
la si sia voluta contrapporre ad aggressori «senza
patria». La presenza tra
loro di un Tarquinio di Roma fa ragionevolmente
pensare che per tutti si
tratti di personaggi di alto rango, se non
addirittura di capi o re delle
rispettive città.
Dalle persone si può
passare ora alla natura dell'azione. Tutta una serie di
indizi prova
chiarissimamente che qui non si è inteso offrire un quadro
generico di
battaglia, ma si è voluto rappresentare un episodio storico
molto particolare
e ben definito. Tale episodio presuppone che Caile
Vipinas, capo di una certa
consorteria (come mostra il risalto datogli dal
fregio), sia stato preso
prigioniero da uno schieramento avversario. I suoi
compagni ne hanno
predisposto la liberazione con un'azione che coglie di
sorpresa, forse nel
sonno, i catturatori. La scena appare ritratta con una
simultaneità di
movimenti quasi come una «istantanea». Ogni assalitore
colpisce un avversario
con la spada snudata; ad uno degli assaliti scivola
il manto dal capo; un
altro lascia cadere lo scudo che non ha fatto in tempo
ad abbracciare; un
altro ancora è a terra, non ancora levato o caduto. Per
quel che riguarda il
primo gruppo, che naturalmente è il principale, mentre
intorno la lotta
infuria vediamo il liberatore Mastarna tagliare i legami
del prigioniero e
portargli la spada destinata a farlo entrare nel
combattimento.
Che cosa
significa tutto questo? Si tratta senza dubbio di un fatto
importante,
presumibilmente decisivo; di vicende concernenti le avventure
dei Vibenna e
dei loro seguaci, contrastate da avversari potenti. Di una
prigionia e
conseguente liberazione di Cele Vibenna la tradizione letteraria
non parla,
almeno per quanto essa è giunta tanto lacunosamente fino a noi.
Che questo
evento e in generale la storia dei Vibenna siano presenti tra i
soggetti
pittorici della grande Tomba Francois di Vulci, unico tema
«storico» locale
tra i molti ispirati dalla mitologia greca (a parte il
«ritratto» in
apparente costume trionfale di Vel Saties, titolare e membro
della famiglia
proprietaria della tomba, di cui non è qui il caso di
discutere), si spiega
con l'intento di glorificare antichi personaggi, se
non già addirittura eroi,
della città come i Vibenna e in pari tempo
alludere alla loro vittoria sul
romano Tarquinio, in un momento (fine del IV
secolo) in cui Vulci doveva
essere gravemente minacciata dai Romani già
penetrati a fondo in
Etruria.
S'intende che anche proprio per questo l'episodio rappresentato
dalla
liberazione di Caile Vipinas deve intendersi come vittoria, e
vittoria
clamorosa, della sua parte contro la parte avversa. Resterebbe forse
da
spiegare perchè questa parte avversa veda schierarsi simultaneamente
e
parallelamente quattro «rappresentanti» eminenti di quattro città che,
con
la loro uccisione, debbono intendersi vinte. Qui sospettiamo che il
realismo
della scena episodica abbia ceduto almeno parzialmente il campo ad
un certo
simbolismo figurativo, per cui si sia voluta considerare presente
e
soccombente l'intera coalizione nemica attraverso i suoi capi,
eventualmente
anche fondendo in uno altri fatti, con quella visione
contemporanea di
momenti diversi che sarà poi caratteristica della pittura e
del rilievo
trionfali romani. Chiaro sembra anche il proposito di
contrapporre alla pari
ed elevata dignità dei vinti la mancanza di
qualificazione etnica e
l'eterogeneità sociale dei vincitori (partecipazione
dei due individui senza
gentilizio: Mastarna e Rasce).
Un ultimo gruppo di
testimonianze, interessante proprio Roma in maniera più
diretta, va preso in
esame a proposito di Aulo Vibenna, il fratello del
«capo». Meno illustre e
meno ricordato per quel che riguarda l'avventura
primaria, egli sembra
apparirci protagonista di vicende conseguenti
incentrate a quanto sembra
attorno a Roma. Il documento fondamentale, tanto
ricco di dati interessanti
quanto poco chiaro, è un lungo passo dello
scrittore cristiano Arnobio
(Adversus gentes VI, 7) in cui si fa riferimento
a diverse fonti annalistiche
risalendo in ultima analisi fino a Fabio
Pittore. In forma retorica e
alquanto complicata si allude ad eventi della
vita di Olus (cioè Aulus)
Vulcentanus e in particolare si accenna al fatto
che egli fu ucciso per mano
di un servo, che non si vollero accogliere le
sue spoglie in patria, che fu
sepolto sul Campidoglio e che il tempio
capitolino (con il colle) prese nome
dal suo cranio ritrovato dopo qualche
tempo (caput Oli = Capitolium).
La
leggenda della scoperta del cranio al momento della fondazione del tempio
di
Giove ricorre in diversi autori romani; in particolare l'etimologia caput
Oli
è ricordata da Servio nel commento all'Eneide (VIII, 345) e dalla fonte
del
Cronografo di Vienna (anno 354 d.C.), che precisa che sul cranio era
scritto
in lettere etrusche «caput Oli regis»; di una iscrizione in lettere
etrusche
parlava anche Isidoro, Origines XV, 2,31. Da notare che questo
prodigioso
rinvenimento, ritenuto augurale per la futura grandezza di Roma
anche da
interpreti etruschi interpellati in proposito, è riportato da Livio
(I, 55)
al regno di Tarquinio il Superbo, cioè in tempi posteriori agli
ipotetici
eventi del «periodo serviano». Ma a fronte di queste memorie
favolose noi
possediamo una testimonianza concreta di straordinario valore,
rappresentata
con pressochè assoluta certezza da un documento originale
dello stesso Aulo
Vibenna, cioè una iscrizione dedicatoria etrusca trovata
nel santuario di
Portonaccio a Veio con il suo nome in forma arcaica Avile
Vipiiennas, incisa
sopra un piede di vaso di bucchero databile tra il
secondo quarto e la metà
del VI secolo. La presenza nello stesso deposito di
oggetti offerti da
personaggi di alto rango come i Tulumne che poi
regneranno a Veio ci
autorizza a credere che qui si tratti veramente di
quell'Aulo Vibenna di cui
era rimasta a Roma una cosl cospicua memoria. Ma
c' è pi più. In una coppa
etrusca di imitazione greca dipinta a figure rosse
della metà circa del V
secolo proveniente molto probabilmente da Vulci,
attualmente conservata a
Parigi nel Museo Rodin, c'è una dedica Avles
Vi(i)pinas la quale fa pensare
che questo personaggio fosse stato ben presto
addirittura eroizzato
(personalmente e singolarmente, cioè in un quadro
diverso dalla tradizione
dei racconti mitici da cui derivano le citate
figurazioni dei due fratelli
nello specchio di Bolsena e nelle urne
chiusine).
Da tutto l'insieme di
dati sin qui raccolti, anche se scarni e di tanto
diversa natura, non è
tuttavia impossibile cercare un'interpretazione
storica. E' cosa certa che
nella prima metà del VI secolo un grosso
sconvolgemento ha turbato l'Etruria
meridionale e Roma (riguardo all'Etruria
questa vicenda appare tanto più
importante se si considera quanto poco
sappiamo della storia politica etrusca
in generale). Si tratta di un'azione
militare guidata da un condottiero
originario di Vulci, Caile Vipinas, e dai
suoi seguaci, presumibilmente a
scopo di rapina e di conquista, senza
peraltro escludere altre eventuali
ragioni di carattere ideologico o sociale
che ci sfuggono. L 'impresa come
già sappiamo è un esempio tipico
dell'avventurosità delle aristocrazie
arcaiche (i Vibenna erano di stirpe
nobile come risulta da Varrone e,
presumibilmente, dalle fonti di Arnobio) e
sembra avere, almeno inizialmente,
il carattere di un'iniziativa privata o
se si preferisce «gentilizia»: non
certo espressione della politica di una
città, nella fattispecie Vulci, anche
se più tardi Vulci la esaltò come una
sua gloria nelle pitture della Tomba
Francois (che probabilmente sono copie
della decorazione di un edificio
pubblico).
Tuttavia non si può del tutto escludere che nel movimento
suscitato dai
Vibenna possa essersi inserito qualche elemento di tendenza
riformistica e
antioligarchica, forse maturata proprio a Vulci città
apertissima alle
influenze della Grecia e quindi anche possibilmente alle sue
innovazioni
socio-politiche. Ciò porterebbe ad un contrasto con gli ambienti
più
conservatori soprattutto dell'Etruria interna; e sarebbe una
spiegazione,
peraltro del tutto ipotetica, di quell'estendersi della sfera
d'azione della
potenza armata dei Vibenna fino ad investire e minacciare
grandi città come
Volsinii e Roma. Bene inteso non sarà da pensare a
cambiamenti politici
ingenti e durevoli, se non forse per Roma, come vedremo.
La presentazione
dei rappresentanti vinti ed uccisi delle quattro città nel
fregio della
tomba Francois è verosimilmente un'amplificazione di singoli e
più modesti
avvenimenti reali. Le forze degli aggressori saranno passate come
un uragano
attraverso l'Etruria meridionale interna e la valle del Tevere,
con vicende
alterne, come provano da un lato la «varia fortuna» del testo di
Claudio, da
un altro lato gli episodi della cattura e della liberazione dello
stesso
capo della spedizione Caile Vipinas testimoniate dalle pitture
vulcenti. La
quasi totalità di questi avvenimenti deve essersi svolta in
Etruria. A Roma,
stando alla versione claudiana, sarebbero giunti solo i
resti dell'esercito
sotto la guida di Mastarna, ciò che implicherebbe
l'uscita di scena di
Caile.
Che cosa accadde poi? Per rispondere a questa
domanda conviene. considerare
più da vicino le persone degli attori del
dramma. Si è già detto dei Vipina
(forma originaria arcaica Vip(i)ien(n)a,
forma latina Vibenna con la
variante Vivenna della registrazione epigrafica
del discorso di Claudio); si
può aggiungere che questo nome gentilizio
apparirà diffuso in tutta
l'Etruria per l'intero corso della storia etrusca,
con particolare riguardo
all'area vulcente, centro-etrusca e chiusina: deriva
da una forma semplice
«prenominale» Vipi (latino Vibius) comune anche
all'onomastica delle lingue
italiche e più frequente nell'Etruria meridionale
(ricordiamo tra l'altro il
Vel Vibe veiente del frammento di Nevio). La
compagnia di Caile Vipinas
nella Tomba Francois appare, ripetiamo,
socialmente mista: la presenza di
parenti (Aulo), amici di pari rango (Larth
Ulthes, Marce Camitlnas) e
coadiutori di rango inferiore (Macstrna, Rasce)
ricorda molto da vicino la
composizione delle consorterie che accompagnavano
la migrazione del futuro
Tarquinio Prisco o sdstenevano Servio Tullio
aspirante al regno nel racconto
degli storici. Larth Ulthes ha un raro
gentilizio attestato in tempi più
recenti anche con forme affini in area
centro-etrusca.
Quanto al nome Camitlnas, in verità isolato, l'ovvia
assonanza con Camillus
può essere fuorviante; anche se non sarà da rigettare
a priori; il richiamo
più pertinente potrebbe essere con il tipo Camcdius e
derivati, di area
laziale, campana, umbro-sannitica: dunque forse un
commilitone «meridionale»
(al quale sarebbe toccato il gesto più pregnante,
quello di colpire
Tarquinio). Restano i due «senza nome»: Mastarna e Rasce,
per il quale
ultimo si può pensare ad un semplice ausiliare designato
genericamente dalla
sua nazionalità (Ras-ce con formazione equivalente a
Rasna, Rascnna, cioè
« l'etrusco» o « un etrusco »?).
Mastarna esige un
più particolare esame perchè il suo nome e la sua
personalità costituiscono
il problema centrale di ogni possibile tentativo
di interpretazione storica
di questi fatti per quanto essi riguardano Roma.
Che la forma onomastica
etrusca Macstrna (latinizzata in Max(tarna),
Mastarna) contenga la parola
latina magister è una vecchia certezza che non
può dar luogo a dubbi. La
questione è invece quella del suffisso -na che in
etrusco è un sicurissimo
indicatore di appartenenza. La forma macstr-na non
può quindi equivalere
semplicemente a macstr- cioè magister; ma deve
piuttosto significare qualcosa
come «relativo al magister», «appartenente a
magister». Cadrebbero di
conseguenza tutte le ipotesi formulate in
precedenza, anche dall'autore di
questo libro, circa una funziont di potere
esercitata dal personaggio
Mastarna in Roma con il titolo di magister, sia
come comandante militare
luogotenente di Tarquinio Prisco, sia come magister
populi più o meno di
estrazione popolare, o simili. Il magister al quale si
riferisce il nome di
Mastarna non sembra possa essere altro che Cele
Vibenna, quel capo di cui
Mastarna era stato sodalis fidelissimus secondo la
tradizione claudiana.
Proprio questa sodalitas si esprime nella forma che
indica grammaticalmente
il concetto di appartenenza, e può spiegare in pari
tempo la condizione di
inferiorità sociale di Mastarna, privo di un nome
gentilizio e
contraddistinto solo da una qualifica funzionale, e l'intimo
legame di
personale devozione al suo comandante di cui è testimonianza,
oltre al
fidelissimus claudiano, la scena della liberazione nel fregio di
Vulci. Si
può e si deve immaginare uno speciale rapporto di fiducia e di
amicizia di
Cele verso il suo «scudiero», tale da porre quest'ultimo in una
posizione di
privilegio, di cui si vedranno forse nel futuro le conseguenze.
Quanto al
fatto che il capo etrusco della grande spedizione possa essere
stato
ricordato con il titolo latino di magister senza dubbio esso
costituisce per
noi un motivo di perplessità: non però gravissimo se si
pensa che il termine
latino appare, sia pure in tempi assai più recenti,
nella titolatura dei
magistrati etruschi (macstrev in un sarcofago di
Tuscania, Corpus
lnscriptionum Etruscarum 5683), ma ancor più supponendo
antiche profonde
interferenze fra mondo etrusco e mondo latino in
particolari settori del
linguaggio tecnico-istituzionale, o la possibilità
di usare un termine
straniero alla moda, o qualche altra cosa di simile.
L'estremo punto d'arrivo
dello sconvolgente movimento dei Vibenna calato per
la valle tiberina - via
che diverrà tradizionale per ogni invasione dal
nord - è, come si diceva,
Roma; ed a Roma si svolgeranno gli ultimi atti di
questa vicenda storica, per
quanto sappiamo. Non si può dire se la versione
data dalle fonti di Claudio
circa la presenza a Roma solo dei resti della
spedizione senza più il suo
capo sia integralmente accettabile sul piano
storico. Nella testimonianza
figurata del fregio vulcente il rappresentante
di Roma Cneve Tarchunies cade
vinto in presenza di Calle Vipinas, il quale
dunque è da considerarsi
responsabile della sconfitta di Roma simboleggiata
in questa scena e potrebbe
aver colto il frutto della sua vittoria occupando
in tutto o in parte la
città nemica. Ne si può escludere la eventualità che
realmente al suo nome si
ricolleghi quello del Caelius mons come voleva
unanimemente la tradizione
antica, anche se è più sensato credere con gli
storici moderni che si tratti
di una falsa etimologia. Comunque l'idea che
il capo della spedizione sia
personalmente arrivato fino a Roma nel corso
delle sue azioni militari non è
da scartare. Ciò che conta è quanto accade
dopo la sua scomparsa (dovuta alla
morte o a una qualsiasi altra ragione) ed
è adombrato nel racconto claudiano,
cioè il fatto che una parte residua del
suo esercito sarebbe rimasta affidata
a Mastarna il quale l'avrebbe
impiegata per installarsi definitivamente in
Roma.
A questo punto il discorso si fa più complesso ed ipotetico. Tutte
le
notizie che abbiamo raccolto su Aulo Vibenna indipendentemente dagli
scenari
nei quali egli appare in coppia con il fratello inducono a pensare
che egli
abbia avuto una propria storia probabilmente da collocare in una
fase
posteriore alla scomparsa di Cele. E' facile immaginare che questa
scomparsa
abbia creato problemi di successione e che, la stretta parentela e
la
comunanza delle imprese abbiano naturalmente portato Auto ad
assumere
l'eredità del fratello nel comando della spedizione e dell'esercito.
E'
sospettabile che a questa designazione abbia concorso soprattutto la
parte
«aristocratica» della consorteria, quelli che le fonti
storiografiche
designano in casi analoghi, come «parenti» ed «amici» del
capo. Ma
l'esercito di Cele Vibenna comprendeva anche i sodales, le clientele
e in
genere gli ausiliari, come si indovina in qualche maniera nella stessa
scena
pittorica della Tomba Francois. Soprattutto esisteva il fatto
certissimo
(concordemente provato dalla testimonianza claudiana e dalle
pitture
vulcenti) del rapporto molto stretto di fedeltà e di fiducia tra
Cele
Vibenna e Mastarna, che può aver procurato a quest'ultimo un
potere
illimitato evidentemente prolungatosi oltre la morte del capo.
Una
fondamentale rivalità ed un finale scontro fra Auto Vibenna e Mastarna
sono
da immaginare logicamente e oseremmo dire con certezza. In Roma
conquistata
(per merito di Mastarna) Aulo avrà avuto inizialmente la
supremazia, per i
suoi diritti familiari di successione al fratello: ne
abbiamo qualche indizio
nelle fonti già citate a proposito del caput Oli e
tra queste il ricordo di
una supposta iscrizione etrusca che lo designava
addirittura come re. Ma
Mastarna, capo di fatto con l'appoggio
dell'esercito, avrà finito con il
prevalere eliminando il rivale. Di questi
ipotetici avvenimenti non esistono
testimonianze. Tuttavia un filo tenue di
prova potrebbe intravedersi nel
citato confuso testo di Arnobio, dove, certo
sulla scorta di remote fonti
annalistiche (forse dello stesso Fabio
Pittore), si accenna come a fatto
notorio alle ragioni per cui Olus sarebbe
stato ucciso da un servo, «...cur
manu servuli vita juerit spoliatus et
lumine». Un sicario di Mastarna? o
Mastarna stesso designato dal primo
relatore del fatto come «servo» per le
sue originarie condizioni
d'inferiorità sociale?
L'occupazione di Roma da
parte degli invasori etruschi, i Vibenna, Mastarna,
i loro compagni, le loro
truppe, è conseguenza e causa del crollo della
monarchia dei Tarquinii. Non
abbiamo dati sufficienti per indicarne con
precisione la cronologia (e con
essa naturalmente la fine del «periodo di
Tarquinio Prisco» e l'inizio del
«periodo serviano»); tuttavia una proposta
che la collocasse intorno al
570-560 non sarebbe forse troppo lontana dal
vero. La caduta di Cneve
Tarchunies nella scena di combattimento della Tomba
Francois fa pensare
logicamente a scontri cruenti e alla soppressione
violenta del potere della
dinastia regnante, con una eventuale sostituzione
dei nuovi dominatori nel
ruolo e nel titolo regio. Sarebbe questa la
spiegazione dell'« Olo (Aulo) re»
della favolosa iscrizione del Campidoglio
(pur ricordata da fonte tardissima
e incerta); si potrebbe cioè immaginare
che Aulo Vibenna sia senz' altro
salito sul tropo degli spodestati Tarquinii
(anche se il suo nome, obliterato
o cancellato, non apparirà nella lista
canonica dei re di Roma); e potrebbe
essere che in questa posizione e in
questo periodo Aulo Vibenna offrisse un
suo donario nel santuario di Veio.
Ma si può pure pensare, in modo diverso,
che la sovranità dei Tarquinii non
sia stata subito e del tutto annullata e
che, pur sotto la dominazione o la
soverchiante presenza degl'invasori, essi
abbiano continuato a portare il
titolo regio e a conservare una loro sede in
un settore della stessa città,
con vicende alterne di convivenza e di
conflitti (di cui potrebbe darci
qualche idea la stessa tradizione a
proposito dei rapporti fra i Tarquinii e
Servio Tullio).
Ci chiediamo se
nell'insediarsi a Roma degli epigoni delle imprese di Cele
Vibenna possano
essere emersi, ed aver acquistato rilievo, quei motivi di
irrequietezza
sociale e di tendenza ad un riformismo in senso
antioligarchico diffusi in
Etruria, di riflesso dal mondo greco, che abbiamo
già sospettati presenti
all'inizio del movimento dei Vibenna. E' possibile
che proprio in queste fasi
finali della occupazione di Roma l'originario
carattere «gentilizio» del
movimento stesso sia andato attenuandosi e gli
elementi di estrazione
subalterna abbiano preso sempre maggiore risalto
nella conduzione delle
milizie.
L'affermazione di Mastarna e la ipotetica ma verosimile eliminazione
di Aulo
Vibenna possono essere considerate come le manifestazioni più
appariscenti
di queste tendenze. Lo stimolo sovvertitore o almeno perturbante
proveniente
dall'esterno può aver avuto importanti ripercussioni anche sugli
ambienti
locali di Roma. Rivendicazioni e innovazioni possono aver trovato il
loro
terreno più favorevole nelle zone di Roma più aperte ad influenze
straniere
e alle sfere del commercio e del lavoro, in particolare come è
naturale
attorno al porto tiberino (è un fatto interessante che proprio qui
nel
santuario di S. Omobono si sia trovata tanta ceramica etrusco-corinzia
di
produzione vulcente: un rapporto con la patria dei Vibenna?). La
politica
conservatrice restò probabilmente legata alla tradizione dei
Tarquinii e ai
loro circoli. Immagineremmo volentieri la loro roccaforte su
quel monte
capitolino sul quale si avviava a sorgere il grande tempio di
Giove
(dedicato da Tarquinio Prisco, compiuto dal Superbo secondo gli
storici
romani), massima espressione della pietà, della magnificenza e della
potenza
della dinastia.
Resta ora da affrontare il problema che ci si
attenderebbe come conclusione
a questo punto: quello della identità di
Mastarna e di Servio Tullio
affermata dalle fonti etrusche di Claudio. In
realtà non possiamo sfuggire,
ne sfuggì un certo settore dell'erudizione
antica, alla suggestione di
coincidenze rilevantissime. Mastarna è a Roma uno
straniero privo di nome
gentilizio e perciò appartenente ad una classe
inferiore; Servio Tullio è
ricordato dalla tradizione come straniero e
apolide, cioè originariamente
senza diritti di cittadinanza. Mastarna si
impone a Roma a seguito di eventi
che implicano la sconfitta e
presumibilmente l'uccisione di un Tarquinio;
Servio Tullio salirà al trono, o
piuttosto si impossesserà del regno dopo
l'uccisione di Tarquinio Prisco. Si
può aggiungere che le riforme attribuite
a Servio Tullio comprendono la
creazione di un sistema di rappresentanza (e
pertanto una fonte di potere
politico), cioè i comizi centuriati,
essenzialmente basato sopra una
struttura militare: ciò che fa pensare alla
importanza che potrebbe aver
avuto per la vita pubblica di Roma la presenza
di un esercito organizzato
come quello di cui, dopo la scomparsa. di Cele
Vibenna, era diventato arbitro
Mastarna.
Sembra dunque lecito argomentare senza eccessivo sforzo di fantasia
che
Mastarna, rimasto ormai solo a capo delle milizie stanziate in Roma
dopo
l'eclissi dei due Vibenna, abbia inteso progressivamente stabilizzare il
suo
potere, assumendo un nome gentilizio e cercando localmente una
legittimità a
quella dignità regia alla quale forse con effimera esperienza
si era
accostato Aulo Vibenna. Ma in ultima analisi che i fatti si siano
svolti in
un certo modo e che propriamente Servio Tullio sia la stessa
persona di
Mastarna è non solo non dimostrabile con cettezza, ma forse
anche
irrilevante per il nostro giudizio storico finale. Ciò che conta è
che
esiste un possibile e logico legame di continuità fra ciò che
rappresentano
nelle loro rispettive sfere le figure di Mastarna e di Servio
Tullio.
MECENATE Caio Cilno
Caio Cilno Mecenate, nato ad Arezzo nel 69
a.C. e discendente da una
schiatta regale etrusca, divenne il personaggio più
famoso della corte
augustea. La famiglia dei Cilni risaliva al IV secolo a.C.
Militare, nella
prima parte della sua vita, e politico, Mecenate fu
testimone della
trasformazione definitiva di Roma e del passaggio dalla
Repubblica all'
Impero. Eletto "vicario" da Ottaviano per la grande fiducia
che era riuscito
ad ispirare, seppe accontentarsi del titolo di "eques",
proprio degli
appartenenti all'ordine equestre, classe sociale definita da
Orazio "la più
eletta del popolo per squisitezza di gusto" (Sat.
1,10,76).
Ritiratosi dalla vita politica, visse delle ricchezze familiari che
gli
provenivano da certe fabbriche di vasi che fiorirono in Arezzo dal 30
a.C.
in poi. Nella vita privata si dedicò solo ai piaceri dello
spirito
scrivendo, conversando e "banchettando" alla maniera etrusca. Seppe,
con
oculatezza rara, scegliersi gli amici. Nel suo ruolo di "scopritore
di
talenti" Mecenate si era creato una cerchia di amici di
notevole
sensibilità: Virgilio, Properzio, Gallo, Orazio, Marziale. Con
intuito e
riservatezza tipicamente etruschi, tra questi ne preferì due che
hanno dato
fama al suo nome: Virgilio e Orazio.
Virgilio, privato dei
campi in riva al Mincio dalle riforme di Augusto e con
la speranza che gli
sarebbero restituiti, il Poeta arrivò a Roma. Asinio
Pollione, governatore
delle terre sul Mincio, lo presentò a Mecenate.
Virgilio già autore delle
Bucoliche dove si esaltava la vita pastorale,
piacque all'"etrusco" che
intercedette presso Augusto. Ma il centurione
Arrio, divenuto nel frattempo
proprietario di quei campi, minacciò di
"accoppare" il Poeta. Mecenate
allora, come risarcimento dell'esproprio
subito, assicurò a Virgilio un
podere in Campania. Nel "fundus" napoletano,
solitario e lontano dal viavai
cittadino, il Poeta poté astrarsi, meditare e
riscoprire la stessa pace dei
campi mantovani. E nacquero le Georgiche che
trattano della bellezza dei
campi.
Le umili origini di Orazio sono note a tutti. Figlio di un liberto e
nato in
un piccolo centro sulla via Appia, Venusia o Venosa, vicino a
Potenza, in
Basilicata. Per i sacrifici del padre, Orazio ebbe un'educazione
letteraria
degna di un nobile. La povertà e la cattiva sorte lo
perseguitarono a tal
punto che dovette accontentarsi di un modesto ufficio
di scrivano quando
Virgilio lo presentò a Mecenate. Il lungimirante etrusco
trovò essenziale,
al vivere, il buon senso e 1'avversione ad ogni gesto
irrazionale del Poeta.
In seguito si stabilì tra i due uomini una stretta
amicizia che proseguì
fino alla morte avvenuta per entrambi nello stesso
anno: l' 8 d.C.. Mecenate
aveva donato al fedele amico una villa in Sabina.
Qui Orazio si ritirava nei
suoi ozi meditativi spesso raggiunto dallo stesso
Mecenate. Le Satire e le
Odi, tra le opere di Orazio, sono le più
significative per il nostro
argomento. Il ricco e raffinato etrusco non
disdegnava sedere alla parca
mensa dell'amico a mangiare olive e bere il vino
modesto che la terra
sabina - corrispondente, oggi, in parte alla provincia
di Rieti e in parte
al territorio di Roma - offriva. Nel descrivere la villa
di Mecenate, Orazio
ammirava le ghirlande composte di fronde verdi, miste a
frutta e fiori, che
pendevano dalle pareti dei
triclinii.
OCRESIA
Ocresia era un'ancella che Tanaquilla aveva scelto
tra molte fanciulle
tarquiniesi per portarla con sè a Roma. Oppure, come
dicono alcuni, una
semplice serva; o, come affermano altri, una schiava
condotta come bottino
di guerra nella reggia romana, dopo la morte in
battaglia di suo marito, il
re di Cornicolum, dal quale aspettava un figlio.
Comunque siano andate le
cose, Ocresia entrò presto nel potente cerchio
magico e divinatorio della
regina Tanaquilla e diventò così un personaggio
chiave nella tormentata
storia della monarchia etrusca nell'Urbe, perché fu
madre del sesto re di
Roma. Sulla nascita e la giovinezza di questo re si
raccontano fatti
straordinari: "Un giorno - apprendiamo da Plinio - apparve
tra le fiamme di
un focolare della reggia di Tarquinio Prisco un membro
virile e Ocresia che
lì sedeva ne fu resa incinta. Il figlio che nacque da
questo concepimento
magico si chiamò Servio Tullio". L'insolito evento era
stato quasi
dimenticato col passare del tempo, "quando - è Livio che ora
racconta -
avvenne un altro fatto mirabile. Tutti videro lunghissime fiamme
ardere
intorno alla testa di Tullio giovinetto".
Tanaquilla chiamò il re
e, avendo accanto Ocresia, profetò: "Il figlio di
questa donna e del nume che
per lui si manifesta con il fuoco, sarà nei
momenti oscuri il salvatore degli
etruschi in Roma. E come ora splendono
queste fiamme che gli avvolgono il
capo, così da lui verrà molta luce alla
casa dei Tarquinii".
Il giovane,
protetto dai vaticini, fu allevato con tale regalità che
Tarquinio Prisco,
non conoscendo un romano che reggesse il suo confronto,
quando giunse l'ora
gli dette in sposa sua figlia. I ritrovamenti
archeologici più recenti
contrastano nettamente con queste leggende e
dimostrano in modo
inequivocabile che in realtà Servio Tullio era Mastarna,
l'eroe di Vulci che
si recò a Roma non per difendere i Tarquinii che
riteneva arroganti e
tirannici, ma per combatterli a favore del popolo e
riorganizzare gli
ordinamenti pubblici.
A lui si deve, infatti, la Costituzione Serviana che
eliminava i privilegi
della nobiltà del sangue e assegnava per la prima volta
i diritti politici e
la possibilità di entrare nelle milizie a tutti i
cittadini, anche romani.
Ma per le leggende, dure a morire, il suo destino
regale nacque, si snodò e
si compì nella reggia dei Tarquinii, manovrato
dalla ferrea volontà di
Tanaquilla. Infatti quando Tarquinio Prisco venne
ucciso in una congiura di
palazzo sulla quale tutto è lecito ipotizzare, fu
lei a tenere nascosto per
molto tempo il cadavere del marito e a regnare in
sua vece nel chiuso della
reggia. Solo quando tutte le fazioni si furono
piegate ai suoi disegni e
tutte le opposizioni furono sedate nel sangue,
Tanaquilla apparve
solennemente al popolo per comunicare che il vecchio re
era appena morto.
Poi annunciò con voce ferma e autorevole che il nuovo re di
Roma era Servio
Tullio, figlio di Ocresia e del Fuoco, considerato dagli
stessi Dei un
Tarquinio perché nato prodigiosamente nella loro
reggia.
PORSENNA
Lucumone della città etrusca di Chiusi verso la fine
del V sec. a.C. Secondo
la tradizione romana, sollecitato da Tarquinio il
Superbo, cercò con le armi
di ricondurlo a Roma, donde era stato cacciato.
Per la giovane repubblica
romana non erano tempi facili, la battaglia appena
vinta contro i veienti
non era che il preludio di una grande guerra che
avrebbe opposto la città
dei sette colli ad una lega di popoli etruschi
costituita su sollecitazione
di Tarquinio il Superbo e comandata da un certo
Lars Porsenna, lucomone
della città di Chiusi. Ad incoraggiare gli etruschi
c'erano sicuramente la
particolare situazione politica di Roma, dilaniata dai
conflitti sociali, e
le forti tensioni esistenti tra la stessa e le altre
città del Lazio. L'
avanzata degli Etruschi fu inesorabile e gli stessi
riuscirono a penetrare
nel territorio romano fino ad occupare il Gianicolo,
sulla sponda destra del
Tevere. Ma proprio quando erano pronti ad invadere
l'Urbe attraverso il
ponte Sublicio, l'eroico comportamento di un comandante
romano, Publio
Orazio detto il Coclite (perché cieco da un occhio), evitò la
disfatta;
rimasto solo sulla sponda destra del Tevere riuscì ad impegnare
le
sbigottite truppe etrusche, dando il tempo ai suoi soldati di abbattere
il
ponte. I soldati etruschi erano realmente sorpresi dalla furia e dalle
urla
con cui questo valente guerriero accompagnava i suoi fendenti.
Lanciarono
contro di lui i loro giavellotti, che finirono inesorabilmente
contro il suo
scudo.
Finalmente il ponte crollò alle sue spalle, Roma era
momentaneamente in
salvo, ma il destino del Coclite sembrava segnato avendo
lui perso la sua
unica via di fuga. Ma lui non si perse d'animo, si gettò nel
Tevere con
tutta l'armatura e riuscì ad attraversarlo, rientrando in quella
città a cui
aveva evitato, con il suo eroico gesto, un infausto destino.
Roma gli
dimostrò la sua gratitudine dedicandogli una statua e regalandogli
un
appezzamento di terreno.
Ma il pericolo non era certo finito. Le truppe
di Porsenna non erano
riuscite ad entrare in città ma l'avevano posta in
assedio, tagliandole ogni
possibilità di rifornimento. A Roma già
cominciavano a scarseggiare i viveri
quando un giovane aristocratico romano,
Muzio Cordo, propose al Senato un
piano che prevedeva l'uccisione del
lucomone etrusco. Ottenuta l'
autorizzazione passò immediatamente all'azione:
armato di un pugnale,
penetrò nelle linee nemiche fino a raggiungere
l'accampamento dove Porsenna,
assistito dal suo segretario, era intento a
distribuire la paga ai soldati.
Muzio aspettò che l'operazione finisse e
quando il suo obiettivo rimase solo
lo uccise con un colpo di pugnale. Ma il
suo era stato un tragico scambio di
persona: aveva ucciso il segretario del
re. Catturato dai soldati e portato
al cospetto di Porsenna, l'aristocratico
romano non tentennò neanche un
attimo: "Ero qui per uccidere te. Sono romano
e il mio intento era quello di
liberare la mia patria, ma ho fallito e quindi
punisco quella parte del mio
corpo resasi colpevole di questo imperdonabile
errore". Così dicendo mise la
sua mano destra in un braciere dove ardeva il
fuoco dei sacrifici e non la
tolse fino a che non fu completamente consumata.
Da quel giorno e per l'
eternità questo coraggioso nobile romano avrebbe
assunto il nome di Muzio
Scevola (il mancino).
Porsenna rimase molto
impressionato da questo gesto, che faceva il paio con
il comportamento di
Orazio Coclite, e decise di liberarlo. Fu allora che
Muzio inventò una storia
destinata a cambiare il destino di Roma,
dimostrando di essere anche molto
astuto oltreché coraggioso. "Per
ringraziarti della tua clemenza, voglio
rivelarti che 300 giovani nobili
romani hanno solennemente giurato di
ucciderti. La sorte aveva stabilito che
io fossi il primo e ora sono qui
davanti a te perché ho fallito. Ma prima o
poi qualcuno degli altri 299
riuscirà nell'intento". Questa falsa
rivelazione spaventò molto il principe
etrusco ed anche suo figlio, il meno
convinto di quella spedizione.
Lo
stesso affermò che era molto più importante salvaguardare il futuro del
re di
Chiusi piuttosto che preoccuparsi del destino dei Tarquini. Fu così
che
Porsenna prese la decisione di intavolare trattative di pace con i
romani,
della cui valenza era rimasto particolarmente colpito. Per dare
inizio alle
trattative chiese in cambio degli ostaggi tra i quali si trovava
la giovane
Clelia. Questa riuscì ad organizzare una fuga attraverso il
Tevere con la
quale riportò a Roma, sane e salve, tutte le fanciulle romane.
L'episodio
fece molto arrabbiare Porsenna che minacciò di interrompere le
trattative se
le ragazze non fossero tornate nel suo accampamento. I romani
decisero per la
restituzione delle giovani, un atto particolarmente doloroso
anche per
Publicola considerando che tra le ragazze c'era anche sua figlia
Valeria. Ma
ancora una volta il comportamento dei romani impressionò
Porsenna che
acconsentì alla definitiva liberazione delle giovani che
stavolta tornarono a
Roma accompagnate addirittura dai giovani maschi.
La guerra tra Roma e la
lega etrusca guidata da Porsenna terminava, almeno
secondo i racconti degli
antichi romani in un modo onorevole ed in fondo
indolore. E' probabile che le
cose non andarono proprio così. Pur dando per
assodato che il conflitto si
concluse attraverso una soluzione negoziale è
abbastanza probabile che Roma
dovette pagare un pegno, rinunciando a gran
parte dei territori conquistati
in precedenza ai danni di città etrusche e
rinunciando soprattutto ad ogni
velleità di conquista. In questo senso va
interpretata la "legge del ferro"
imposta da Porsenna, una sorta di disarmo
unilaterale, per cui a Roma si
poteva lavorare il ferro solamente per
costruire attrezzi agricoli. Un altro
segnale in questo senso, potrebbe
essere l'accordo stipulato con Cartagine
(tradizionale alleata degli
etruschi) sempre nel 508 a.c., per il quale Roma
rinunziava ad ogni pretesa
sulle isole della Corsica e della Sardegna. Roma
dovette accettare anche una
sorta di protettorato che prevedeva la presenza
nell'Urbe di un contingente
etrusco. Di contro Porsenna rinunciò al suo
progetto di restaurazione
monarchica e questo mandò su tutte le furie
Tarquinio il Superbo che si
rifugiò nella città di Tuscolo presso suo suocero
Ottavio Mamilio da dove
riuscì nell'intento di coalizzare le altre città
latine (Ariccia, Ardea,
Tivoli, Pomezia, Lanuvio .). Obiettivo di questa
nuova Lega Latina era
quello di combattere contro questa forte presenza
etrusca nel cuore del
Lazio e recuperare molti dei territori che i romani
avevano conquistato nei
244 anni che erano passati dalla sua fondazione. I
rappresentanti della Lega
Latina si riunivano nel tempio di Diana a Nemi e lì
prendevano le più
importanti decisioni.
Sembra proprio che una disastrosa
sconfitta patita dall'esercito etrusco ai
danni della Lega Latina, convinse
Porsenna a tornarsene nella sua città di
Chiusi, abbandonando Roma al suo
destino. La battaglia si svolse presso
Aricia, ed accanto agli eserciti della
Lega Latina si schierarono anche i
greci di Cuma. In questa battaglia
Porsenna perse suo figlio, Arunte, e
questo tragico fatto contribuì a far
maturare la scelta del lucomone di
ritirarsi nella sua città, determinando in
qualche modo il fatale destino
della civiltà etrusca. Secondo la tradizione
etrusca, derivata dalla
leggenda di Mastarna, con il quale dovrebbe essere
quindi identificato egli
invece, occupata Roma, vi avrebbe dominato a lungo.
Per alcuni infine,
Porsenna non sarebbe un nome proprio, ma il titolo
corrispondente a un'alta
carica etrusca.
RAVNTHU
Ravnthu appartenne
a due delle più grandi famiglie tarquiniesi: per nascita
a quella dei
Thefrinai e per matrimonio a quella ancora più prestigiosa e
storica degli
Spurinna. Quando morì fu deposta con gli Spurinna nella regale
Tomba
dell'Orco, dove ancora s'intravede dipinta in una nicchia, sullo
sfondo di un
paesaggio agreste. Indossa una tunica bianca ed è distesa con
meravigliosa
scioltezza in banchetto, accanto al marito Velthur il Grande, l
'eroe che al
comando di due eserciti etruschi partecipò come alleato di
Atene all'assedio
di Siracusa. Le sue quinquereme combatterono
magnificamente nella battaglia
di Lisimelia, ma quella fu l'ultima azione
militare di vasta portata in cui,
nel meridione, apparvero le forze navali
di Tarquinia. Perché, come era stato
scritto inesorabilmente, il tempo
concesso dagli Dei alla nazione etrusca
stava per concludersi e nel silenzio
del cielo sereno era già risuonato lo
squillo terrificante della tromba
sacra che ne annunciava la fine.
Roma
invadeva le terre, atterrava le rocche, devastava i porti, ma
Tarquinia
resisteva e contrattaccava. Ogni volta, a difendere la libertà
della città
santa al nomen etrusco c'era uno Spurinna, strettamente legato
per vincoli
di parentela alla matriarca Ravnthu. Prima scese in campo suo
figlio Velthur
il giovane, poi suo nipote Avle, che i romani chiamavano
Aulus. Avle
Spurinna spodestò dal trono Orgolnius, re di Cere, liberò Arezzo
dalla
rivolta degli schiavi, tolse ai Latini nove città fortificate. Poi
carico di
orgoglio, di rancore e di sete di libertà, affrontò Roma in campo
aperto.
Tanta era l'ira di entrambe le parti che nessuna iniziò lo scontro
con i
giavellotti, gli archi e le altre armi da getto. La battaglia fu
subito
aperta con la spada, corpo a corpo, e la già inaudita violenza
iniziale si
accrebbe durante la lotta.
I tarquiniesi vinsero e il prezzo
che imposero ai vinti fu durissimo: con un
implacabile cerimoniale che si
protrasse per giorni e giorni, in un mare di
sangue che inondò il Foro di
Tarquinia, trecentosette prigionieri romani
furono giustiziati davanti
all'Ara della Regina. Nella seconda battaglia per
la libertà, le truppe
etrusche inferiori per numero furono sconfitte. Questa
volta fu Roma a non
avere pietà. I tarquiniesi vinti furono passati per le
armi la sera stessa,
sul luogo dello scontro. Trecentocinquantotto tra i più
nobili furono invece
trascinati nell'Urbe. Qui, in un crescendo di orrore
che superò quello
dell'eccidio dell'Ara della Regina, furono pubblicamente
massacrati. I ricchi
oliveti, i vigneti, i campi della città vinta furono
bruciati e gli impianti
idraulici insabbiati. Tarquinia non morì subito,
anzi conobbe altri anni di
effimero splendore. Poi, pian piano, uscì dalla
storia.
Mezzo millennio
più tardi, però, un cittadino della Roma Imperiale, che
nonostante l'oblìo
dei molti secoli trascorsi voleva onorare il ricordo dei
suoi antenati
etruschi, fece incidere in una epigrafe, gli "Elogia
Tarquiniensia", le lodi
degli Spurinna e il racconto delle loro grandi
gesta. Tra i nomi degli eroi,
con grandissima dignità e rispetto, volle
immortalare anche quello di
Ravnthu, la donna che orgogliosamente fu al
centro della loro gente e della
loro storia. L'epigrafe degli Elogia è
conservata nel Museo Nazionale
Archeologico di Tarquinia.
SERVIO TULLIO
Secondo la tradizione sesto
re di Roma, che avrebbe regnato dal 578 al 535
a.C. Nato, in base alla
leggenda, a palazzo reale da una prigioniera di
guerra Ocresia, e dal lare
domestico e allevato con ogni cura, dopo che un
prodigio aveva preannuncato
la sua futura grandezza, con l'aiuto della
regina Tanaquilla succedette senza
difflcoltà a Tarquinio Prisco, di cui
aveva sposato la figlia.
Il suo nome
è associato a due fatti: la costituzione serviana e il tempio di
Diana
sull'Aventino. Non pare invece che si possano attribuire a lui le
cosiddette
mura serviane, almeno nello stato in cui sono conservate. Il
carattere
distintivo del suo regno fu il tentativo di fondere nativi ed
etruschi.
Servio venne educato a Roma nel palazzo reale. Sposò una figlia di
Tarquinio.
Nel 579 Tarquinio fu ucciso ad opera di persone legate
all'ambiente dei figli
di Anco Marcio, quarto re di Roma. Tanaquilla,
dapprima nascose al popolo la
morte di Tarquinio, e poi riuscì a far
nominare Servio re di
Roma.
L'imperatore Claudio, autore di un storia dell'Etruria, parlando in
senato a
favore della concessione della cittadinanza romana agli abitanti
della
Gallia Comata, per sottolineare la tradizione romana di
apertura
all'accoglienza degli stranieri, narrò un storia diversa. Secondo
Claudio,
Servio Tullio, con il nome di Mastarna (vedi paragrafo), avrebbe
avuto un
ruolo importante nella storia di Vulci, città etrusca. Amico di
Celio e Aulo
Vibenna, signori di Vulci, avrebbe combattuto al loro fianco
senza fortuna.
Con i resti dell'esercito si sarebbe posto al servizio di
Tarquinio, che per
ricompensa gli avrebbe permesso di abitare con i suoi
compagni sulla collina
a cui diede il nome di Celio, in onore del suo capo.
Questa versione
potrebbe nascondere un fatto più grave: un esercito,
proveniente da Vulci,
avrebbe occupato Roma e ne avrebbe cacciato i Tarquini,
che sarebbero
rientrati alla morte di Servio Tullio, comandante dell'esercito
invasore.
Mastarna è un nome latino etruschizzato, deriva da magister e
significhebbe
qualcosa di analogo a "il condottiero". Il termine servus, non
di origine
indoeuropea e forse etrusco, significava straniero senza diritti,
apolide.
In sostanza il sesto re di Roma sarebbe stato conosciuto con un nome
etrusco
a Roma ed uno latino in Etruria. La costruzione sull'Aventino del
tempio
dedicato a Diana, l'Artemide greca, fu un atto di politica
internazionale.
Il tempio di Artemide ad Efeso era considerato il simbolo
della federazione
delle città della Ionia in Asia Minore. Il culto di Diana e
l'idea di
federazione dovevano essere assai vivi nel mediterraneo occidentale
dopo la
rifondazione, avvenuta nel 540 a.C., della colonia greca di
Marsiglia. La
statua di Diana venne posta nel tempio romano esattamente come
Artemide nel
tempio di Marsiglia. Il tempio sull'Aventino, costruito intorno
al 540 a.C.,
mirava a riunire politicamente e religiosamente Roma, il Lazio e
l'Etruria
meridionale, a somiglianza del sistema federale etrusco dei Dodici
Popoli.
Il tempio venne costruito fuori della città, su di un colle
scarsamente
abitato. Solo nel 465 l'Aventino diverrà zona residenziale con
una legge
ascritta al tribuno della plebe L. Icilio. La posizione esterna
venne
prescelta probabilmente per poter attirare il maggior numero di
persone,
poveri, immigranti, schiavi, ecc. La fondazione del tempio
veniva
festeggiata il 13 agosto.
Servio Tullio eresse i templi gemelli di
Mater Matuta e della dea Fortuna
nel Foro Boario, il mercato in riva al
Tevere. Mater Matuta è una divinità
italica, con tempio principale a Satrico,
città a sud di Roma. La dea della
Fortuna, tradizionale divinità latina, era
simboleggiata da una statua
velata, come quelle degli dei etruschi del Fato.
La fondazione dei templi
gemelli veniva festeggiata l'11 giugno. Il tempio di
Fors Fortuna venne
costruito sull'altra sponda del Tevere, fuori della cinta
cittadina e alle
celebrazioni potevano partecipare gli schiavi.
Servio
Tullio divise la popolazione romana in base al territorio,
indipendentemente
da criteri etnici o di nascita. La cittadinanza venne a
dipendere dal luogo
di residenza. In tal modo molti immigrati, mercanti,
agricoltori etruschi o
di altra provenienza poterono divenire cittadini
romani, fedeli a Roma prima
che alla famiglia o al gruppo etnico. Vennero
definite 4 tribù urbane:
Suburana (il Celio), Palatina, Esquilina, Collina.
Il numero delle tribù
extra-urbane, inizialmente 16, arrivò in seguito a 31.
L'appartenenza ad una
circoscrizione territoriale (tribus), basata sul
domicilio, consentì lo
sviluppo di un catasto per valutare i beni fondiari
ed assegnare i cittadini
ad una classe e fissare il tributum relativo.
Il popolo romano fu diviso in
cinque classi di cittadini/soldati in base al
censo. Ogni classe forniva
all'esercito un certo numero di centurie, gruppi
di cento uomini. Nella prima
classe, la più ricca, si reclutavano 18
centurie di cavalieri e 80 di fanti,
Nella seconda, terza e quarta 20
centurie e nella quinta 30. Un sistema di
tassazione proporzionale al
reddito. Erano esentati dal servizio militare e
dalle spese connesse i
cittadini con un reddito molto basso (i capite censi).
Le centurie
all'interno di ogni classe si distinguevano in quelle formate da
seniores,
la riserva dei cittadini al di sopra di 46 anni, e quelle formate
da
iuniores, i combattenti effettivi. Le centurie di iuniores e di
seniores
erano in numero pari.
La prima classe era armata con elmo, scudo
tondo, corazza e schinieri,
lancia, giavellotto e spada. La seconda classe
era armata come la prima, ma
senza corazza. Portava uno scudo più piccolo e
allungato. La terza classe
aveva elmo e armi offensive. La quarta classe
aveva lancia e giavellotto. La
quinta classe aveva delle fionde.
I diritti
politici erano proporzionali ai servizi che i cittadini
fornivano
all'esercito. Ogni centuria, in quanto unità di combattimento era
una unità
di voto. I capite censi formavano una sola centuria. Due centurie
erano
riservate al genio (carpentieri e fabbri) e votavano con la prima
classe.
Due centurie erano riservate ai musici e votavano con la quarta
classe. In
totale si avevano 193 centurie, con maggioranza assoluta della
prima classe
(80+18). Il sistema eliminava i privilegi della nascita o della
etnia, e nel
contempo evitava gli inconvenienti della tirannia del numero. I
Comizi
Centuriati costituirono l'assemblea dei soldati e si riunirono
all'esterno
dei sacri confini della città. Questa assemblea divenne l'entità
dominante
dopo la caduta della monarchia, sia dal punto di vista legislativo
che
elettorale. Sarebbe stato infine ucciso dal genero, Tarquinio il
Superbo,
d'accordo con la moglie Tullia, la quale non esitò poi a passare con
il
cocchio sul suo corpo nel vicus che dal fatto prese il nome di
sceleratus.
SPURINNA (Gens)
A Tarquinia, nel IV sec. a.C., la famiglia più
potente ed egemone è quella
degli Spurinna (Larth, Velthur, Aulus). I vasti
interessi di questa famiglia
realizza un' alleanza con la grande potenza
ateniese e trascina appresso
numerose città etrusche (si potrebbe pensare ad
una alleanza stipulata o
consacrata al Fanum Voltumnae). In questa alleanza,
nel bene e nel male, il
popolo etrusco è rappresentato da Velthur Spurinna
praetor di Tarquinia e
figlio di Larth Spurinna. La carica di praetor è la
massima magistratura
politico-militare, ma non religiosa, della città stato
(simile forse al
consul romanus), sembra che Velthur l'abbia ricoperta per
ben tre volte. A
lui viene affidato il comando della spedizione di soccorso
ad Atene
impegnata nell'assedio della odiata rivale Siracusa nel 414-413
a.C.. Lo
scontro definitivo tra Tarquinia, ancora potente e alla testa della
lega
delle città etrusche, e Roma, data al 358-351 a.C. e si conclude con
una
tregua di 40 anni allo scadere della quale, dopo un nuovo scontro
armato
conclusosi nel 308 a.C., la tregua viene rinnovata per un uguale
periodo. Di
queste vicende conosciamo la versione romana tramandataci da Tito
Livio, ora
integrata con la versione etrusca fornita da alcuni frammenti
degli elogia
relativi alle gesta di Aulo Spurinna, figlio o nipote del
capostipite
Velthur.
Gli Spurinna ritornano alla ribalta con Giulio
Cesare. Il generale romano
aveva al suo seguito un indovino discendente della
famiglia tarquiniese che
gli aveva consigliato di non recarsi in Senato la
mattina del tragico
eccidio.
TANAQUILLA
Nella splendida Tarquinia
del VII secolo a.C., Tanaquilla era la donna che
più assomigliava alla città.
Nobile, ricchissima, ambiziosa, era ammantata
di una sacralità speciale,
poiché nessuna come lei era esperta nelle
dottrine tagetiche.
Sapeva
leggere i segni attraverso i quali si manifestavano gli Dei e, come
toccata
dal divino, aveva il dono di interpretarli in modo da stornare da
essi tutto
quello che si opponesse alla propria volontà e allontanare ogni
significato
che ostacolasse i suoi progetti, trasformando così il suo
fascino divinatorio
in potere personale al quale tutti finivano per
piegarsi.
Sposò Luchmon,
figlio di una Tarquiniese e del greco Demarato che, fuggito
da Corinto con un
seguito di ceramisti eccellenti e di pittori squisiti, si
era stabilito a
Tarquinia, inondandola di bellezza e di ricchezza. Ma a
Luchmon, proprio
perché figlio di uno straniero sia pure così eminente, non
era permesso dalle
rigorose tradizioni etrusche di percorrere la carriera
politica fino ai
massimi livelli. L'esclusione dai giochi del potere sembrò
intollerabile a
Tanaquilla, che convinse il suo uomo a trasferirsi a Roma,
città ancora
giovane e in cerca di una propria identità dove tutto poteva
accadere a chi
era intelligente, intraprendente e ricco. Fu lei, che
orgogliosa e impavida
sapeva guidare i veloci carri da corsa degli etruschi,
a prendere
personalmente le redini del pilentum a quattro ruote carico di
vasi dipinti e
di preziosità di ogni genere con il quale, lasciando
Tarquinia insieme al suo
compagno, affrontò un destino che avrebbe cambiato
la storia.
Sul
Gianicolo, il primo colle di Roma che si incontra giungendo dall'
Etruria,
accadde un evento prodigioso: un'aquila piombando dal cielo ad ali
spiegate,
ghermì il cappello di Luchmon e dopo aver volato con alti stridi,
glielo
ripose in capo, come se solo per questo fosse venuta. Infine si
rialzò in
volo e sparì nel cielo altissimo. Luchmon ritenne infausto il
presagio e ne
rimase sopraffatto. Tanaquilla, invece abbracciò con riverenza
il marito e
vaticinò la gloria che lo attendeva: l'aquila scesa da altezze
così grandi
era il messaggero dei Numi e aveva tolto e rimesso il berretto
etrusco sulla
sua testa per significare che con lui stava entrando in città
un vero capo
che, voluto dagli dei, avrebbe reso Roma più grande e più
potente.
Infatti
Luchmon che era saggio e generoso ma che soprattutto sapeva
combattere a
cavallo e a piedi più coraggiosamente degli altri, divenne re
con il nome di
Lucio (Luchmon) Tarquinio (proveniente da Tarquinia) Prisco,
il primo dei re
etruschi. In quel tempo, Roma non era una vera città: sui
colli tiberini
esistevano soltanto sparuti gruppi di villaggi e nei luoghi
pianeggianti
regnava ancora la palude. Tarquinio la drenò, trasformò il
terreno
prosciugato in mercato, il futuro Foro Romano e di qui fece partire
un
reticolo di strade lastricate tra le quali la Via Sacra. Poi costruì
gli
edifici che sarebbero rimasti per sempre il nucleo monumentale dell'Urbe
e
gettò le fondamenta del tempio di Giove Capitolino. Infine, trasmise
ai
romani tutti i cerimoniali e i simboli che a Tarquinia significavano
l'
autorità: i littori con i fasci di verghe e la scure, le porpore
ricamate,
le corone d'oro, i troni e gli scettri d'avorio sormontati
dall'aquila e l'
uso di trionfare sul carro aureo a quattro cavalli. Musici,
danzatori,
atleti, artisti tarquiniesi invasero la città e riuscirono ad
incantarla.
Da allora Roma incominciò a rincorrere un sogno: diventare nel
tempo
raffinata come Tarquinia e superarla in grandezza e splendore. Poi,
negarne
con crudeltà la dipendenza e cancellarne per sempre il nome dalla
storia.
TARQUINIO Lucio PRISCO
Secondo la tradizione quinto re di Roma,
che avrebbe regnato dal 616 al 578
a.C. Figlio di Demarato, un esule corinzio
stabilitosi a Tarquinia, insieme
con la moglie Tanaquilla si sarebbe
trasferito a Roma, dove, mutato il nome
Lucumone in Lucio Tarquinio e
accattivatosi il favore di Anco Marcio, alla
sua morte sarebbe riuscito a
farsi eleggere re lasciando in disparte i
giovani figli del sovrano, che
circa 38 anni dopo lo avrebbero fatto
uccidere nel tentativo di riconquistare
il trono.
La tradizione gli attribuì la nomina di cento nuovi senatori,
I'istituzione
dei duoviri sacris 1aciundis e dei ludi magni (romani),
I'introduzione a
Roma di usi e costumi tipicamenie etruschi (in particolare
le insegne
regali, quali lo scettro, la toga purpurea, la sella curalis, i
fasci
littori, e il rito del trionfo) I'intrapresa di importanti opere
pubbliche
(Cloaca massima, circo Massimo, tempio di Giove sul Campidoglio,
ecc.) e
vittoriose campagne contro Sabini e Latini. Figura di indubbia
storicità, al
di là dei particolari leggendari e sebbene sia da alcuni
storici considerato
tutt'uno con Tarquinio il Superbo, è generalmente
identificato con il Cnere
Tarchunies Rumach raffigurato nelle pitture della
tomba Francois di Vulci,
che rispecchiano una tradizione diversa (etrusca) da
quella ufficiale
romana.
TARQUINIO Lucio il SUPERBO
Secondo la
tradizione settimo e ultimo re di Roma, che avrebbe regnato dal
535 al 509
a.C. Figlio o nipote del precedente, si sarebbe impadronito del
trono dopo
aver fatto uccidere Servio Tullio, di cui aveva sposato la figlia
Tullia.
Astuto e senza scrupoli, per ampliare il proprio dominio si servì
più che
delle armi, come contro i Volsci, di spregiudicati stratagemmi, come
quelli
escogitati per impadronirsi di Gabi (l'uccisione dei più influenti
cittadini
cui avrebbe alluso, tagliando i papaveri di un campo) e per
assicurarsi la
supremazia nell'ambito della Lega latina.
Ma con i suoi metodi tirannici e
oppressivi (scarsa considerazione per il
senato, arbitraria amministrazione
della giustizia, mantenimento di una
guardia del corpo, imposizione di
corvées) avrebbe suscitato sia tra i
patrizi sia tra la plebe gravi
malcontenti, sfociati infine in aperta
ribellione per la violenza usata da
suo figlio Sesto alla nobile Lucrezia.
Cacciato quindi da Roma con tutta la
famiglia, avrebbe poi tentato invano di
ritornarvi, con l'aiuto di Porsenna e
dei Latini. La tradizione gli
attribuisce inoltre il compimento della Cloaca
massima e del tempio di Giove
sul Campidoglio. Considerato da alcuni studiosi
moderni personaggio storico,
è da altri ritenuto un semplice sdoppiamento di
Tarquinio Prisco.
TULLIA
Tullia, figlia del sesto re di Roma, era una
vera etrusca. Per sangue,
perché nipote di Tanaquilla e di Tarquinio Prisco;
per diritto, perché sposò
il più superbo dei Tarquinii; per temperamento,
perché ambiziosa e
determinata. Era così sfrenatamente assetata di potere che
viene ricordata
come uno dei personaggi più torvi e crudeli della complessa
saga che
determinò, nel bene e nel male, la vita di Roma ai tempi della
monarchia. In
una cupa atmosfera di complotti di palazzo, uccise il suo primo
marito che
riteneva inadeguato a soddisfare le sue ambizioni. Poi eliminò sua
sorella
che aveva sposato il nobile Tarquinio, detto il Superbo, un giovane
di
grande fascino, di eccezionale intelligenza e di
illimitata
spregiudicatezza. Con Tarquinio e per Tarquinio, di cui diventò
consorte e
complice, Tullia continuò ad ordire sempre nuove congiure,
rivolgendosi
infine contro il proprio padre, Servio Tullio, il re colpevole
di aver
emanato una Costituzione che limitava la signoria unica ed assoluta
tanto
cara alle nobili famiglie etrusche trasferite a Roma. Aveva imposto
anche ai
patrizi i tributi da pagare secondo il censo, perché riteneva
"conveniente e
vantaggioso per la comunità che chi possieda molto, dia molto,
chi poco, dia
poco".
Per questo la Factio Tarquinia, cioè la fazione degli
aristocratici
tarquiniesi che vedevano imbrigliata la loro egemonia su Roma,
ribolliva e
Tullia, impaziente di prendere il potere, ne inaspriva gli animi
con furiosa
perseveranza.
Finalmente il regicidio si compì, nel Vicolo
Ciprio, dove Tarquinio il
Superbo sferrò spietatamente l'attacco da cui il
vecchio Servio Tullio non
uscì vivo.
Tullia, fremente, non poté attendere
chiusa nel suo palazzo l'esito della
congiura, perciò, scansato l'auriga, si
recò sul luogo del massacro guidando
personalmente il suo veloce carro
etrusco. Con questo, come invasata,
calpestò più e più volte, il corpo del
padre. Poi, grondante di sangue
paterno, prima ancora che qualcun altro
parlasse, gridò che Roma ora aveva
un altro re. Finalmente un grande re, suo
marito Tarquinio. Lucio Tarquinio,
detto il Superbo, fu davvero grande: sotto
di lui Roma divenne una potenza
militare imbattibile e schiere di
commercianti, ingegneri, idraulici,
agronomi e di artisti, interi collegi di
musici e danzatori scesero dall'
Etruria e vi portarono arte, progresso e
benessere.
La stella di Tarquinia che, madre di Roma, irradiava civiltà
raffinatezza e
bellezza, non brillò mai così fulgida come in quel magico
tempo.
Ma presto il regno si trasformò in aperta tirannide: il Superbo, che
già
disprezzava la plebe, riempì la città di spie e di provocatori
per
perseguitare chiunque si opponesse al suo arbitrio, non solo i romani
ma
anche i nobili etruschi che gli avevano dato il potere, persino
alcuni
Tarquinii suoi familiari. Proprio da questi fu cacciato per sempre da
Roma.
Nella vicenda che portò alla repentina caduta della monarchia etrusca
che
sembrava incrollabile, giganteggiò ancora una volta una donna. Si
chiamava
Lucrezia.
VELIA
E' nota in tutto il mondo come la
Fanciulla Velca. Il suo squisito ritratto
è considerato uno dei capolavori
dell'arte antica ed è il frammento più
"classico" di tutta la pittura
funeraria etrusca. Si chiamava Velia, Velia
Spurinna. Era nipote di Velthur
il Grande, che aveva comandato due eserciti
etruschi all'assedio di Siracusa
e di Ravnthu Thefrinai: era sorella di
Avle, l'eroe Tarquiniese che affrontò
Roma in campo aperto e la vinse. Sposò
Arnth Velcha, appartenente ad
un'aristocratica famiglia di magistrati di
rango così alto che avevano il
diritto di essere scortati dai littori con i
fasci di verghe e l'ascia
bipenne che, prima a Tarquinia e poi a Roma,
furono il simbolo del massimo
potere. Dei Velcha conosciamo anche l'aspetto
perché molti di essi furono
dipinti nelle pareti della loro grande Tomba
degli Scudi, che prende il nome
dalle armi raffigurate in uno dei suoi
affreschi. Qui tra gli altri, appaiono
anche i genitori di Arnth che,
adagiati sul letto conviviale davanti ad una
tavola imbandita, si scambiano
l'uovo dell'eterna fertilità mentre una
giovane ancella muove per loro un
ventaglio di foglie e di piume. Arnth e suo
fratello Vel, avvolti in caldi
mantelli, stanno invece in piedi vicino ad una
porta. Velia, sposando,
assunse dai Velcha il nome con il quale è nota in
tutto il mondo. Eppure
portava in sè così impresse la grazia e la dignità
degli Spurinna che
questi, straziati dalla sua morte forse precoce, la
vollero dipinta nella
loro Tomba dell'Orco.
Ora, basta scendere i ripidi
scalini di questo regale sepolcro, fare pochi
passi e cercare con gli occhi:
improvvisamente la fanciulla ci appare in un
piccolo affresco sospeso in un
mare grigio e indistinto di colori consunti
dai millenni. Si presenta di
profilo, quel suo famoso profilo netto come una
scultura che, reso con grande
realismo ma stemperato nella dolcezza dei
particolari, ancora suscita stupore
e costituisce l'immagine più nota dell'
iconografia etrusca. La ragazza veste
una morbida tunica e un mantello
bordato di rosso. Indossa gli ornamenti
preziosissimi ma semplici degni del
suo rango: orecchini a grappolo, collane
di ambra, la corona di foglie d'
alloro dorato sulla chioma. I capelli
castani sono in parte trattenuti alla
nuca da una elegante reticella, in
parte ricadono in morbidi boccoli ai lati
del volto. Che è assorto. Il naso è
dritto, di linea greca. Le labbra sono
piene e sensuali ed evocano perduti
contatti d'amore. Perciò si piegano in
un sorriso doloroso quasi che il
richiamare le gioie della vita appena
trascorsa procuri ancora alla ragazza
innamorata un rimpianto insostenibile.
Gli occhi invece guardano lontano e
sembrano già aver trovato nei misteri
della morte i motivi per accettare
senza dolore tutti i distacchi. Come un'
ombra paurosa sta dietro di lei una
creatura dalle ali gigantesche. Ha i
capelli pieni di serpi, le orecchie di
animale e lo sguardo che lampeggia
rosso sull'orribile naso a becco
d'avvoltoio. È Charun, il traghettatore
delle anime nel loro ultimo oscuro
viaggio nell'Ade, che brandisce il
pesante martello con il quale spegneva la
vita dei mortali. Ma questa volta
il Demone Etrusco ha perduto, perché la
fanciulla dei Velcha ancora oggi,
nonostante i millenni, continua ad
incantare e a sedurre, sospesa tra la
vita che non vuole andarsene e la morte
che ancora non vince.
VIRGILIO Publius Maro
Publius Virgilius Maro
nacque a Pietole [allora: Andes, vicino Mantova] nel
70-, suo padre era un
agiato proprietario terriero, fece i primi studi a
Mantova e Cremona, poi a
15 anni a Milano e infine a Roma. Seguì i corsi del
retore Epidius ma li
abbandonò: era goffo e timido, parlava con lentezza e
non sapeva affrontare
il pubblico. Andò a Napoli, alla scuola del filosofo
epicureo Syro: si
interessò di astronomia botanica zoologia medicina
matematica. Scrisse i
primi versi, nel gusto del conterraneo Catullus.
Compose a 28 anni le
Bucoliche. In questo periodo, durante la distribuzione
di terre italiche ai
veterani di Filippi, perse temporaneamente i poderi (ne
parla dolorosamente
nei canti pastorali), poi restituitigli per
interessamento di Asinius Pollio
che governava la Cisalpina, e di Alfenus
Varo. Abitò però sempre tra Napoli e
Roma: qui aveva una casa presso i
giardini di Maecenas,
sull'Esquilino.
Nel 39\37 entrò nel circolo di Maecenate. Sempre discreto e
timoroso, quando
di rado veniva a Roma a trovare i suoi amici poeti Cornelius
Gallus,
Horatius, Varius, Tucca ecc., tutti del circolo di Maecenas, era
già
additato dalla gente, famoso per le "Bucoliche" spesso cantate in teatro
da
attori di professione. In Campania nel 37\30 compose le "Georgiche", poi
si
dedicò tutto all'Eneide. Diversamente da quanto, secondo la tradizione,
era
solito fare (cioè alzarsi presto la mattina, buttar giù molti versi, e
poi
sillabarseli interiormente durante il giorno) fece prima una stesura
in
prosa, divise la trama in dodici libri, poi si mise a comporli uno per
uno
seguendo il suo estro e non la successione dei fatti. Nel 24 ne lesse
tre
canti alla corte davanti all'imperatore Augusto e a sua moglie
Ottavia.
Dopo 11 anni di lavoro, a opera compiuta, non era ancora
soddisfatto: molti
versi provvisori, discordanze tra un libro e l'altro,
voleva visitare i
luoghi teatro d'azione della prima parte. A 56 anni partì
per Atene: qui,
dopo una giornata a Megara sotto il sole infuocato, si
ammalò. Incontrò ad
Atene l'imperatore proveniente dall'oriente, si imbarcò
con lui per mare,
sbarcò a Brindisi. Si dice che sul letto di morte volesse
avere il
manoscritto per distruggerlo, ma non fu accontentato. Spirò qualche
giorno
dopo, nel settembre 19. La sua salma fu trasportata a Napoli e sepolta
sulla
strada di Pozzuoli.
VULCA
Nell'ambito del rinnovamento dei
santuari veienti nel tardo VI sec. va
senz'altro collegato il nome dell'unico
artista etrusco tramandatoci dalle
fonti, Vulca di Vulci, al quale la
tradizione romana assegna origini veienti
e la creazione della statua
acroteriale del tempio di Giove Capitolino a
Roma, all'epoca di Tarquinio il
Superbo. La coincidenza tra questi dati
delle fonti e l'emergere a Veio,
nell'ultimo decennio del VI sec. a.C., di
una scuola di maestri coroplasti
(cioè scultori in terracotta) autori di
grandi statue acroteriali (cioè
destinate ad ornare i vertici dei frontoni
dei templi) per il Santuario di
Portonaccio (ma un'antefissa è nota anche
dal Santuario di Porta Caere) è
tale da autorizzarci a ritenere autentica la
tradizione romana, e ad
attribuire a Vulca e alla sua scuola la paternità
del celebre Apollo di Veio
e delle altre sculture decoranti il tetto del
tempio di
Portonaccio.
Cronologia Etrusca
Secolo X a.C.
Fasi finali della civiltà
del bronzo.
Secolo IX a.C.
Fasi iniziali della civiltà del ferro;
cultura «villanoviana» nei territori
dell'Etruria «propria» e sua espansione
verso l'Emilia-Romagna e il
Salernitano. Formazione delle comunità di
villaggi.
Secolo VIII a.C.
Navigazione degli Etruschi nel Tirreno
meridionale.
Inizio della colonizzazione greca nella penisola
italiana.
775 ca. Stanziamento dei Greci a Pitecusa, nell'isola
d'Iscbia.
753 Fondazione di Roma, secondo la tradizione
varroniana.
750-725 Fondazione di Cuma.
Inizio della colonizzazione greca
in Sicilia.
Sviluppo del «villanoviano in Etruria - differenziazioni sociali
-
fondazione del centri pre-urbani.
710-705 ca. Fondazione di Sibari, di
Crotone e di Taranto. Inizio della
cultura «orientalizzante».
Adozione
dell'alfabeto greco e introduzione della scrittura in Etruria (e
nel
Lazio).
Secolo VII a.C.
Primo iscrizioni etrusche rinvenute a
Tarquinia e a Cere.
Pieno sviluppo della cultura «orientalizzante».
650
ca. Demarato di Corinto si stabilisce a Tarquinia.
Influenze corinzie in
Etruria.
Fase evolutiva dell'orientalizzazione.
Inizio della civiltà
urbana. Fioritura di Cere.
Thalassocrazia ed espansione commerciale delle
città costiere dell'Etruria
meridionale.
616 Inizio della monarchia
etrusca a Roma: regno di Tarquinio Prisco (fino
al 578).
Secolo VI
a.C.
Espansione etrusca nella pianura Padana.
580 ca. Gli Etruschi
sconfitti dai coloni greci nel mare di Lipari.
578 Inizio a Roma del regno di
Servio Tullio (fino al 534).
565 ca. I Greci di Focea fondano Alalie in
Corsica.
540 ca. Coalizione cerite-cartaginese contro i Focei: battaglia del
Mare
Sardo. Controllo etrusco della Corsica.
534 Inizio a Roma del regno
di Tarquinio il Superbo (fino al 5l0).
Fondazione di Marzabotto e di
Felsina.
525 Spedizione fallita degli Etruschi (con Umbri e Dauni) contro
Cuma.
510 Distruzione di Sibari ad opera di Crotone.
Fioritura di Capua
etrusca.
509 Cacciata di Tarquinio il Superbo e fine della monarchia etrusca
a Roma.
Espansione di Chiusi nel Lazio: il re Porsenna a Roma.
505 ca.
L'esercito di Porsenna sconfitto presso Ariccia do Aristodemo di
Cuma e dai
Latini. Gli Etruschi sconfitti dai Galli al Ticino.
Secolo V
a.C.
Thefarie Velianas signore di Cere.
Guerra tra Veio e Roma; strage dei
Fabii al Cremera.
474 Gli Etruschi sconfitti nelle acque di Cuma dai
Siracusani; fine della
thalassocrazia e crisi delle città etrusche
meridionali; sviluppo delle
città dell'Etruria interna e settentrionale;
fioritura dell'Etruria padana e
adriatica.
454-453 Incursioni della flotta
siracusana nel Tirreno settentrionale.
Inizio della pressione sannitica sulla
Campania.
428 Guerra tra Veio e Roma.
426 La città latina di Fidenae,
alleata di Veio, conquistata dai Romani.
423 Capua occupata dai
Sanniti.
Fine del dominio etrusco in Campania.
414-413 Un contingente
etrusco (forse di Tarquinia) partecipa all'assedio
navale ateniese di
Siracusa.
406 Inizio dell'assedio di Veio da parte dei Romani.
Secolo
IV a.C.
396 Veio conquistata e distrutta dai Romani: il suo territorio
incorporato
nello stato romano.
390-386 Scorrerie dei Galli nell'Italia
centrale: Roma saccheggiata e
incendiata.
384 Incursione della flotta
siracusana nel Tirreno e saccheggio del
santuario di Pyrgi. I Siracusani
nell'Adriatico settentrionale.
382 Fondazione delle colonie romano-latine di
Nepi e Sutri. Ascesa di
Tarquinia e sua egemonia sulla Lega etrusca.
358
Tarquinia (con Cere e Faleri) muove guerra a Roma. Detronizzazione del
re di
Cere.
353 Pace separata tra Cere e Roma.
351 Fine della guerra e tregua
quarantennale fra Tarquinia e Roma. Rivolta
«servile» ad Arezzo domata con
l'intervento di Tarquinia. Marzabotto e
Felsina occupate dai Galli.
Spedizioni dei Galli nell'Italia centrale.
314 Navi etrusche in Sicilia in
aiuto di Agatocle di Siracusa contro i
Cartaginesi.
311 Gli Etruschi in
guerra contro Roma. I Romani penetrano nell'Etruria
centrale e
interna.
307 Gli Etruschi costretti alla pace con Roma.
302 Roselle
assediata e occupata dai Romani. Intervento di Roma ad Arezzo in
appoggio
alla famiglia dei Cilnii. Rivolte «servili» a Volterra e a Roselle.
Completa
decadenza di Spina.
Secolo III a.C.
296 Gli Etruschi nella coalizione
«italica» contro Roma.
295 I coalizzati sconfitti dai Romani a Sentino.
Vittorie romane sugli
Etruschi.
284 Rivolta «servile» ad Arezzo.
282
Gli Etruschi definitivamente sconfitti dai Romani al lago Vadimone.
280 Vulci
eVo1sini si arrendono a Roma. Le città etrusche costrette ad
allearsi con
Roma: l'Etruria federata. Prefettura romana a Statonia.
273 Colonie romane a
Cosa e a Pyrgi.
265 Rivolta «servile» a Volsinii.
264 Volsinii conquistata
e distrutta dai Romani. Saccheggio del santuario
della Lega. Volsinii
ricostruita sulle rive del lago di Bolsena. Colonie di
Roma a Castrum Novum,
Alsium e Fregene.
241 Faleri conquistata e distrutta dai Romani.
Trasferimento della città in
altra sede.
225 L'Etruria investita da un
incursione di Galli distrutti dai Romani a
Talamone. Costruzione della via
Clodia.
222 Spedizioni romane contro i Galli, dalle basi etrusche.
Costruzione della
via Flaminia.
217 Annibale, in Etruria, sconfigge i
Romani al Trasimeno.
209 I Romani rinforzano i presidi militari in
Etruria.
205 Le città etrusche contribuiscono alla spedizione africana di
Scipione
contro Cartagine.
Secolo II a.C.
196 Rivolta di schiavi in
Etruria.
189 Fondazione della colonia romana di Bononia.
186 Repressione
del culto «sovversivo» di Dioniso.
183-180 Fondazione di colonie di Roma a
Saturnia, Gradisca e Pisa.
177 Fondazione di colonie di Roma a Luni e a
Lucca. Costruzione della via
Cassia.
Progressiva emancipazione di elementi
servili nell'Etruria settentrionale.
135 Viaggio del tribuno Tiberio Gracco
attraverso l'Etruria.
133-121 Fallimento dei tentativi di riforme sociali dei
Gracchi.
130 L'etrusco Marco Perperna eletto console a
Roma.
Secolo I a. C.
91 Marcia su Roma degli Etruschi contro le
proposte di legge riformatrici
del tribuno Livio Druso. Secessione e guerra
degli alleati italici contro
Roma.
90 Interventi militari romani a
Fiesole, Arezzo, Chiusi e Volsinii.
89 Gli Etruschi ricevono la cittadinanza
romana. Le città etrusche diventano
«municipi» dell'Italia romana.
87 Gli
Etruschi parteggiano per Mario.
82 Repressioni di Silla contro Fiesole,
Arezzo e Volterra e deduzione di
colonie di veterani romani.
78 Effimere
rivolte «popolari» a Fiesole e in altre città.
63 Catilina si rifugia in
Etruria e arruola truppe a Fiesole e ad Arezzo.
49 Gli Etruschi neutrali
nella guerra civile tra Pompeo e Cesare.
40 Perugia, occupata dai seguaci di
Antonio, conquistata e saccheggiata
dalle truppe di Ottaviano.
27
L'etrusco Mecenate tra i consiglieri e i ministri di Augusto.
7 L'Etruria
diventa la regione VII dell'Italia romana.
Bibliografia
"La civiltà
etrusca" Keller 1981, Garzanti
"Etruscologia" M. Pallottino, Hoepli Milano
1968
"Tarquinia" Maria Castaldi, Regione Lazio Ass. Cultura , Quasar
1993
"Origini e Storia Primitiva di Roma" M. Pallottino, Ed. Bompiani
2000
"Guida insolita ai luoghi, ai monumenti e alle curiosità degli
Etruschi"
Chiesa, Facchetti, Newton & Compton Ed. 2002
Schede
didattiche - Museo Archeologico Firenze
La Società
Caratteristiche e
sviluppi della società etrusca
L' organizzazione politica: città-stato e loro
associazioni
Il potere e le forme istituzionali nei singoli stati
Il
popolo
Le classi sociali
La classe sacerdotale
La famiglia
La
donna
Caratteristiche e sviluppi della società
etrusca
Nell'affrontare i problemi dell'organizzazione sociale e politica
degli
Etruschi la nostra prima e fondamentale notazione è che non si può
procedere
ad una pura e semplice rassegna descrittiva dei fenomeni senza
considerarne
l'evoluzione nel tempo che è essenziale per la loro
comprensione. Le notizie
che derivano da accenni occasionali e sommari degli
scrittori greci e latini
si riferiscono pressoche esclusivamente al quadro
delle istituzioni in
alcuni dei loro aspetti esteriori, ed in ogni caso per
lo più ai tempi e
alle circostanze dei rapporti con Roma. Assai più vasta è
la piattaforma
delle testimonianze epigrafiche che a partire dal VII secolo
a.C. e per
tutta la durata della civiltà etrusca ci documentano nomi e
formule
onomastiche: ci danno cioè, per quanto è stato finora scoperto (e
continua
ogni giorno a scoprirsi), una sorta di radiografia della società
etrusca;
mentre le indicazioni biografiche delle iscrizioni funerarie
presentano
titoli di cariche. C'è poi tutto l'insieme dei resti archeologici
che, per
epoche anche più antiche, nella forma e nella distribuzione delle
tombe e
nelle caratteristiche della produzione rivelano consistenza,
rapporti,
sviluppi dei diversi nuclei e strati sociali.
Difficilmente
potremmo sfuggire all'importanza di due opinioni correnti
sulla società
etrusca: cioè in primo luogo che essa si sia costituita
attraverso una
progressione da piccole comunità semplici e indifferenziate a
raggruppamenti
complessi con articolazioni dinamiche e forti emergenze di
poteri e di
ricchezze; in secondo luogo che le oligarchie abbiano esercitato
una funzione
dominante e durevole. Ma occorre intendersi sull'una e
sull'altra asserzione.
È indubbio che nel periodo villanoviano, vale a dire
come sappiamo nella
prima fase della civiltà etrusca, si manifestano ancora
forme di vita proprie
delle culture di villaggio preistoriche (quali si
riflettono con evidenza
nelle figurine e nelle scene dei bronzi di Vulci, di
Bisenzio, di Vetulonia)
e apparenti rapporti egualitari denunciati dalla
relativa uniformità delle
tombe: naturalmente in contrasto con quelli che
saranno i costumi e gli
sfarzi della successiva fase orientalizzante. È però
anche vero che sarebbe
un errore considerare la società villanoviana come
una società primitiva. La
moltitudine e profondità di esperienze culturali
che si sono succedute nel
corso dei tempi che precedono sul suolo d'Italia e
nella stessa terra
d'Etruria, l'inevitabile osmosi con gl'influssi
provenienti dall'evoluto
Mediterraneo orientale, la presenza già
sottolineata di aggregazioni e di
costruzioni evolute nell'età del bronzo
con particolare riguardo al bronzo
finale (Luni sul Mignone, Crostoletto di
Lamone, Frattesina) rivelanti tra
l'altro segni di spicco politico-sociale:
tutti questi elementi ci convincono
che il fenomeno villanoviano deve esser
maturato in un ambito di strutture
già evolute e dinamiche; ne si può
escludere che gli addensamenti e la
somiglianza reciproca delle deposizioni
funerarie, con particolare riguardo
ai pozzetti dei cremati, ubbidiscano ad
esigenze rituali comuni (ma non
mancano segni anche piuttosto evidenti di
distinzioni, per esempio nell'uso
delle urne a capanna rispetto ai cinerari
biconici, nella presenza degli elmi
in funzione di coperchi, delle armi, di
corredi di oggetti di accompagno
piuttosto abbondanti).
Le attività metallurgiche, artigianali, cantieristiche
riflettono
necessariamente una specializzazione del lavoro. Le imprese navali
a largo
raggio già iniziate in questa età presuppongono e comportano
accentramenti
di capacità finanziarie e quindi formazioni di gruppi di
potere. Che poi
tali gruppi, anche appoggiandosi ai possessi terrieri e alla
loro
trasmissione ereditaria, tendano a chiudersi in una cosciente
autorità
egemonica di alcune famiglie privilegiate, cioè in un sistema
oligarchico
gentilizio analogo a quello della Grecia contemporanea, con ogni
possibile
apparato di prestigio e di lusso, questo può considerarsi veramente
il
processo che, determinandosi nel corso dell'VIII secolo, differenzierà
dalla
società villanoviana la società orientalizzante.
È probabile, anche
se non certo, che su questo processo s'innesti la
formazione del sistema
onomastico bimembre, che crediamo di origine etrusca,
e si ritrova anche nel
mondo latino e italico, differenziandosi dalle
formule in uso presso altri
popoli del mondo antico come i Greci, che
indicavano le persone con il
semplice nome e patronimico (Apollonio di
Nestore), o anche con un epiteto di
discendenza (Aiace Telamonio), senza
tuttavia esprimere con evidenza il
concetto di una continuità familiare. La
formula vigente nell'Italia antica è
sistematicamente rappresentata da un
doppio elemento, e cioè dal prenome
personale e dal nome di famiglia o
gentilizio: in questo senso esso è l'unico
sistema onomastico del mondo
antico che anticipi una costumanza affermatasi,
per necessità sociali,
culturali e politiche, nell'ambito della civiltà
moderna. Accanto ai due
elementi principali appaiono spesso il patronimico e
il metronimico (nomi
paterno e materno), talvolta anche i nomi degli avi; al
gentilizio può
aggiungersi, raramente e per lo più tardivamente, un terzo
elemento
onomastico che i Romani dissero cognomen, forse di origine
individuale ma
generalmente adoperato a designare un particolare ramo della
gens. È
indubitato che l'elemento più antico è il prenome o nome individuale,
che fu
in origine un nome singolo. Si ritiene che i gentilizi siano derivati
dal
nome singolo paterno (per intenderci, come il greco Telamonio),
mediante
l'aggiunta di un suffisso aggettivale che spesso è -no: così ad
esempio
Velno da Vel.
Ma poi i gentilizi si formarono anche da nomi di
divinità (Velfino), di
luoghi (Sufrina) o in altro modo talvolta non
definibile. L'originalità del
sistema sta comunque nel fatto che la nuova
formazione resta definitivamente
fissata per tutti i membri della famiglia e
loro discendenti. Si discute se
l'apparizione e la diffusione dei gentilizi
siano avvenute nel corso del VII
secolo, o già prima, come è possibile. Il
numero delle gentes conosciute è
grandissimo, possiamo dire illimitato;
constatazione interessante che
esclude l'ipotesi di una contrapposizione tra
un ristretta oligarchia dei
membri delle gentes ed una massa di popolazione
estranea al sistema
gentilizio. A dire il vero si ha l'impressione che in
origine tutti i membri
delle nascenti comunità urbane etrusche, in quanto
cittadini liberi, fossero
inquadrati nell'ambito del sistema "gentilizio"; ma
non nel senso di una
loro aggregazione entro i limiti di pochi e vasti
organismi familiari, bensì
nel senso dell'appartenenza a singoli e numerosi
ceppi familiari ciascuno
dei quali era contraddistinto da un particolare nome
gentilizio. Si può
pensare a qualche cosa di simile a quello che accade nel
mondo moderno verso
la fine del medioevo, quando nascono i nomi di famiglia,
e tutta la
popolazione, dalle classi elevate alle più umili, finirà con
l'adottare un
unico sistema onomastico. È naturalmente possibile - quantunque
non
provato - che nell'Etruria arcaica esistessero gentes patrizie e
plebee,
come a Roma durante la repubblica. La vera e propria classe inferiore
è
rappresentata dai servi, dagli attori e dai giocolieri, dagli
stranieri,
ecc., che nei monumenti appaiono contraddistinti soltanto da un
nome
personaIe e sono quindi estranei all'organizzazione gentilizia. Se
una
società di liberi, suddivisa in piccoli e numerosi aggregati
familiari,
poteva conciliarsi con una costituzione monarchica di tipo
arcaicaca, ciò
parrebbe più difficile per lo stato oligarchico attestato
dagli accenni
degli scrittori antichi per una fase posteriore della civiltà
etrusca.
Tuttavia i monumenti epigrafici continuano a presentarci famiglie -
di cui
per questo periodo più tardo si conoscono ormai complesse genealogie -
assai
numerose in ciascuna delle città etrusche, e sulla base di
un'apparente
parità sociale. Ma è possibile anche intravvedere la formazione
di aggregati
familiari più vasti, contraddistinti da un sologentilizio, ma
con numerose
ramificazioni anche fuori dell'ambito della città originaria. E'
il
manifestarsi della gens nel senso più propriamente noto nel mondo romano;
e
non di rado ai gentilizi si aggiungono cognomi adottati per distinguere
i
diversi rami della famiglia. Alle piccole tombe strettamente familiari
del
periodo arcaico si sostituiscono i grandiosi ipogei gentilizi con
numerose
deposizioni. Si può osservare un più frequente ricorrere di
matrimoni tra
membri di alcune gentes, che sono poi quegli stessi che più di
frequente
rivestono cariche politiche e sacerdotali. Ciò si spiega
abbastanza
logicamente supponendo che nell'ambito dell'originario sistema
sociale
gentilizio si sia venuta ulteriormente determinando una netta
prevalenza di
alcune gentes maggiori che avrebbero costituito la oligarchia
dominante. Di
ciò si è già fatto cenno nella trattazione storica. È evidente
che di quelle
oligarchie sono esponenti, ad esempio, a Tarquinia gli Spurina
o i Velcha,
come ad Arezzo i Cilnii, o a Volterra i Ceicna (Cecina) dai
numerosi rami.
Più difficile è stabilire la posizione delle gentes minori o
plebee
nell'ambito dello stato oligarchico; come anche determinare
le
caratteristiche delle classi proletarie e servili. Sono
abbastanza
frequenti, specialmente nell'Etruria settentrionale, iscrizioni
funerarie
appartenenti a personaggi designati con i termini lautni, etera,
lautneteri;
in alcuni casi essi recano il solo prenome, segno di condizione
servile, o
conservano un nome di origine straniera. La parola lautni deriva
da lautn
"famiglia" e significa letteralmente "familiare"; ma è adoperata
come
corrispondente del latino libertus. Quanto ad etera non si sa
precisamente
il valore del termine, che qualcuno traduce come
«servo».
Un'affermazione politico-sociale delle classi inferiori è ricordata
dalla
tradizione storica per Arezzo e per Volsinii dove avvenne nella prima
metà
del III secolo a.C. una vera e propria rivoluzione proletaria con
la
conquista del potere e la momentanea abolizione delle differenze di
casta
(per esempio il divieto di connubio) con l'aristocrazia dominante.
Resta
tuttavia dubbio se e fino a qual punto tali lotte sociali
possano
interpretarsi anche come un urto tra genti maggiori e minori nell'
ambito
del sistema gentilizio, analogo alla lotta tra patrizi e plebei nella
Roma
repubblicana, ovvero debbano intendersi esclusivamente come una
affermazione
rivoluzionaria di elementi servili estranei alle gentes. D'altra
parte, come
è stato recentemente dimostrato da H. Rix, nelle città
dell'Etruria
settentrionale ebbe luogo, al più tardi nel II secolo a.C., una
generale
ascesa pacifica di elementi servili, i cui nomi individuali (come
Cae, Tite,
Vipi) divennero nomi gentilizi. Trattando della famiglia e del
sistema
onomastico degli Etruschi, si può fare un riferimento al
cosiddetto
"matriarcato" degli Etruschi. È questa soltanto una leggenda
erudita, nata
dal confronto fra usanze dell'Etruria e dell' Asia Minore,
quali vengono
riportate da Erodoto (I, 73), e alimentata dalle notizie degli
scrittori
antichi sulla libertà della donna etrusca. Il fatto che i fanciulli
lidii
fossero chiamati con il nome della madre e non con quello del padre è
stato
posto a confronto con l'uso etrusco - attestato nelle iscrizioni -
del
metronimico. Ma in realtà nelle iscrizioni etrusche l'elemento prevalente
è
il patronimico, anche se in molti epitafi sono riportati il gentilizio
e
talvolta il prenome della madre.
Non vi è dubbio che la donna abbia
nella società etrusca un posto
particolarmente elevato e certamente diverso
da quello della donna greca di
età classica. La partecipazione ai banchetti
con gli uomini è indizio
esterno di una parità sociale, che ricollega anche
per questo aspetto la
società degli antichi Etruschi a costumi propri del
mondo occidentale e
moderno. Un ultimissimo cenno a quel tipo di istituzione
sociale che,
parzialmente su modelli ellenici, ebbe particolare importanza
nel mondo
italico e specialmente romano: ci riferiamo alle associazioni di
giovani,
alla iuventus. È possibile e probabile che ciò esistesse anche nel
mondo
etrusco. Già in età arcaica appare raffigurato il giuoco della
Troia
(Truia), consistente in abili evoluzioni di cavalieri connesse con
la
iuventus; e a questa si allude forse con la parola huzrnatre derivata
dalla
radice hus, huz- che esprime il concetto di "giovane,
gioventù".
L' organizzazione politica: città-stato e loro
associazioni
All'epoca dei contatti dell'Etruria con Roma la vita
politica della nazione
etrusca poggia essenzialmente sopra un sistema di
piccoli stati indipendenti
facenti capo a città preminenti per grandezza e
per ricchezza. Non sappiamo
quali fossero le effettive condizioni del periodo
arcaico; ma la coesistenza
di diversi centri di grande importanza a poca
distanza l'uno dall'altro,
come Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, con propri
poteri, caratteristiche e
costumanze, sembra effettivamente ispirarsi al
sistema della città-stato
proprio delle contemporanee colonie greche e
fenicie d'occidente. Questa
struttura politica - estesa anche nel Lazio
etruschizzato - è designata
tecnicamente in latino con il termine populus, di
probabile origine euusca,
che appare, in un certo senso, sinonimo di civitas,
dell'osco-umbro touto,
toto. In etrusco il concetto è reso, probabilmente con
diverse sfumature,
dai termini spur-, mex e forse anche tufi (dall'italico).
Il nome ufficiale
dei populi è quello degli abitatori stessi delle città:
Veienti,
Tarquiniesi, Ceretani, Chiusini, ecc.
È probabile che con il
procedere del tempo le singole città sovrane si siano
aggregate un territorio
più o meno vasto, sottomet- tendo altre città
rivali, come vediamo in atto
nella più antica storia di Roma; ma non è
escluso che alcune delle città
conquistate possano aver conservato una
parziale autonomia o siano state
legate da rapporti di alleanza con i
dominatori (ciò che potrebbe spiegare
l'esistenza di centri di media
importanza specialmente nell'Etruria interna,
come Nepi, Sutri, Blera,
Tuscania, Statonia, Sovana, ecc., nel territorio
delle maggiori città, cioè
di Veio, Tarquinia, Vulci). Si consideri inoltre
la possibilità di vincoli
di dipendenza delle colonie dalle città di origine:
per esempio nella
espansione etrusca in Campania e verso settentrione. Ma in
realtà, per
quanto ci consta, il principio dell'autonomia e del frammentismo
politico
deve aver prevalso anche nella costituzione dei domini
etruschidell'Italia
meridionale e settentrionale.
Il centro della vita
politica e culturale dell'Etruria è dunque da ricercare
nelle grandi città
dominanti, di cui possediamo gli splendidi resti, e che
il computo
tradizionale calcola in numero di dodici (solo in età romana si
parla di
quindici popoli). Quali sono queste città? Certamente all'epoca
della
conquista romana si contano tra di esse Caere, Tarquinia, Vulci,
Roselle,
Vetulonia, Populonia, Volsinii, Chiusi, Perugia, Cortona, Arezzo,
Fiesole,
Volterra; Veio era stata annessa al territorio romano già
dall'inizio del IV
secolo, Alcuni centri minori dovevano essere ancora
autonomi nel IV e III
secolo a.C., come parrebbe risultare da monete con i
nomi di Peithesa,
Echetia e di altre città non meglio identificate. Nuclei
abitati fiorenti in
età arcaica, quali Acquarossa, Bisenzio, Marsiliana d'
Albegna (Caletra?) e
la stessa Vetulonia, decadono più tardi: altre città si
svilupperanno
soltanto alla fine della civiltà etrusca, sotto il dominio di
Roma, quali
Siena, Firenze, Pisa, Luni.
Una fase anteriore a quella dell'organizzazione
urbana non è documentabile
storicamente: ne possiamo quindi conoscere il
sistema politico e i reciproci
rapporti dei villaggi protostorici dei quali
restano tracce nel territorio
etrusco. Accenni indiretti di scrittori e
l'analogia con la costituzione
primitiva di Roma potrebbero far supporre che
la popolazione delle città
fosse ripartita in tribù e in curie. Per il resto,
cioè per il rapporto fra
queste ripartizioni interne e i nuclei territoriali
di aggregazione dai
quali sarebbero sorte le città stesse, nonche i centri
minori dipendenti,
regna almeno per ora l'oscurità più completa.
Ogni
città-stato o città capitale (caput) di uno stato costituisce un
mondo
politicamente ed entro certi limiti culturalmente a se stante (si pensi
ad
esempio allaspecializzazione dei prodotti artistici, per cui tra le
altre
Tarquinia eccelse soprattutto per la pittura funeraria, Caere
per
l'imitazione dell'architettura interna delle tombe, Vulci per i bronzi e
per
la scultura, e così di seguito). Gestione interna, commerci,
eventuali
imprese navali dovettero essere autonome come nelle poleis della
Grecia
arcaica e classica. Le notizie delle fonti storiche ci persuadono a
ritenere
che anche la politica estera fosse decisa con sostanziale autonomia
da
ciascuna città secondo i propri interessi. Tuttavia esistono altri
indizi,
sempre delle fonti, che ci indirizzano verso il ricordo di un tipo
di
associazione delle città etrusche per la quale si è usato modernamente
il
termine di lega o di federazione. Dobbiamo chiederci quale sia
l'effettiva
natura di quest'ultima istituzione, che ha dato luogo a
discussioni tra gli
studiosi. L 'esistenza di forme associative tra diverse
comunità autonome è
un fatto ben noto nel mondo antico, in Grecia come in
Italia, sia pure con
diverse caratteristiche a seconda dei tempi e dei
luoghi; ne può quindi
destare meraviglia. Per l'Etruria gli scrittori antichi
non usano, a quanto
ci consta, un termine specifico per indicare
l'associazione stessa; ma
parlano dei duodecim populi, dei duodecim (o
quindecim) populi Etruriae o
semplicemente di Etruria, di omnis
Etruria.
Il numero dodici delle grandi città dell'Etruria propria - alle
quali
facevano riscontro altrettante della Etruria padana e della Campania -
ha
probabilmente un carattere rituale: come in altri casi analoghi del
mondo
antico, e forse, ma non necessariamente, per analogia con le dodici
città
della lega ionica (considerati gli antichi legami culturali fra Etruria
e
lonia asiatica). Che si tratti per altro non soltanto di uno schema
ideale,
ma di una reale istituzione politica, può dedursi da quei
riferimenti,
principalmente di Livio (IV, 23; V, 1; X, 16, ecc.), nei quali
si accenna ad
una adunanza di consultazione annuale o comunque periodica
(concilium)
tenuta dagli stati etruschi e dai loro capi (principes) al Fanum
Voltumnae.
Ha giustamente posto in rilievo L. Pareti che simili testimonianze
non sono
sufficienti a provare il carattere continuativo ed un forte
potere
soprastatale del supposto istituto federale etrusco. Accertata
l'esistenza
di feste e di giochi annuali panetruschi nel santuario di
Voltumna - non
altrimenti da ciò che sappiamo relativamente al mondo greco
per Efeso,
Olimpia, Delfi, Corinto -, si potrebbe infatti supporre che
soltanto
circostanze politiche di carattere eccezionale, come la minaccia di
Roma,
possano avere indotto i rappresentanti dei diversi stati etruschi
a
concertarsi nel santuario nazionale e financo a coalizzarsi in una
lega
politica e militare. Ma esistono d'altra parte riferimenti che
paiono
indicare una certa continuità dell'istituto ed una relativa
subordinazione
ad esso dei singoli stati: ad esempio il passo di Servio (ad
Aen., VIII,
475), nel quale è detto che l'Etruria aveva dodici lucumoni, o
re, dei quali
uno era a capo degli altri, o gli accenni di Livio (l, 8, 2; V,
1) alla
elezione di un re da parte dei dodici popoli, ciascuno dei quali
forniva un
littore per i fasci, e più tardi alla elezione di un sacerdote al
Fanum
Voltumnae in occasione delle adunanze degli stati etruschi. In
sostanza
dall'attendibilità delle notizie contenute in questi riferimenti
dipende il
nostro giudizio sulla lega etrusca.
È interessante notare che
in due delle testimonianze si parla di re: ci si
riferisce cioè
preferibilmente ad epoca arcaica. Ma in altro passo di Livio
si parla di un
capoelettivo della comunità degli Etruschi, il quale alla
fine del V secolo
(cioè all'epoca del conflitto tra Veio e Roma) era un
personaggio designato
con il titolo di sacerdos, e perciò dotato di poteri
eminentemente religiosi
(o ridotti alla sola sfera religiosa). In alcune
iscrizioni latine di età
imperiale ricorre il titolo praetor Etruriae che
appare anche nella forma
praetor Etruriae XV populorum, cioè della comunità
nazionale etrusca che in
età romana pare accresciuta di tre città. Ora fra
le cariche esercitate da
personaggi etruschi e ricordate da iscrizioni in
etrusco conosciamo il titolo
zilat? mexl rasnal. Dal celebre passo di
Dionisio (I, 30, 3) in cui gli
Etruschi sono designati con il nome nazionale
di Rasenna sappiamo che la
parola rasna dovrebbe significare «etrusco,
Etruria». D'altra parte la
magistratura indicata con la parola zilat?, che
pare sia la più elevata fra
le cariche delle repubbliche etrusche, equivale
assai probabilmente al
praetor dei Romani. Per mexl si può pensare ad un
genitivo della parola mex
che ricorre nella iscrizione della lamina d'oro
lunga di Pyrgi, e forse
tradurre "dei populi". Risulterebbe così una
corrispondenza del titolo zilat?
mexl rasnal con praetor Etruriae
(populorum). Si può discutere se questa
carica si identifichi con la suprema
presidenza elettiva dei populi etruschi,
o con una magistratura di
rappresentanza dei singoli populi nel concilio
federale, come quella dei
principes ricordati da Livio. La prima ipotesi
sembra oggi la più probabile.
Se le notizie relative alla supremazia di uno
degli antichi sovrani delle
città etrusche non sono del tutto prive di
fondamento, si potrebbe
arrischiare l'ipotesi che una forma originaria di
legame unitario esistesse
fra gli Etruschi del sud all'inizio dei tempi
storici, sotto la egemonia di
una o dell'altra città. Più tardi questa antica
unità avrebbe assunto il
carattere di associazione religiosa, commerciale e
politica, con feste e
adunanze nazionali nel santuario di Voltumna presso
Volsinii. La elezione di
un supremo magistrato annuale è forse il ricordo
dell'alta sovranità di un
capo sugli altri. Sappiamo da Livio che verso la
fine del V secolo il re di
Veio poneva la sua candidatura alla elezione - il
che conferma
implicitamente l'importanza della magistratura nazionale -, ma
ne usciva
battuto.
Il potere e le forme istituzionali
nei singoli stati
Le condizioni di fatto esistenti nelle città etrusche
tra il IV e il II
secolo a.C., hanno influito sulla generale interpretazione
delle istituzioni
politiche e sociali etrusche quale risulta dai riferimenti
degli scrittori
antichi. Le città appaiono dominate da un' oligarchia
gentilizia (solo
sporadicamente e per breve tempo soppiantata da altre classi
sociali), con
magistrati genericamente designati dalle fonti romane come
principes. I
monumenti confermano in parte la tradizione pre- sentandoci
grandiose e
ricche tombe gentilizie con numerose deposizioni, iscrizioni
riferibili a
membri di alcune famiglie strettamente imparentate e soprattutto
epigrafi di
personaggi che portano titoli di cariche temporanee e
probabilmente
collegiali, secondo un sistema altrimenti noto nelle
costituzioni delle
città-stati del mondo antico. Ma tali condizioni non
rispecchiano
evidentemente il quadro della vita politica etrusca nei secoli
più antichi
della storia nazionale.
Molte fonti ci parlano dell'esistenza
di re nelle città etrusche. Il termine
lucumone (lat. lucumo, lucmo, in
etrusco probabilmente lauxume, lauxme,
luxume) ricorre talvolta quale prenome
personale di personaggi etruschi,
come nel caso del re di Roma Tarquinio
Prisco; ma è generalmente usato come
nome comune per designare i capi
etruschi. Il commentatore di Virgilio,
Servio, in un caso chiama lucumoni i
magistrati preposti alle curie della
città di Mantova (ad Aen, X, 202),
altrove identifica esplicitamente i
lucumoni con i sovrani della città (ad
Aen, II, 278; VIII, 65, 465). E'
accertato che i lucumoni equivalessero ai
principes, designando ambedue i
termini null'altro che i capi delle famiglie
patrizie. È però probabile che
il termine principes indichi, più che una
condizione sociale, le
magistrature dello stato repubblicano, e forse anche
magistrature supreme;
tutto porta a credere che il titolo lucumone designi i
re etruschi di età
arcaica, secondo l'esplicita e ripetuta affermazione di
Servio.
Non sembra quindi necessario ricercare, con S.P. Cortsen, la parola
etrusca
per re nel titolo * pursna, * purtsna, purfne, che sarebbe stato
considerato
come un nome proprio nel caso del re di Chiusi Porsenna. È
d'altro canto
probabile che, analogamente a quanto accadde a Roma per il
termine rex
(sacrificulus), il titolo degli antichi monarchi non sia stato
abolito con
la trasformazione dello stato in una repubblica aristocratica e
si sia
conservato accanto alle nuove magistrature, sostanzialmente svuotato
del suo
contenuto politico e volto a funzioni religiose. Nel testo sacro
della
Mummia di Zagabria si parla di cerimonie compiute lauxumneti,
«nel
lauxumna», cioè probabilmente la residenza del lauxume, il lucumone:
qualche
cosa di analogo alla Regia, residenza dei Pontefici, in Roma. Infine
il capo
elettivo del Fanum Voltumnae, designato da Livio come sacerdote, non
sarà
forse stato in origine altro che il re eletto dai dodici popoli e
il
lucumone più potente ricordato da Servio: sia pure con funzioni sminuite
e
trasformate dal mutare dei tempi e delle concezioni politiche.
Quale
carattere ebbe la monarchia etrusca primitiva? purtroppo ci mancano
gli
elementi per determinarlo e soltanto l'analogia con quel poco di
storicamente
certo che ci è noto sulla monarchia romana consente qualche
supposizione. Il
re doveva avere il potere giudiziario supremo che
esercitava, a detta di
Macrobio (Saturn., l, 15, 13), ogni otto giorni in
udienze pubbliche. Doveva
essere il capo dell'esercito ed anche della
religione dello stato. Meglio
informati siamo sopra alcuni costumi
cerimoniali e attributi esteriori della
monarchia, che furono ereditati da
Roma e considerati dagli scrittori antichi
come di origine specificamente
etrusca: così la corona d'oro, lo scettro, la
toga palmata, il trono (sella
curulis), l'accompagno dei fasci e altre
insegne del potere, la presenza di
uno scriba che registra gli atti sovrani;
così forse anche la cerimonia del
trionfo.
Particolarmente interessante è
il problema delle origini del fascio
littorio. La sua origine etrusca è
sostenuta esplicitamente dagli scrittori
di età imperiale, come Silio Italico
(Puniche, VIII, 483 sgg.) e Floro (l,
1, 5). La più antica rappresentazione
di fasci senza scure s'incontra in un
rilievo chiusino del Museo di Palermo
che si data nella prima metà del V
secolo a.C.: cade quindi l'ipotesi che i
littori e i fasci al seguito dei
magistrati etruschi nelle città federate
siano una imitazione delle
costumanze di Roma. È probabile che in origine il
fascio fosse soltanto uno
e che il moltiplicarsi del numero dei littori sia
dovuto all'estendersi
della sovranità su più territori o al moltiplicarsi dei
per- sonaggi
detentori del potere supremo. Al simbolo materiale dei fasci
corrisponde una
capacità politica e religiosa, che i Romani designarono con
il nome di
imperium. A riprova del valore dell'ascia come simbolo del potere
sovrano
sta il fatto che soltanto l' imperium maius ed alcune
particolari
circostanze davano diritto al magistrato romano dì inalberare i
fasci con la
scure. L' imperium, distinguendosi da una generica potestas, è
la pienezza
dei poteri giudiziari e militari: esso è in sostanza la sovranità
degli
antichi re di Roma trasmessasi ai magistrati repubblicani. Il concetto
di
imperium, con le sue sfumature religiose, deriva probabilmente
dalla
monarchia etrusca.
Nello studio del passaggio dallo stato monarchico
allo stato repubblicano in
Etruria - passaggio avvenuto tra il VI e il IV
secolo a.C. - va tenuta
presente la portata internazionale del fenomeno che
investe, con linee
sostanzialmente analoghe, la storia istituzionale dei
Greci, dei Fenici, dei
Latini, degli Etruschi, e che dimostra, per certi
aspetti sostanziali della
vita pubblica, la profonda unità della civiltà
mediterranea anche in epoca
anteriore all'ellenismo e alla romanità.
Dalla
monarchia primitiva a carattere religioso si passa allo stato
oligarchico con
magistrature elettive, collegiali e temporanee: talvolta il
processo si
affianca o si sviluppa con affermazioni di potere personale
(tirannie) e con
soluzioni democratiche. In molte città greche la
trasformazione è già in atto
in epoca protostorica, durante e dopo l'età
micenea; mentre altre città come
Sparta conservano, almeno formalmente,
l'istituto monarchico fino alla fine
della loro storia. Nel mondo greco
d'occidente le nuove soluzioni sembrano
già in gran parte affermate sin
dagli inizi della colonizzazione; mentre a
Roma il mutamento ha luogo nel VI
secolo. Le molte teorie proposte per
spiegare il passaggio dalla monarchia
romana alle magistrature repubblicane
si orientano da un lato verso il
concetto dell'evoluzione continua e
necessaria, da un altro lato verso
l'idea di una innovazione improvvisa.
Quest'ultima potrebbe effettivamente
ricollegarsi all'imitazione di istituti
stranieri (greci, latini o anche
etruschi?). È stata inoltre affacciata,
essenzialmente da S. Mazzarino, la
proposta che agli inizi dello stato
repubblicano, prima dell'affermarsi
delle magistrature collegiali sia da
ricostruire una fase di magistrature
singole o preminenti, a carattere
prevalentemente militare, quasi dittature
stabili, sostituitesi alla regalità
arcaica. In tal senso sono state
interpretate tradizioni relative a titoli
come, in Roma, quelli del magister
populi o del praetor maximus; e si è anche
creduto di poter riconoscere un
simile tipo di potere nel personaggio etrusco
Mastarna, il cui nome Macstrna
(senza prenome nella tomba Franr;ois di Vulci)
sarebbe null'altro che un
titolo derivato dal latino magister: tanto più che
Mastarna era stato da
alcune fonti identificato con il re di Roma Servio
Tullio, alle cui riforme
costituzionali si faceva risalire l'origine stessa
della repubblica (Livio,
I, 60). L'esistenza di forti poteri personali nelle
città etrusche e latine
tra la fine del VI e il principio del V secolo
s'inquadrerebbe nel diffuso
costume delle tirannie che caratterizza le città
greche d'occidente in quel
medesimo periodo (si pensi ad esempio ad
Aristodemo di Cuma), per una sorta
di mimetismo politico. Le laminette d'oro
in scritte in etrusco e in punico
trovate a Pyrgi recano un nuovo prezioso
contributo alla discussione di
questo problema, dato che esse ci presentano
la figura del dedicante
Thefarie Velianas, designato in punico come "re di
Caere" o "regnante su
Caere" (ma in etrusco probabilmente già come zilac,
cioè praetor), con tutte
le caratteristiche di un capo di stato investito di
potere unico e
personale.
Oltre a ciò va detto che probabilmente non
esiste in Etruria una netta
contrapposizione cronologica tra fase monarchica
e fase repubblicana anche
per un'altra ragione, e cioè perche la monarchia,
di nome oltre che di fatto
(se le fonti non mentono), sopravvive o riaffiora
almeno in due casi
posteriori a quella fase tardo-arcaica nella quale
dovrebbero collocarsi i
mutamenti istituzionali più o meno nello stesso
periodo delle origini della
repubblica romana. Ci riferiamo alla creazione di
un re a Veio sul finire
del V secolo e alla menzione di un "redei Ceriti"
nell'elogium di Aulo
Spurinna in un contesto cronologico che si riporta verso
la metà del IV
secolo. Nell'uno come nell'altro caso c'è una palese ostilità
di altri stati
etruschi, che farebbe pensare a fatti eccezionali in un mondo
di ormai
prevalenti assuefazioni istituzionali repubblicane.
Il sistema
che doveva essersi generalizzato negli ultimi secoli di vita
autonoma delle
città etrusche è, come si è detto, quello delle repubbliche
oligarchiche, per
la cui conoscenza abbiamo purtroppo soltanto pochi indizi
diretti offerti
dalle iscrizioni e qualche cenno delle fonti storiche,
oltreche l'analogia
con Roma. Possiamo dedurne l'esistenza di un senato
formato dai capi delle
gentes; probabilmente di assemblee popolari; di una
magistratura suprema
temporanea, unica o collegiale; di altre magistrature
collegiali a carattere
politico e religioso. In ogni caso si avverte la
tendenza a spezzettare il
potere, a sminuirlo e a porlo sotto un costante
reciproco controllo, allo
scopo di evitare l'affermarsi del potere
personale. Questo irrigidimento
delle istituzioni oligarchiche sembra più
accentuato in Etruria che a Roma.
Una differenza traspare anche nei riguardi
dei movimenti di rivendicazione
pubblica delle classi inferiori, che in
Etruria non hanno generalmente la
possibilità di inquadrarsi, come a Roma,
in uno sviluppo progressivo delle
istituzioni verso l'avvento al potere
della classe plebea; ma si risolvono, a
Volsinii, ad Arezzo e forse altrove,
in parentesi di anarchia popolare. Ciò
non esclude tuttavia un progressivo
assorbimento di elementi extragentilizi
nel sistema gentilizio specialmente
nell'Etruria settentrionale intorno al II
secolo a.C., come si è già
accennato: con loro probabile conseguente accesso
almeno ad alcune delle
cariche pubbliche.
I titoli delle magistrature
etrusche, nelle loro forme originarie, ci sono
noti dai cursus honorum (cioè
dalle elencazioni delle carriere) delle
iscrizioni funerarie, alcune delle
quali dovevano esser redatte nella forma
di veri e propri elogio poetici del
defunto, come ad esempio le iscrizioni
romane degli Scipioni. Non è facile
tuttavia interpretare la natura delle
cariche, i loro reciproci rapporti, la
differenza di dignità e la
corrispondenza con le magistrature del mondo
latino ed italico. Il titolo
più frequente è quello tratto dalla radice zii-,
di origine ancora oscura ed
imprecisata (ma già presente a Caere almeno
all'inizio del V secolo), nelle
forme zii, zil(a)c o zilx, zilat. Alle forme
nominali corrisponde un verbo
zilx- o zilax- che significa «essere zilc o
zilat». Già sappiamo che zilat
corrisponde in qualche caso al titolo romano
praetor. È indubbio che si
tratta di un'alta carica, forse la più alta dello
stato; ma spesso il titolo
appare accompagnato da specificazioni (zilat o
zilx parxis; zilc marunuxva;
zilx cexanen) che possono indicare una
specializzazione di funzioni (cfr. il
latino praetor peregrinus).
Un'altra
carica importante, che taluno considera il più alto grado di un
supposto
collegio di zilat, è indicata dalla radice purt-, che non si è
mancato di
ricollegare con il titolo di probabile origine preellenica noto
anche nelle
città greche dell'occidente e forse da queste trasmesso alle
città etrusche.
Frequente è inoltre il titolo maru, marniu, marunux, i cui
richiami sacrali
sono resi evidenti dalla sua connessione cori il titolo
sacerdotale cepen e
da specificazioni, che contengono i nomi degli dèi Paxa
(Bacco) e Cafa.
Appare anche in Umbria con il collegio dei marones (e fu
cognomen del
mantovano Virgilio!). Si è supposto che corrisponda al latino
aedilis. Altre
cariche amministrative o militari sono espresse dai termini
camfi,
macstrev(c) (dal latino magister), ecc.
Trattando degli ordinamenti dello
stato etrusco un ultimo cenno dovrebbe
esser fatto alle leggi e al diritto.
Ma purtroppo di questa materia noi
possediamo nozioni limitatissime ed
incerte delle fonti letterarie antiche,
essenzialmente collegate con la
disciplina etrusca e in particolare con i
libri rituali. L 'ipotesi
dell'esistenza di un ius terrae Etruriae, cioè di
una legislazione della
proprietà terriera, sostenuta da S. Mazzarino, dove
comunque sarebbe nominato
un ius Etruriae. L'estrema importanza della
normativa riguardante i confini
(molti dei quali contrassegnati da cippi con
la parola tular) sembra del
resto confermata anche da altri documenti. Ma
siamo in ogni caso, sia per
questa materia civile come per il diritto
penale, prevalentemente nella sfera
del sacro, cui si farà riferimento nel
capitolo
successivo.
Il popolo
Sotto la classe padronale o
gentilizia - la cui ricchezza si era creata con
l'agricoltura, il commercio,
la pirateria - si formò col tempo, a partire
dal VII secolo, una sorta di
ceto medio anch'esso composto da agricoltori,
artigiani mercanti (non pochi
di costoro erano stranieri, che prendevano
fissa dimora nei centri dove li
portavano i loro traffici e magari sposavano
donne del posto). Non è pur
troppo facile ricostruire l'esistenza di questa
gente e di quella che stava
al livello più basso della scala sociale, i
servi. È evidente che questi
servi non costituivano un blocco omogeneo, e
che (erano fra loro differenze
anche notevoli in relazione alle funzioni che
svolgevano. Certo erano molto
numerosi. Le fonti di approvvigionamento del
personale servile furono
dapprima le scorrerie piratesche, poi le guerre (i
prigionieri di guerra
finivano, come è noto, in schiavitù): e va da sé che
schiavi erano i nati da
genitori di condizione servile. Mercati di schiavi c
'erano poi dappertutto
(alcuni internazionalmente noti), e c'erano
trafficanti specializzati che
facevano soldi a palate trattando questa
merce. I prezzi variavano
naturalmente secondo la qualità (caratteristiche
etniche, nazionalità, età,
sesso, forza, bellezza, salute, conoscenza di
arti e mestieri, cultura,
ecc.).
Pare che le case dei ricchi Etruschi pullulassero di schiavi, adibiti
alle
più svariate funzioni, non di rado pretestuose. Fra gli schiavi
che
servivano durante i banchetti, c'erano quelli che mischiavano nelle
anfore
il vino e l'acqua, quelli che versavano le bevande nelle coppe, quelli
che
tagliavano le carni, quelli che distribuivano i cibi, e così via. I
servi
erano, come in tutte le società antiche, alla mercé dei padroni. In
Etruria
erano, sembra, trattati un po' più familiarmente e mitemente che a
Roma, ma
non mancavano certo i padroni capricciosi e crudeli. Le punizioni -
frustate
per lo più, ma si arrivava alla tortura e alla morte - erano
all'ordine del
giorno. Non c'erano deterrenti legali contro padroni cattivi o
addirittura
sadici: si può supporre tuttavia che valesse come freno la
disapprovazione
sociale. E poi gli schiavi rappresentavano un patrimonio e
strumenti di
lavoro che si aveva interesse a proteggere e a sfruttare. Lo
spettro dei
servi era l'ergastolo (il lavoro cioè nelle miniere, nelle cave
di marmo
quando si cominciò a sfruttarle sistematicamente, nelle paludi per
opere di
prosciugamento), che si svolgeva in condizioni disumane. Con il
costituirsi
di grosse ricchezze terriere e l'estendersi del latifondo si
andarono
spopolando le campagne. I contadini, che già prima stentavano la
vita,
sfruttati e vessati dai proprietari, cercavano scampo nei centri
urbani. A
sostituirli erano gli schiavi, che costavano meno anche se il
loro
rendimento non era esaltante.
Come dappertutto, gli schiavi in
Etruria potevano emanciparsi, grazie al
peculio che riuscivano ad accumulare
o semplicemente grazie ai meriti che
acquisivano. L'affrancamento dipendeva
comunque dalla volontà del padrone,
nei confronti del quale il liberto
(lautni com'era chiamato in lingua
etrusca) conservava obblighi importanti.
Il liberto aggiungeva al suo nome
il gentilizio del padrone, faceva pur
sempre parte della famiglia, ma aveva
una vita propria, lavorava per sé,
poteva sposare una libera o un libero,
arricchire, fare
carriera.
Basandoci sulle testimonianze figurative e letterarie possiamo
farci un'idea
di com'erano fisicamente gli Etruschi. Con molta cautela, senza
dimenticare
il lavoro di idealizzazione degli artisti e i loro modelli
culturali: è dall
'Asia Minore e dalla Grecia, per esempio, che gli scultori
avevano preso la
fronte sfuggente, il naso dritto, l'occhio a mandorla e quel
sorriso
particolarissimo che poi venne assunto a simbolo dell'arte etrusca.
Non
parleremo quindi semplicisticamente di un "tipo etrusco" sulla scorta di
un
famosissimo sarcofago di terracotta (metà del VI secolo) proveniente da
Cere
(Cerveteri), su cui è rappresentata una coppia di coniugi adagiati
fianco a
fianco sul letto del banchetto funebre, con un viso lei da kore
attica, lui
tendente al triangolare, con occhi obliqui resici familiari
dall'arte
egeica.
Catullo e Virgilio hanno parlato rispettivamente di
obesus etruscus e di
pinguis tirrhenus, varando un'immagine degli Etruschi
goderecci e mangioni.
che trova del resto qualche riscontro nella scultura,
soprattutto in tre
sarcofaghi. Uno, proveniente da San Giuliano nei pressi di
Viterbo ci
presenta sul coperchio una figura coricata sul dorso con un
ventre
spropositato; un altro, di Tarquinia, mostra un vecchio dalle carni
piene
che contrastano con guance e collo flaccidi e rugosi; il terzo,
conservato
nel Museo di Firenze, ci presenta un panciutissimo individuo
coronato di
fiori (un cavaliere, si direbbe dall'anello all'anulare della
mano
sinistra), dalla testa semicalva e dagli occhi spalancati, che regge
nella
mano destra una coppa. Ma possiamo considerare questi
personaggi
rappresentativi della media degli Etruschi o piuttosto del ceto
ricco,
godereccio, infiacchito dal benessere e dall'ozio? Prendendo
in
considerazione un centinaio di iscrizioni comprese fra il 200 e il 50
a.C.
sulle quali figurano le età dei defunti, gli studiosi hanno ipotizzato
(con
qualche incertezza per la perdurante difficoltà a interpretare
alcuni
numerali che vi compaiono) una durata media della vita degli Etruschi
di
40,88 anni, non disprezzabile per i tempi, ma che non tiene conto
della
mortalità infantile, allora elevatissima.
Gli Etruschi dovevano
essere piccoletti, se vogliamo credere agli scheletri
(circa un metro e mezzo
per le donne, una decina di centimetri in più per
gli uomini). Ma lo erano
anche i Romani e molti popoli dell'epoca. Basta
guardare nei musei armature
ed elmi per rendersene conto. Da quando si
intensificarono i contatti con i
Greci, gli Etruschi si ispirarono alla loro
moda per l'abbigliamento, che ci
appare nei documenti figurativi nel
complesso piuttosto vivace ed elegante
(poche informazioni ricaviamo dagli
autori romani, e solo per gli aspetti
dell'abbigliamento che Roma importò
dall'Etruria). È ovviamente difficile
distinguere l'abbigliamento di tutti i
giorni da quello festivo e
cerimoniale. Gli uomini, specie i giovani,
stavano spesso seminudi, in casa
soprattutto ma anche fuori, accontentandosi
del perizoma, un panno annodato
intorno ai fianchi a formare come delle
braghette. Oppure mettevano un
giubbetto. Le persone mature indossavano più
spesso la tunica leggera lunga
fino ai piedi, pieghettata e ricamata, e
quando faceva freddo il mantello di
stoffa pesante e colorata. Le donne si
sbizzarrivano di più: tuniche, gonne,
corpini, giubbetti, casacche, mantelli
colorati ricamati. Soprattutto le
gonne colpiscono per loro grazia, con le
loro pieghettature, increspature,
inamidature, e con le forme svasate che
lasciano sospettare cerchi di
sostegno. Tutti questi capi di vestiario
subirono una evoluzione le cui tappe
non è sempre possibile precisare. Alla
metà circa del VI secolo risale, per
esempio, l'introduzione del chitone di
lino, indumento decisamente unisex,
anche in una versione corta al ginocchio
(più tardi, in epoca ellenistica, si
impose fra gli eleganti il chitone
attillato con cintura). Vivace fu anche
l'evoluzione del mantello: quello
classico, di derivazione greca, era
rettangolare, ma andò molto di moda
anche uno semicircolare che si portava di
traverso lasciando una spalla
scoperta. Uno dei capi di vestiario più famosi
e di più lunga vita è il
tebennos. che possiamo ammirare su delle piastre di
terracotta provenienti
da Cere e conservate nel Louvre (VI secolo): vi è
raffigurato un re seduto
su una sedia curule che indossa sopra una corta
tunica bianca orlata di
rosso un mantello purpureo che gli lascia scoperta la
spalla destra.
Adottato a Roma dai sacerdoti e dai militari, il tebennos
evolvette nella
toga.
Nella tomba bolognese degli Ori si è trovato un
tintinnabulum di bronzo su
cui sono raffigurate fasi della lavorazione dei
tessuti (cardatura filatura
tessitura). Le fibre più usate erano la lana e il
lino. Gli Etruschi amavano
i colori intensi e le decorazioni, incorporate o
applicate. Ai piedi sandali
con suole leggere e cinghie incrociate (ce
n'erano con suole di legno anche
molto alte, montature metalliche e lacci
dorati; altri, semplicissimi,
avevano suole di legno basse, fasce a
semicerchio e un cordone fra l'alluce
e le altre dita). C'erano zoccoli,
c'erano stivaletti del tipo che oggi
diremmo alla polacca. Derivarono da
calzature etrusche gli stivali indossati
dai senatori romani (calcei
senatorii), con linguette e corregge, che vedono
in molte statue romane ma
già nella statua dell'Arringatore. Le più tipiche
calzature etrusche erano
però quelle che i Romani chiamarono calcei repandi,
babbucce curve e
colorate, forse di panno, con le punte volte in su e la
parte posteriore
anche molto rialzata. Sta di fatto che i calzolai etruschi
godevano di gran
fama anche fuori del paese. I copricapi erano molto in uso
in Etruria, più
che in Grecia dove si andava prevalentemente a testa
scoperta. Ne conosciamo
alcuni: a larghe falde adatti a proteggere dalle
intemperie, ad ampia tesa
con la parte superiore conica (qualcosa di simile
al sombrero). E poi
berretti, di lana e pelle. Risale all'età arcaica il
cappello conico
femminile chiamato tutulus, nome un po' impreciso, applicato
anche a un
berretto di lana degli auguri e a una pettinatura femminile
(capelli avvolti
intorno a un nastro). Per le donne tutta la gamma, in
pratica, delle
pettinature odierne - nodi, trecce, chignons, riccioli - e
dei marchingegni
per tenerle insieme (reti, spil loni e così via). Farsi i
capelli biondi
faceva fino.
Sempre dai Greci gli uomini presero l'abitudine della barba rasa
e dei
capelli corti. Chi poteva permetterselo si adornava con ogni sorta
di
gioielli e monili (spille, diademi, collane, pettorali,
bracciali,
braccialetti, anelli ciondoli). In guerra gli uomini si vestivano
e armavano
come quelli degli altri paesi. Le armi erano lance, giavellotti,
spade
lunghe e corte, sciabole ricurve, pugnali, asce (magari a doppio
taglio),
mazze, archi, fionde. Per proteggersi elmi e scudi di varia forma,
corazze
(dapprima in tela con borchie bronzee tonde o quadrate, poi
interamente in
bronzo), schinieri. Un periodo cruciale dell'evoluzione
dell'armamento fu il
VI secolo, con il passaggio dalla tecnica di
combattimento di tipo eroico
(corpo a corpo) a quella che implicava l'uso di
masse (fanteria oplitica e
cavalleria). I modelli greci allora prevalsero
nettamente su quelli
centroeuropei: elmo conico di tipo ionico o calcidese:
scudo rotondo in
lamina bronzea; schinieri di bronzo a proteggere le gambe
spadoni di ferro a
scimitarra. Nei secoli successivi la tecnica di
combattimento della falange
e della cavalleria si consolidò, e le armi si
perfezionarono: si diffuse l'
elmo a calotta con paranuca e paraguance, le
corazze adottarono la forma
anatomica e gli spallacci (bretelle), lo scudo
mantenne la forma rotonda ma
aumentò di dimensioni.
Quanto al carattere
degli Etruschi, non possiamo non registrare le
testimonianze degli antichi
scrittori, tenendo però presente l'invidia che
la potenza e il benessere
degli Etruschi potevano suscitare e lo sconcerto
suscitato da alcuni aspetti
singolarmente liberi e spregiudicati del loro
costume. Li si considerava, e
probabilmente erano, crudeli: ma la crudeltà
era di casa nel mondo antico.
Certo non contribuivano a migliorare la fama
degli Etruschi, sotto questo
profilo, l'avere essi esercitato su larga scala
e molto fruttuosamente la
pirateria e fatti come quello che abbiamo
riferito, la lapidazione in massa
dei Focesi catturati nella battaglia di
Alalia. Virgilio dice peste del re di
Cere, Mesenzio, che si divertiva a
legare faccia contro faccia uomini vivi a
cadaveri lasciandoli morire nel
fetore e nella putredine. Crudeltà insomma
spinta al sadismo. Oltre che
crudeli, gli Etruschi erano accusati in antico
d'essere goderecci,
lussuriosi, ghiottoni. Una delle fonti più citate in
questo senso è Teopompo
(IV secolo a.C.) - riportato da Ateneo (II-III secolo
d.C.) nel suo
Dipnosofisti - considerato peraltro anche anticamente una
solenne
malalingua. Ciò che sembra particolarmente colpirlo è la condotta
delle
donne, liberissima.
Avevano grande cura del corpo, sfoggiavano
seminudità o nudità, bevevano a
più non posso. Quanto agli uomini, erano
donnaioli sfrenati e accettavano la
promiscuità sessuale, non disdegnavano i
ragazzetti, facevano l'amore in
pubblico senza pensarci due volte, si
depilavano. Il filosofo Posidonio di
Apamea (II secolo a.C.) - riportato da
Diodoro Siculo (I secolo d.c.) nella
sua Biblioteca storica - dà un giudizio
degli Etruschi un po' più
equilibrato. Anch'egli tuttavia parla di lusso
eccessivo e di mollezza di
costumi: si fanno imbandire due volte al giorno
tavole sontuose, si fanno
servire da nugoli di schiavi, alcuni bellissimi e
vestiti con sconveniente
eleganza. Questo infiacchimento dei costumi è
secondo Teopompo imputabile
alla illimitata feracità del territorio etrusco.
È da Posidonio che
apprendiamo l'origine etrusca della tromba (detta
"tirrenica"), del fascio
littorio, della sedia d'avorio, della toga con orlo
purpureo, e la perizia
degli Etruschi nelle scienze naturali e nella
teologia. La famiglia etrusca
non differiva sostanzialmente dalla romana e
dalla greca (più simile semmai
alla romana per l'indiscussa autorità del
pater familias), tranne per la
posizione delle donne. Era questo che stupiva
e scandalizzava (abbiamo
citato in proposito Teopompo) le altre nazioni. Si
desume, l'importanza
maggiore delle donne dal fatto che sempre nelle
iscrizioni il loro nome è
preceduto dal prenome e per tutti, maschi e
femmine, si dà non solo la
paternità, ma la maternità.
Certo è che le
donne etrusche non stavano chiuse nel gineceo, la loro virtù
non era misurata
solo sulla pudicizia, sulla bravura nell'accudire alla casa
e nel filare.
Partecipavano a tutti gli aspetti della vita privata e
pubblica (ai
banchetti, ai giochi, alle cerimonie), e attivamente alle
carriere dei
mariti. Tito Livio racconta per esempio il ruolo che ebbe
Tanaquilla, donna
di nobile famiglia, nella fortuna del marito Lucumone
(figlio di un greco
immigrato). Lucumone divenne, niente meno, re di Roma,
con il nome di Lucio
Tarquinio Prisco. Ma ancora dopo la morte di Tarquinio,
Tanaquilla ebbe parte
determinante nell'elezione a re del proprio genero,
Servio Tullio. Un'altra
di queste donne energiche e influenti, Urgulanilla,
moglie di un certo
Plauzio di cui non sappiamo nulla, frequentò la corte di
Augusto sfruttando
la grande amicizia con l'imperatrice Livia. Una sua
nipote sposò un nipote di
Livia, Claudio, un giovane infelice (miisellus lo
definiva preoccupato
l'imperatore), considerato più o meno l'idiota della
famiglia. Questo
misellus però mise a frutto i rapporti che grazie al
matrimonio stabilì con
l'ambiente dell'aristocrazia etrusca, ebbe accesso
agli archivi di molte
famiglie importanti, e divenne, oltre che imperatore,
un valente etruscologo.
Se ci fosse rimasta la sua storia degli Etruschi in
venti libri - purtroppo
andata perduta - il mondo etrusco presenterebbe per
noi molti meno
misteri.
Le classi sociali
Agli albori della
storia di questo popolo, nel periodo Protovillanoviano
(età del Bronzo) e nel
successivo Villanoviano iniziale (età del Ferro), non
si notano segni di una
distinzione in classi all'interno della società; essa
invece appare evidente
nel Villanoviano evoluto, nella seconda metà dell'
VIII secolo a.C., quando i
corredi funerari cominciano a mostrare netti
segni di differenziazione:
aumentano gli oggetti di corredo in quantità e
qualità, appaiono vasi ed
ornamenti d'importazione. Qualcosa è cambiato
nella società etrusca e lo si
vedrà amplificato alla fine dell'VIII secolo
a.C. e nel successivo, quando
appare lo splendore della società
Orientalizzante, con all'apice le ricche
aristocrazie dalle grandi tombe a
tumulo e dai sontuosi corredi, che basavano
il proprio potere e prestigio
sul controllo dei commerci con l'Oriente e
delle attività agricole e
pastorali.
La nascita di un ceto "medio" avviene
nel'età Arcaica, nel VI secolo a.C.,
quando artigiani e mercanti iniziano a
prendere coscienza delle proprie
capacità, operando per proprio conto e non
più per i ricchi principi. Fanno
parte della stratificazione sociale anche i
lautni, gli schiavi, importati
come merce da paesi lontani o catturati
durante le numerose battaglie per il
predominio sul commercio tirrenico: a
volte si rinvengono i luoghi di
sepoltura di questi esponenti della classe
servile, cremati e posti in
recipienti di terracotta, tumulati in piccole
nicchie scavate nelle
strutture sepolcrali dei padroni.
La
classe sacerdotale
Il ruolo della classe sacerdotale comincia a definirsi
più chiaramente nella
città-stato etrusca a partire dal VI sec. a.C.
Attributo distintivo del
sacerdote era il lituo, un bastone di piccole
dimensioni e ricurvo a un'
estremità, del quale si ha testimonianza fin dalla
prima metà del VI sec.
a.C. Si tratta di un'insegna già conosciuta dagli
storici degli Annales:
l'augure che accompagnò a Roma il re Numa Pompilio
stringeva nella mano
destra, secondo la descrizione che ne viene fatta,
proprio questo "bastone".
Personaggi così raffigurati si trovano di frequente
in Etruria a cominciare
dalla fine del VI sec. a.C., riprodotti sia in
bronzetti votivi che sulle
stele funerarie. Nelle lastre architettoniche
della "dimora" di Murlo (SI)
il lituo è un attributo distintivo del
capo-signore, che evidentemente era
investito - oltre che del potere
politico- anche di quello religioso.
Possiamo formulare l'ipotesi che questo
nuovo "ceto sociale" (sacerdotale)
sia venuto fonnandosi nelle città quando
il potere del "re" cominciava a
sgretolarsi, come diretta emanazione quindi
della classe aristocratica.
Possiamo inoltre supporre che, col tempo, si sia
costituita anche una
gerarchia all'interno del sacerdozio. Nel III sec. a.C.
compare una serie di
monete che recano, sul diritto, l'immagine di una testa
di aruspice
(netsvis) con berretto conico (tùtulus) e, sul rovescio, la scure
e il
coltello, ossia gli strumenti sacrificali. I sacerdoti addetti al
culto
erano chiamati cepen: è probabile che fra di loro vi fosse una
gerarchia
dotata di cariche specifiche (spurana cepen: sacerdote pubblico).
Come a
Roma i sacerdoti erano depositari di varie fonne di scienza,
così
presumibilmente accadeva anche per quelli etruschi. Sappiamo infatti
da
Censorino, erudito latino del III sec. d.C., che nei Libri rituali
era
contenuta anche una dottrina specifica per il computo del tempo
(saecula)
non solo degli esseri viventi, ma anche degli stati: il massimo
tempo
concesso all'Etruria sarebbe stato di dieci saecula. Il numero di
anni
compreso in un saeculum non era fisso, ma stabilito da prodigi
spesso
astronomici. La ninfa Vegoia aveva profetizzato che nell'VIII
secolo
qualcuno, per avidità, avrebbe cercato di aumentare i propri
possedimenti;
tale "secolo" sembrerebbe corrispondere agli inizi del I sec.
a.C.: i
sacerdoti etruschi avrebbero dunque previsto la fine dell'Etruria con
poco
margine di errore.
La famiglia
La
struttura della famiglia etrusca non è dissimile da quella delle
società
greca e romana. Era cioè composta dalla coppia maritale, padre e
madre,
spesso conviventi con i figli ed i nipoti e, tale struttura è
riflessa dalla
dislocazione dei letti e delle eventuali camere della maggior
parte delle
tombe. Conosciamo alcuni gradi di parentela in lingua etrusca
grazie alle
iscrizioni, come papa (nonno), ati nacna (nonna), clan (figlio),
sec
(figlia), tusurhtir (sposi), puia (sposa), thuva (fratello) e
papacs
(nipote).
La donna
Merita un cenno la
condizione sociale della donna che, a differenza del
mondo latino e greco,
godeva di una maggiore considerazione e libertà: se
per i latini la donna
doveva essere lanifica et domiseda, cioè seduta in
casa a filare la lana, e
su cui, nelle età più antiche, il pater familias
(il capofamiglia) aveva il
diritto di morte qualora fosse stata sorpresa a
bere del vino, per gli
Etruschi ella poteva partecipare persino ai banchetti
conviviali, sdraiata
sulla stessa kline (letto) del suo uomo, o assistere ai
giochi sportivi ed
agli spettacoli. Questo era scandaloso per i Romani che
non esitarono a
bollare questa eguaglianza come indice di licenziosità e
scarsa moralità da
parte delle donne etrusche: addirittura dire "etrusca"
era sinonimo di
"prostituta". Ma la condizione sociale della donna nella
civiltà etrusca era
veramente unica nel panorama del mondo mediterraneo, e
forse ciò derivava
dalla diversa stirpe dei popoli, pre indoeuropei gli
etruschi, indoeuropei
latini e greci.
La donna poteva trasmettere il proprio cognome ai figli,
soprattutto nelle
classi più elevate della società. Nelle epigrafi talvolta
il nome (oggi
diremmo il cognome) della donna appare preceduto da un prenome
(il nome
personale), segno del desiderio di mostrarne l'individualità
all'interno del
gruppo familiare a differenza dei Romani che ne ricordavano
solo il nome
della gens, della stirpe. Tra i nomi propri di donna più
frequenti troviamo
Ati, Culni, Fasti, Larthia, Ramtha, Tanaquilla, Veilia,
Velia, Velka, i cui
nomi appaiono incisi sul vasellame migliore di casa od
accanto alle pitture
funerarie.
Le Attività
L'alimentazione
La
cucina etrusca
Il vino
Fornelli, stoviglie e altri utensili per
cucina
La filatura e la tessitura
Aspetti della vita, economia e
tecnica
Le armi e l'abbigliamento
La
medicina
L'alimentazione
Le fonti letterarie
conservateci che trattino questi soggetti risultano
davvero scarse; le
notizie che abbiamo ci sono infatti riportate da autori
greci e latini, i
quali -colpiti in modo negativo dal "lusso"
dell'aristocrazia etrusca - non
possono considerarsi una fonte attendibile,
anche perche risultano di molto
posteriori al periodo di fioritura della
civiltà etrusca. Posidonio di
Apamea, per esempio, racconta che gli Etruschi
apparecchiavano le loro tavole
"ben" due volte al giorno: del resto, anche i
Greci consumavano due pasti al
giorno, ma il pranzo era molto frugale. Il
dato archeologico, che in genere è
così importante, nel caso
dell'alimentazione non è direttamente determinante;
infatti, solo
recentemente gli scavi degli abitati sono stati affiancati da
indagini
paleonutrizionali; oltre a ciò, relativamente rari risultano gli
avanzi di
pasto rinvenuti. Comunque utili notizie possono essere dedotte
dagli
utensili ritrovati negli ambienti adibiti a cucina, ma soprattutto
dagli
affreschi che decorano le pareti di alcune tombe, soprattutto quelli
della
"Tomba Golini I" di Orvieto, che mostrano immagini relative
alla
preparazione del banchetto.
Da un famoso brano dello storico Tito
Livio (Historiae XXXVIII, 45)
sappiamo che in Etruria si coltivavano
copiosissime messi (in particolare
grano e farro); esse dovevano costituire
l'alimento-base sulla mensa di
tutti i giorni, sia sotto forma di pani e
focacce, che di minestre e zuppe.
Dalla citata notizia di Livio, inoltre,
possiamo indurre che i bovini
fossero allevati non solo per la carne, ma
anche perche necessari per il
lavoro dei campi, soprattutto per l'aratura.
Gli avanzi di pasto rinvenuti
durante gli scavi ci testimoniano, d'altra
parte, la presenza sulla tavola
etrusca di altri animali domestici quali
ovini, caprini e suini, in
proporzioni diverse a seconda del tempo o luogo in
cui ci si trovasse; altra
fonte di alimentazione, inoltre, era la selvaggina,
come ci testimoniano gli
autori antichi e alcuni famosi affreschi (la citata
"Tomba Golini I" di
Orvieto o la "Tomba della Caccia e della Pesca" di
Tarquinia). Per quanto
riguarda l'alimentazione ittica, ancora più rari
risultano (dalla ricerca
archeologica) gli avanzi di pasto, a causa della
deperibilità degli
scheletri dei pesci e del guscio dei molluschi; rimangono,
comunque, come
testimonianza archeologica, ami da pesca, aghi e pesi da rete.
Gli Etruschi
dovevano conoscere diverse varietà ittiche diffuse nel
Mediterraneo, come
mostrano i cosiddetti "piatti da pesce" in cui appaiono
raffigurate, sulla
superficie esterna, numerose specie
manne.
L'alimentazione del mondo mediterraneo antico è condizionata,
ovviamente,
dai prodotti che la natura offre e le condizioni climatiche
simili nel mondo
greco, latino ed etrusco, hanno generato una dieta ed una
cucina per molti
versi assai simili tra loro. Per l'età preistorica si hanno
dati
scientificamente molto interessanti per il villaggio del Gran Carro
di
Bolsena, scoperto sotto le acque del bacino lacustre e databile attorno
al
IX secolo a.C, nella fase di passaggio dunque tra l'età del Bronzo e
l'età
del Ferro.
Il setacciamento dei fanghi che ricoprivano le antiche
strutture, eseguito
nel 1974, portò alla luce una rilevante quantità di
noccioli di frutta
selvatica tra cui corniolo (Cornus mas), prugna selvatica
(Prunus spinosa) e
prugna damascena (Prunus insititia), nocciolo (Corylus
avellana) e ghiande
(Quercus sp.), ed anche vite (Vitis vinifera) che presto,
grazie alle
conoscenze trasmesse dai navigatori provenienti dall'Egeo,
sarebbe stata
trasformata in vino e non consumata solo come frutta. Tra i
cereali sono
presenti cariossidi di farro (Triticum dicoccum), tra i legumi
resti di fave
(Vicia faba). I cereali ed i legumi potevano essere consumati
abbrustoliti o
macinati per farne frittelle e minestre; la frutta poteva
essere consumata
fresca o fermentata in bevande a scarso tenore alcolico. Tra
i resti
faunistici (scavi 1980) ricordiamo la presenza di numerose specie
domestiche
(68 % del totale dei resti ossei rinvenuti) e selvatiche (32 %).
Sono stati
segnalati resti di caprovini, suini, bovini, equini, cani; tra i
selvatici
cervo, cinghiale, capriolo ed orso bruno.
I dati disponibili
dagli scavi condotti dall'Istituto Svedese di Roma a San
Giovenale (Blera)
abbracciano un arco cronologico molto ampio che va dall'
età del Bronzo
all'età romana: essi rivelano come attraverso i secoli il
principale alimento
siano stati i suini, gli ovini ed i bovini, talvolta
integrati da esemplari
cacciati come il cervo, il capriolo e la lepre. Se
cerchiamo analogie con il
mondo romano di cui si possiedono numerose notizie
in più rispetto
all'etrusco, apprendiamo che si tendeva al consumo
soprattutto di suini,
mentre i caprovini erano destinati alla produzione di
latte e lana, i bovini
al lavoro nei campi. La carne era arrostita su lunghi
spiedi (in greco
obeloi) che, in epoche premonetali, cioè quando ancora non
si usavano monete
e si ricorreva allo scambio di prodotti e di metalli a
peso, costituivano nel
Mediterraneo un elemento di scambi assai frequente.
Ma poteva essere anche
bollita in grandi calderoni da cui veniva estratta
con uncini.
A San
Giovenale sono stati rinvenuti fornelli e pentole di terracotta
che
testimoniano la quotidiana vita dell'abitato: molti dei
materiali
archeologici provenienti soprattutto dagli abitati arcaici della
Tuscia (San
Giovenale ed Acquarossa) sono esposti in un'interessantissima
mostra
permanente presso il Museo Archeologico Nazionale di Viterbo
(Rocca
Albornoz). Lo scavo di un insediamento agricolo etrusco del IV - III
secolo
a.C. condotto dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria
Meridionale a
Blera in località Le Pozze (scavi 1986-87), ha permesso il
rinvenimento di
570 semi e noccioli di frutta, tra cui segnaliamo corniolo,
nocciolo,
ghiande di quercia, olivo (Olea europaea), vite, fico (Ficus
carica), pero
(Pyrus sp.) ed orzo (Hordeum sp.). Tra i resti di animali,
presenti i suini,
la capra, i bovini, le galline. Indagini paleonutrizionali,
cioè sulle
modalità alimentari del passato, condotte sulla popolazione
etrusca, hanno
rivelato che dal VII secolo a.C. all'età romana l'economia
alimentare sia
rimasta a base agricola; un consumo maggiore di carne e
latticini,
rilevabile dall'aumento di Zinco nelle ossa, si ha nell'età
arcaica (VI
secolo a.C.-inizio V secolo a.C.): con il passaggio all'età
classica ed all'
ellenistica si nota una graduale diminuizione del consumo di
prodotti di
origine animale, forse conseguenza di quella forte crisi
economica che avrà
il suo inizio nel V secolo a.C. e che si protrarrà con la
conquista romana.
La cucina etrusca
Le raffigurazioni
pittoriche della tomba Golini I di Orvieto (l'antica
Volsinii) databili alla
seconda metà del IV secolo a.C., ci offrono una
visione interessante delle
attività di cucina di un'importante famiglia
dell'aristocrazia: sulle pareti
sono rappresentati i servi che fanno a pezzi
la carne con una piccola ascia,
altri che preparano i cibi sotto lo sguardo
attento di una donna: preparano
focacce, cuociono le cibarie nel forno,
mesciono le bevande nelle brocche.
Nelle altre pareti appaiono i loro
padroni, seduti o sdraiati sulle klinai, i
letti tricliniari del banchetto,
in compagnia delle proprie donne dalle
ricche vesti, illuminati da alti
candelieri di bronzo lucente, serviti da
schiavi nudi ed allietati da
suonatori di lira e tibicines (flauti
doppi).
Ma cosa si mangiava nell'antica Etruria? Oltre alla frutta e verdura
di cui
abbiamo fatto cenno, quali erano le pietanze, i cibi preparati ? Nei
tempi
più antichi erano frequenti le minestre di cereali e legumi, come le
gustose
zuppe di verdura: ne è un ricordo eccezionale l'acquacotta, uno dei
piatti
della tradizione culinaria viterbese. Le sfarinate di cereali
erano
utilizzate per fare frittelle e focacce. La carne era bollita ed
arrostita:
sono frequenti nei corredi delle tombe gli alari, gli spiedi e le
pinze per
maneggiare i tizzoni di brace. Condimento ideale per ogni cibo era
l'olio
d'oliva, di qualità eccellente, esportato in tutto il Mediterraneo
come
testimonia il rinvenimento di anfore etrusche: anche oggi la qualità
dell'
olio viterbese lo denota come prodotto tipico, così come il vino.
La
mancanza di una letteratura specifica non ci aiuta nella conoscenza
di
ricette e preparazioni tipiche, lontane dalla raffinata e
forse
confusionaria cucina d'età romana: ma non è difficile immaginare che
i
piatti più tipici della tradizione gastronomica toscana e viterbese,
così
legati alla sana e semplice cultura contadina, siano il perpetuarsi
della
cucina etrusca.
Il vino
Già nel VII secolo
a.C. la vite e l'olivo erano coltivati intensivamente in
Etruria ma, per
quest'ultimo, la produzione non fu mai considerata
importante dagli autori
antichi; del vino etrusco, invece (anche se in senso
talvolta negativo),
scrivono sia Orazio che Marziale. Il vino bevuto
nell'antichità era molto
diverso da quello d'oggi: denso, fortemente
aromatico, ad elevata gradazione
alcolica. Il primo mosto ottenuto dalla
vendemmia veniva in genere consumato
subito, mentre il restante veniva
versato in contenitori di terracotta con le
pareti interne coperte di pece o
di resina. Il liquido veniva lasciato
riposare, schiumato per circa sei mesi
e a primavera, infine, poteva essere
filtrato e versato nelle anfore da
trasporto. Il liquido così ottenuto non
veniva bevuto schietto ma mescolato,
all'interno di crateri, con acqua e
miele, e travasato nelle coppe dei
cornrnensali, servendosi di attingitoi e
sìmpula. Sulla mensa, il vino era
contenuto in brocche e vasi a doppia ansa
(stàmnoi), mentre per l'acqua si
utilizzavano spesso piccoli secchi,
denominati sìtule.
Non potevano mancare, in una cucina ben attrezzata, i
colini. Questi
instrumenta sono presenti in tutta l'area mediterranea,
dall'Egeo alla
Gallia Meridionale, a iniziare dal VI secolo a.C. fino all'età
romana
imperiale. Gli esemplari più antichi (II millennio a.C.) sono stati
trovati
in Grecia, nell' isola cicladica di Santorino, realizzati in
terracotta.
Potevano essere ottenuti anche in altro materiale (argento,
bronzo, rame,
ceramica) e diverse risultano le varianti della forma a seconda
dell'uso.
Alcuni colini appaiono provvisti di un imbuto (nome latino
infundìbulum),
collegato al colino stesso, altri ne sono privi, altri infine
si denotano
semplicemente per un "bulbo" ricavato al centro della vasca.
Alcuni di essi
rivelano, sul lato opposto al manico, un sostegno rettangolare
orizzontale
destinato a reggere il colino stesso sull'imboccatura del vaso in
cui veniva
versato il liquido; in un secondo momento, il colum poteva essere
lasciato
appeso all'orlo del recipiente, pure tramite questa sorta di gancio.
I
colini provvisti di imbuto venivano usati per filtrare il vino e
altri
liquidi in tipi di recipiente contraddistinti da strette
imboccature.
Fornelli, stoviglie e altri utensili per
cucina
Gli Etruschi, di solito, non avevano, all'interno delle loro
abitazioni, un
vano adibito a cucina quale lo intendiamo oggi; spesso si
cuoceva
all'aperto, ma comunque esistevano sistemi di cottura che
utilizzavano dei
particolari "fornelli". Ne esistono sostanzialmente di tre
tipi, provvisti
ognuno di relative varianti: il tipo più antico è di forma
cilindrica e
munito sulla superficie superiore di una piastra forata e, sulla
parte
inferiore, di un' apertura per l'alimentazione del fuoco; verso la fine
del
VII sec. a.C. compare un secondo fornello semicilindrico, a forma di
ferro d
cavallo, con tre parti sporgenti verso l'interno per sostenere la
pentola; c
'è infine un ultimo modello, simile a una piccola botte aperta
per
appoggiarvi il recipiente per la cottura e, in quella inferiore, per
il
carico del combustibile.
Il secondo tipo era già conosciuto nella
Magna Grecia e doveva risultare
migliore del primo modello, in quanto
permetteva una cottura più veloce. In
diverse zone dell'Etruria, per esempio
a Poggio Civitate, Murlo (SI), sono
state trovate specie di campane di
terracotta provviste di un 'ansa alla
sommità, sotto le quali venivano posti
i cibi da cuocere; intorno veniva
messa la brace per consentire la cottura,
simile dunque a quella sub testo
dei Romani. Altri utensili per cuocere i
cibi sono gli spiedi (in greco
obelòi), usati per arrostire la carne. Li
troviamo talvolta conservati nelle
tombe, forgiati in bronzo o ferro, lunghi
anche 1 m e associati a graffioni.
Quest'ultimo tipo di strumento ha più
volte attirato l'attenzione degli
studiosi, che hanno tentato di definirne
l'uso. Prevalgono oggi due
interpretazioni: la prima tende a identificare
questo oggetto con un
porta-fiaccole, i cui rebbi sarebbero stati destinati a
sostenere materiale
combustibile; la seconda, avvalorata anche da fonti
letterarie (strumenti
simili sono infatti descritti, con tale uso, dalle
testimonianze romane,
contraddistinti dal nome latinizzato di hàrpago), lo
considera un utensile
domestico, anzi culinario, usato per infilzare e
cuocere pezzi di carne,
recuperarli dai calderoni e togliere pietanze "dal
fuoco". Nel medioevo, per
es., si usavano uncini per impedire che i cibi in
cottura venissero a galla.
Tra gli instrumenta domestica vanno anche
annoverate le "teglie" (simili
nella forma alle odierne padelle), alcune del
tipo monoansato, in bronzo. Si
tratta di utensili domestici adibiti a
contenere i cibi in fase di cottura e
chiamati anche pàtere o bacinelle, di
cui esistono diverse varianti a
seconda del modo in cui risultino forgiati
orlo e ansa. La medesima classe
di recipiente si trova replicata, nel corso
del III secolo a.C., nella
cosiddetta "Ceramica a Vernice Nera" di produzione
volterrana, che ispira le
sue fonne a prototipi di vasi in metallo, ottenendo
così contenitori a un
costo inferiore di quello raggiunto dagli originali.
Un altro oggetto d'uso
domestico che compare tra le suppellettili da cucina è
la grattugia, in
genere ricavata in bronzo, ma talvolta anche in metallo
pregiato. Il termine
latino ràdula è usato da Columella (De re rust. XII,
15,5) per un oggetto
che doveva servire a raschiare la vecchia pegola dai
vasi, prima di
spalmarvela nuovamente. Non siamo certi, tuttavia, che si
tratti del
medesimo oggetto, in quanto Columella non lo descrive. Omero già
la menziona
(Iliade XI, 638), usata per grattugiare il fonnaggio; era infatti
usata per
fare il kykèion, bevanda composta da vino forte, orzo, miele e
fonnaggio
grattugiato, bevuta dagli eroi omerici. Non sappiamo se anche gli
Etruschi
avessero una bevanda simile.
La filatura e la
tessitura
A parte la preparazione e la cottura dei cibi, le attività
domestiche
peculiari della donna etrusca (anche di elevato ceto sociale)
erano la
filatura e la tessitura della lana e delle fibre vegetali (lino).
Già in
epoca villanoviana, i corredi delle tombe femminili
contengono
frequentemente rocchetti e fuseruole di ceramica e, talvolta, fusi
di
bronzo. L'attività della tessitura, del resto, è documentata negli
scavi
degli abitati da numerosi pesi da telaio, di norma realizzati in
terracotta
in forma troncopiramidale, oppure costituiti da semplici ciottoli
(il telaio
vero e proprio era invece interamente di legno). Alcune antiche
scene
figurate, per esempio sul tintinnàbulo di bronzo di Bologna (VII sec.
a.C.),
riproducono le diverse fasi di lavorazione delle fibre tessili,
in
particolare della lana. Dopo essere stata cardata, cioè pulita e
pettinata,
quest'ultima veniva attorcigliata in fili grezzi e poi filata con
il fuso
(in legno, osso o bronzo); il filo così ottenuto, avvolto sui
rocchetti, era
quindi utilizzato per la tessitura, eseguita per lo più
mediante telai
verticali, nei quali i fili erano tenuti in tensione, a
gruppi, dagli
appositi pesi.
Aspetti della vita,
economia e tecnica
La ricostruzione della vita che si svolgeva nelle case
dei ricchi non
presenta eccessive difficoltà. Si è già accennato alla
posizione della donna
che partecipa ai conviti e alle feste con perfetta
parità di fronte
all'uomo. In età arcaica le donne e gli uomini banchettano
distesi sullo
stesso letto: ed è probabilmente a questa usanza che risale
l'affermazione
di Aristotele (in Ateneo, 1,23 d) che "gli Etruschi mangiano
insieme con le
donne giacendo sotto lo stesso manto". Si è anche supposto che
Aristotele si
riferisca ad una falsa interpretazione di alcuni sarcofagi sui
quali
appaiono i due coniugi giacenti sotto un manto simbolo di nozze.
La
cerimonia nuziale presso gli Etruschi comprendeva infatti il
rito
(conservato tuttora dagli Ebrei) della copertura degli sposi con un
velo:
come attesta il rilievo, di non dubbia interpretazione, di una umetta
di
Chiusi. Ma è possibile che l'uso del velo esistesse in realtà anche per
i
letti conviviali. Si presume comunque che i Greci, per un atteggiamento
di
incomprensione e di ostilità verso gli Etruschi forse risalente ad
antiche
rivalità politiche, trovassero argomento di scandalo nella libertà
formale
della donna etrusca, così diversa dalla segregazione della donna
greca
almeno nel periodo classico: e fosse quindi facile e quasi
naturale
attribuire alle etrusche i caratteri e il comportamento delle etère,
le sole
donne che ad Atene partecipassero ai banchetti con gli uomini.
Nascevano
così e si diffondevano - con quella facilità nell'accettare e
ripetere
notizie anche incontrollate specialmente sui costumi dei "barbari",
quasi
come motivi letterari, che è propria del mondo classico - le dicerie
sulla
scostumatezza degli Etruschi, sulle quali insiste Ateneo (IV, 153 d;
VII,
516 sgg.) e di cui si fa eco perfino Plauto (Cistellaria, Il, 3, 20
sgg.). A
partire dal V-IV secolo le donne etrusche non partecipano più ai
conviti
distese sopra il letto come gli uomini, ma sedute, secondo l'usanza
che
resterà poi stabilmente diffusa nel mondo romano. Raffigurazioni
di
banchetti con più letti (generalmente tre, donde il romano triclinio),
come
quelle delle tombe tarquiniesi dei Leopardi o del Triclinio, ci
presentano
quadri pieni di naturalezza e di gioiosa semplicità. Non mancano
cqnviti
all'uso greco, con la presenza di soli uomini, culminanti anche in
orge
piuttosto sfrenate, con abbondanti libazioni e balli (tomba delle
Iscrizioni
a Tarquinia). I banchetti solenni, come del resto anche altre
feste
(giuochi, funerali, ecc.), sono regolarmente accompagnati dalla musica
e
dalla danza. Le pitture della tomba Golini di Orvieto ci portano anche
nell
'interno delle cucine dove si preparano i cibi per il banchetto, anche
con
la presenza del suono forse magico-propiziatorio di un suonatore di
doppio
flauto.
Una notevole serie di rappresentazioni si riferisce a
giochi e a spettacoli
(tombe tarquiniesi degli Auguri, delle Olimpiadi, delle
Bighe, del Letto
Funebre, ecc., tombe dipinte e rilievi di Chiusi). È
evidente che l'influsso
ellenico domina su questo aspetto della vita etrusca;
ma si ha l'impressione
che il carattere agonistico e professionale dei
giuochi e delle gare greche
tenda a trasformarsi nel mondo etrusco in un
divertimento spettacolare.
Niente è più suggestivo ed interessante, a questo
proposito, del piccolo
fregio della tomba delle Bighe a Tarquinia, nel quale
il pittore ha
immaginato un grande campo sportivo o circo, visto spaccato
secondo i due
assi lungo e corto, con l'arena e le tribune lignee sulle quali
trovano
posto gli spettatori; nell'arena sono corridori con le bighe,
cavalieri,
coppie di lottatori e pugilatori, un saltatore semplice e con
l'asta, un
corridore armato (oplitodromo), giudici di gara ed altri
personaggi vari;
sulle tribune spettatori dei due sessi s'interessano nel
modo più vivace
all'esito delle gare, come mostra chiaramente la loro mimica
concitata. Non
è escluso che ad agoni sportivi partecipassero anche i membri
delle famiglie
più illustri. Va ricordato a tal proposito il gioco etrusco
della Truia
(ludus Troiae), che consisteva in una gara di corsa a cavallo
lungo una
pista intricata in forma di labirinto: esso è riprodotto nel
graffito di un
vaso etrusco arcaico e sappiamo che era ancora in uso al
principio
dell'impero come esercizio della gioventù romana. A gare
equestri
partecipavano assai probabilmente i giovani membri della stessa
nobile
famiglia proprietaria della tomba tarquiniese delle Iscrizioni. Il
rapporto
dei giochi agonistici con il mondo funerario è documentato, oltre
che
dall'evidenza delle tombe, dal passo di Erodoto (I, 167) relativo
alle
cerimonie espiatorie compiute dai Ceretani per il massacro dei
prigionieri
focei.
Accanto agli spettacoli di natura agonistica debbono
esser ricordati anche
quelli mimici, musicali, acrobatici e farseschi che
erano specificamente
attribuiti ad attori etruschi ricordati con il nome di
histriones o ludiones
(la forma etrusca corrispondente sarebbe tanasa(r),
fhanasa) e che furono
introdotti a Roma dall'Etruria nel 364 a.C. come «ludi
scenici» (Livio, VII,
2-3). Di fatto esistono non poche testimonianze
figurate di pitture, vasi
dipinti. bronzetti, che raffigurano personaggi in
costumi particolari,
talvolta mascherati, che partecipano a vere e proprie
rappresentazioni: le
quali sembrano essere per altro di carattere assai
vario, dall'esibizione
popolaresca di saltimbanchi ed equilibristi (come
nelle tombe dei Giocolieri
di Tarquinia e della Scimmia di Chiusi), a
qualcosa che può ricordare il
dramma satiresco e porsi al limite di un'azione
drammatica (ben diversa in
ogni caso dal genere della tragedia di imitazione
greca, senza dubbi
tardivo, di cui si è già fatto cenno). Va poi ricordato un
genere di giochi
più cruento, nel quale è forse da riconoscere
un'anticipazione dei
combattimenti gladiatorii, che del resto la tradizione
antica considerava di
origine etrusca (Ateneo, IV, 153) e comunque provengono
in Roma dalla
Campania anticamente etruschizzata. Può darsi che i giochi in
questione
nascano dall'uso funerario, come attenuazione dei sacrifici umani
che in
molte civiltà primitive accompagnano la morte di principi o di
personaggi
illustri; giacche nella lotta cruenta è lasciata al più forte o al
più abile
dei contendenti la possibilità di scampare alla propria sorte.
Un
combattimento di tal genere sembra rappresentato nella tomba degli Auguri
di
Tarquinia: un personaggio mascherato e barbato, designato con il nome
fhersu
(corrispondente al latino persona, da maschera»), con un cappuccio,
un
giubbetto maculato ed un feroce cane al guinzaglio, assale un
avversario
seminudo e con il capo avvolto in un sacco e armato di una
clava.
Quest'ultimo è presumibilmente un condannato che lotta in condizioni
di
inferiorità; ma è anche possibile che egli riesca a colpire il cane con
la
clava e abbia quindi alla sua mercè l'assalitore. Sulla natura e
sulla
funzione del personaggio con cappuccio, barba e giubbetto maculato
-
sicuramente un essere umano e non un dèmone come si credette in passato
-
esistono tuttavia notevoli incertezze dal momento che egli ritorna più
volte
altrove in figurazioni pittoriche (tombe del Pulcinella, delle
Olimpiadi,
del Gallo, forse della Scimmia: un nano o un bambino) in
atteggiamenti o in
contesti che nulla hanno a che vedere con la gara mortale
della tomba degli
Auguri. Sembra veramente che si tratti piuttosto di una
caratterizzazione
generica, e che possa addirittura parlarsi della più antica
«maschera» della
storia dello spettacolo italiano. Passando ora a considerare
i problemi
della vita economica e produttiva dell'Etruria antica, diremo che
è da
supporre che in origine le risorse degli abitanti del paese fossero
di
natura prevalentemente agricola e pastorale (a parte, ovviamente,
la
raccolta, la caccia e la pesca); ma presto esse dovettero
esser
rivoluzionate, almeno in alcune zone, dallo sfruttamento delle
ricchezze
minerarie, ed ulteriormente integrate dall'attività dei traffici
terrestri e
marittimi.
Un quadro sufficientemente esatto della produzione
etrusca nell'ultima fase
della storia della nazione ci è offerto dal noto
passo di Livio (XXVIII, 45)
sui contributi offerti a Roma dalle principali
città etrusche annesse o
federate per l'impresa oltremarina di Scipione
l'Africano durante la seconda
guerra punica. Ecco l'elenco delle prestazioni
fatte secondo le principali
risorse di ciascun distretto in materie prime e
prodotti:
Caere grano ed altri viveri
Tarquinia tela per le vele
delle navi
Roselle legname per la costruzione delle navi e grano
Populonia ferro
Chiusi legname e grano Perugia legname e
grano
Arezzo armi varie in grande quantità, utensili e
grano
Volterra scafi di navi e grano
Vediamo definirsi chiaramente
nelle zone meridionali e centrali i di-
stretti agricoli (Caere, Roselle,
Chiusi, Perugia, Arezzo, Volterra), alcuni
dei quali avvantaggiati anche
dallo sfruttamento dei residui grandi boschi,
mentre Populonia appare
esplicitamente indicata come centro siderurgico ed
Arezzo come città
industriale. La zona mineraria etrusca abbraccia
prevalentemente i territori
di Vetulonia (con le colline metallifere) e di
Populonia (con l'isola
d'Elba); ma ad essa dobbiamo aggiungere anche il
massiccio dei Monti della
Tolfa, dove si hanno tracce di antiche miniere non
più sfruttate. L
'estrazione dei metalli (rame, ferro, in minor grado piombo
e argento) da
questi territori risale forse anche in parte alla preistoria,
ma fu praticata
sistematicamente a partire dall'inizio dell'età del ferro.
La sua importanza
per la storia dell'Etruria arcaica è grandissima e in un
certo senso
determinante, come già sappiamo. Alla valorizzazione di queste
ricchezze
naturali si ricollega presumibilmente lo sviluppo stesso delle
città
tirreniche; mentre la minaccia e la pressione continua dei Greci sulle
coste
dell'Etruria è un segno dell'importanza che si annetteva al
possesso,
all'influenza o soltanto alla vicinanza delle zone minerarie. Non
ci sono
noti gli aspetti tecnici dell'estrazione e della prima lavorazione
dei
minerali, se non da pochi indizi di natura archeologica - quali
gallerie
scavate in alcune località delle colline metallifere e strumenti in
esse
rinvenute, forni, scorie della fusione del ferro nella zona di Populonia
- e
da poche notizie antiche, dalle quali ricaviamo ad esempio che Populonia
era
il primo centro di fusione del metallo grezzo estratto dalle
miniere
dell'Elba e luogo del suo smistamento e diffusione, ma probabilmente
non di
lavorazione ulteriore.
La produzione etrusca è in gran parte
influenzata della ricchezza di metalli
del territorio: ce ne accorgiamo dalle
armi, dagli strumenti, dalle
suppellettili di bronzo e di ferro che abbondano
nelle tombe. Soprattutto
notevoli sono le opere di metallotecnica artistica
trovate a Vetulonia, a
Vulci, a Bisenzio, nei dintorni di Perugia, a Cortona;
la fonte di Livio già
ricordata designa inoltre Arezzo (da cui proviene la
famosa Chimera). Il
ferro e il bronzo etrusco erano anche lavorati in
Campania, donde
probabilmente minerale grezzo e prodotti si diffondevano
verso il mondo
greco (Diodoro Siculo, v, 13). In Grecia erano rinomate le
trombe etrusche
di bronzo; un frammento di tripode del tipo di Vulci si
rinvenne
sull'acropoli di Atenen. Non debbono essere trascurati altri aspetti
della
produzione artigianale ed industriale, come la tessitura e la
lavorazione
del cuoio, specialmente per le calzature che erano note e certo
largamente
esportate nel mondo mediterraneo (Polluce, VII, 22, 86). La
produzione
corrente di stoffe, oggetti lignei, ceramiche (e soltanto di
queste ultime
ci resta nel nostro clima la totalità delle testimonianze, come
già detto)
fu inizialmente limitata ad un circuito familiare o di villaggio.
Gli scambi
si estesero con il progresso del lavoro artigianale specializzato
e con la
conseguente necessità di reciproche acquisizioni tra ambienti e
centri
diversi. Si passò quindi ai commerci esterni, terrestri e
soprattutto
marittimi, favoriti dalla domanda di oggetti di lusso e di
prestigio e
dall'offerta delle maggiori fonti di potenzialità economica, cioè
dei
metalli nell'ambito di una società aristocratica. Ma nel periodo aureo
dei
grandi traffici internazionali, cioè in età arcaica, la massa degli
scambi
avveniva, come già in precedenza accennato, essenzialmente per baratto
di
merci. Pezzi di rame grezzo (aes rude) e poi contrassegnato (aes
signatum),
come anche oggetti o spezzoni di oggetti lavorati, specialmente
asce,
poterono costituirsi quali intermediari di scambio; si aggiunga
l'argento
pesato secondo un piede ponderale originario del Mediterraneo
orientale
(detto, impropriamente, «piede persiano», di circa grammi 5,70),
che rimarrà
poi tipico del sistema ponderale delle monete etrusche.
La
coniazione di monete, che nel mondo greco risale al VII secolo,
resterà
fondamentalmente estranea alla concezione dell'economia etrusca: ciò
che può
considerarsi, se si vuole, un altro segno di primitivismo o di
arcaismo. Di
fatto le monete greche circolarono precocemente, insieme con gli
altri più
rozzi strumenti di scambio locali; e di esse si ebbe qualche
imitazione, in
oro (dubitativamente) e argento, in età arcaica. Ma di una
vera e propria
monetazione etrusca d'argento e d'oro non si può parlare se
non a partire
dalla metà del V secolo (cioè nell'età della relativa
recessione economica)
specialmente a Populonia, sotto l'influenza della
monetazione greca
dell'Italia meridionale e seguendo i sistemi ponderali
etrusco e calcidese.
Di fatto è la zona mineraria che sembra comporre in
Etruria la moneta, per
comprensibili ragioni di accelerazione e
moltiplicazione di scambio.
Soltanto più tardi, e non prima dell'affermarsi
dell'egemonia romana alla
fine del IV secolo, appariranno monete di bronzo
fuse (aes grave) e coniate.
Sappiamo che gli Etruschi avevano una tecnica
progredita nel campo della
ricerca, dello sfruttamento, del convogliamento
delle acque. La ricerca
delle acque era fatta dagli aquilices: specie di
rabdomanti. Plinio (Nat.
Hist. ,III, 20, 120) parla dei canali scavati dagli
Etruschi nel basso Po:
ed effettivamente in diverse zone dell'Etruria
tirrenica si riscontrano
sistemi di cunicoli di drenaggio che risalgono
all'età preromana e
dimostrano un'intensa applicazione di opere idrauliche a
scopo di bonifica e
di irrigazione. La vita nelle zone paludose della maremma
e del basso Po non
si spiegherebbe d'altro canto se fosse già stata diffusa,
durante il periodo
aureo della civiltà etrusca, l'infezione malarica: la
quale dovette appunto
cooperare, durante la tarda età ellenistica, ad
affrettare la decadenza di
molte città etrusche costiere. Al denso manto
boschivo che copriva tanta
parte dell'Etruria si suppone dovuto lo sviluppo
di una tecnica che abbiamo
ragione di ritenere caratteristica del mondo
etrusco (anche se le fonti
letterarie sono meno esplicite che per altre
peculiarità): vogliamo dire
l'arte della lavorazione del legno per la grande
carpenteria architettonica
e per l'ingegneria navale. Anche a questo
proposito sarebbe errato
trascurare i precedenti orientali e greci. Ma la
facilità della materia
prima deve pure aver avuto la sua importanza. In ogni
caso le tombe scavate
nella roccia ad imitazione di interni di case,
specialmente quelle della
necropoli di Cerveteri, suggeriscono le più varie e
ardite soluzioni
nell'impiego del legno per le costruzioni, soppiantato solo
tardivamente
dalla pietra. Va però tenuto conto della diffusione dei mattoni
crudi
nell'alzato delle pareti, in concomitanza con gli elementi lignei
dei
pilastri, delle porte e delle coperture. Un altro impiego fondamentale
del
legno è per le navi, da guerra ed onerarie, che costituirono lo
strumento
della potenza commerciale e politica etrusca, e che appaiono
rappresentate
in un grande numero di figurazioni di ogni età. Significativo,
a proposito
della tecnica costruttiva, è il ricordo degli scafi (interamenta)
forniti da
Volterra a Scipione come già si è visto, evidentemente fabbricati
in uno
degli scali marittimi volterrani. Per le forme evidentemente, come
desumiamo
dalle immagini, non ci si dovette scostare dai modelli greci;
leggendaria è
la notizia dell'invenzione dei rostri da parte di un Piseo
figlio di Tirreno
(Plinio, Nat. Hist.. VII, 56, 209); ma è curioso, ed unico
nel suo genere,
il modello di nave con prora a testa di pesce dalle cui fauci
fuoriesce una
lancia.
Le armi e
l'abbigliamento
Immagini di guerrieri singoli e scene di parate, duelli e
battaglie sono
frequentissime nei vasi e nei rilievi dell'Etruria arcaica.
Insieme con le
armi reali superstiti essi costituiscono una vasta
documentazione della
guerra e dell'armamento. Sull'arte etrusca della guerra
assai poco si rileva
dalla tradizione, che tuttavia suggerisce che
l'organizzazione militare
primitiva. dei Romani debba molto all'Etruria. Ma
anche per questa materia -
soprattutto ove si considerino le testimonianze
figurate - l'influenza della
tattica e dell'armamento dei Greci sembra
essersi affermata in modo
dominante soprattutto per quel che riguarda la
presenza della fanteria
oplitica, cioè dei guerrieri con armi pesanti, che
costituì verisimilmente
il nerbo dello stato cittadino arcaico. In origine si
combatteva sui carri,
forse più a lungo che in Grecia, se non c'inganna il
carattere mitologico di
molte figurazioni; comunque già a partire dal VII
secolo appare operante la
cavalleria. Tutto ciò premesso, non può trascurarsi
l'esistenza di fenomeni
che ricollegano il mondo etrusco specialmente nella
sua fase più antica a
tipi di armamenti presenti piuttosto nell'area europeo-
continentale che in
Grecia.
Armi offensive sono l'asta pesante con la
punta e il saurocter di bronzo o
di ferro, l'asta leggera o giavellotto, la
spada lunga - il cui uso sembra
cessare già in epoca arcaica, e che è
soltanto una sopravvivenza
dell'armamento della tarda età del bronzo - , la
spada corta o gladio, la
sciabola ricurva (machaira) in uso a partire dal VI
secolo, il pugnale,
l'ascia che in epoca antichissima è a due lame e, come
già si è accennato,
appartiene forse all'armamento dei capi. Armi difensive
sono l'elmo di
bronzo, lo scudo, la corazza, gli schinieri. Gli elmi
primitivi hanno una
forma ad apice o a calotta sormontata da cresta, o a
semplice calotta, o con
apice a bottone; assai per tempo si diffondono gli
elmi di tipo greco
corinzio. Ma la forma classica di elmo etrusco di bronzo è
una sorta di
morione talvolta sormontato da penne, di cui molti esemplari si
sono
rinvenuti nelle tombe etrusche (tipico uno degli elmi apparsi tra
gli
oggetti votivi del santuario ellenico di Olimpia, con
l'iscrizione
dedicatoria a Zeus del tiranno di Siracusa Gerone che li dedicò
come bottino
di guerra dopo la vittoria navale dei Greci sugli Etruschi
presso Cuma nel
474 a.C.); con il termine moderno di elmo tipo Negau lo si
incontra, con
varianti, diffuso largamente anche nell'Italia adriatica e
settentrionale e
nell'area alpina e slovena. Le corazze erano in origine di
tela, con borchie
rotonde o quadrangolari di metallo laminato; ma poi furono
lavorate
interamente di bronzo, del tipo ad elementi staccati o tutte di un
pezzo
riproducenti a sbalzo la muscolatura del tronco virile. Scudi rotondi
di
bronzo appaiono così in epoca arcaica come nel periodo più recente;
ma
alcune figurazioni ci rivelano anche forme di scudi ellittici o tendenti
al
quadrato, probabilmente di legno o di cuoio. Un cenno va fatto ai
bastoni
offensivi e difensivi, nei quali è forse da vedere un ricordo delle
antiche
clave usate nelle culture primitive: di essi appare qualche
testimonianza
nei monumenti arcaici, mentre il tipo del bastone ricurvo
all'estremità,
detto lituo, tende successivamente a diventare in modo sempre
più esclusivo
un'insegna sacerdotale, e come tale passa al mondo
romano.
Per quel che riguarda l'abbigliamento maschile e femminile e
le
acconciature, in mancanza di materiale direttamente conservato,
dobbiamo
servirci essenzialmente dei monumenti figurati, del resto abbondanti
e
ricchi di particolari. Naturalmente il clima influisce sul vestiario
non
meno delle tradizioni locali; ma la moda dei prototipi diffusi dal
mondo
greco ebbe anche in questo campo un'azione determinante. La
consuetudine
prettamente mediterranea della seminudità maschile è ancora
viva
nell'Etruria arcaica; le piccole figurazioni plastiche del
periodo
villanoviano ci mostrano anzi addirittura numerosi esempi di nudità
completa
maschile e femminile, ma non sappiamo fino a che punto essa risponda
alla
realtà della vita quotidiana (nell'arte essa è assai meno frequente che
in
Grecia).
Comunque ancora in piena civiltà del VI e V secolo gli
uomini, specie
nell'intimità domestica, andavano a torso nudo; e quest'uso
tradizionale si
riflette nel costume "eroico" del defunto banchettante delle
figure scolpite
sui coperchi dei sarcofagi e delle urne di età ellenistica.
Completamente
nudi appaiono soltanto servi ed atleti, ma neppur sempre. Un
ampliamento
dell'originario perizoma bordato che copriva i fianchi è
costituito dal
giubbettino che riveste anche il petto, ed è di moda negli
ultimi anni del
VI secolo. Ad esso poi si sostituirà la tunica, imitata dal
chitone dei
Greci. Ma il secondo elemento tipico del costume maschile è il
manto di
stoffa più pesante e colorata, già diffuso in epoca arcaica.
Con
l'accrescersi dell'entità del vestiario il manto acquisterà un
'importanza
sempre maggiore, fino ad aumentare di ampiezza e ad arricchirsi
di
decorazioni dipinte o ricamate, diventando la veste nazionale
degli
Etruschi, la tèbennos, dalla quale discende in via diretta la toga
romana.
Le donne e le persone anziane vestono fin dai tempi arcaici una
tunica in
forma di camicia lunga fino ai piedi di stoffa leggera pieghettata
o
decorata sui bordi, alla quale si sovrappone il manto dipinto di stoffa
più
pesante. È da notare, per un periodo che va dalla fine del VII al
principio
del V secolo, l'uso di stoffe con un disegno a rete che si suppone
lavorato
a ricamo e che s'incontra sui monumenti così nelle tuniche
(statuetta di
Caere al Campidoglio, vasi cinerari chiusini) come nei mantelli
(situla
della Certosa).
Fin dall'epoca più antica si osservano una cura ed
un interesse particolare
degli Etruschi per le calzature. Le tombe arcaiche
di Bisenzio hanno
restituito sandali in forma di zoccolo ligneo snodato con
rinforzi di
bronzo. I calzari potevano essere di cuoio e di stoffa ricamata.
La forma
tipica in uso nel VI secolo è quella allungata in alto dietro il
polpaccio e
con punta rialzata davanti, cioè i così detti calcei repandi di
origine
greco-orientale, dei quali alcune caratteristi- che sopravvivono
ancora
nelle ciocie dei montanari dell'Italia centrale. Anche più tardi,
accanto ai
sandali bassi, sono in uso gli alti stivaletti: queste diverse
fogge
passano, quasi senza mutamenti, al costume romano.
Sul capo era
portato nel VI secolo un tipo di berretto o sacchetto a cupola
di stoffa
ricamata, comune così agli uomini come alle donne, e con diverse
varianti, il
così detto tutulus, anch'esso di origine orientale, ionica, ma
divenuto
caratteristico del costume etrusco; Altre forme di copricapi sono
il berretto
a punta rigida o a cappuccio di alcuni speciali personaggi (ad
esempio il già
citato persu della tomba degli Auguri), sacerdoti e divinità;
il berretto di
lana o di pelle con base larga e punta cilindrica portato
dagli aruspici ed
attestato in diversi monumenti; e infine il cappello a
larghe falde alla
greca (pètasos) che sembra particolarmente diffuso
nell'Etruria
settentrionale (figure di terracotta della decorazione
architettonica di
Poggio Civitate di Murlo, flautista della tomba della
Scimmia di Chiusi),
come del resto nell'Italia del nord (arte delle situle).
Ma generalmente così
gli uomini come le donne andavano a capo scoperto; e
questa è l'usanza che
diviene predominante a partire dal V secolo.
Dapprima gli uomini sono barbati
e portano i capelli lunghi spioventi sulle
spalle; ma già dalla fine del VI
secolo i giovani vanno rasi e con i capelli
corti, secondo la moda greca. La
barba scompare quasi del tutto a partire
dal III secolo a.C. (e non tornerà
di moda in Italia se non quattrocento
anni più tardi, ai tempi
dell'imperatore Adriano). Le donne nei tempi più
antichi (VIII-VI secolo)
recano i capelli lunghi pioventi a coda annodati o
intrecciati dietro le
spalle: successivamente li lasciano cadere a boccoli
sulle spalle e infine
(VI-V secolo) li annodano a corona sul capo o li
raccolgono in reticelle o
cuffie. È notevole la probabile moda di sbiondire
le chiome, che parrebbe
attestata dalle pitture della tomba dei Leopardi di
Tarquinia. Nel IV secolo
prevale una pettinatura a riccioli cadenti ai lati
del volto. Più tardi, in
piena età ellenistica, si preferisce il ciuffo
annodato sulla nuca, alla
greca. Grande importanza nel costume etrusco hanno
i gioielli. Alla fine
dell'età del bronzo si diffonde largamente per tutto
il mondo mediterraneo
l'uso delle spille di sicurezza, le fibule, che sono
fra gli oggetti più
caratteristici delle tombe dell'età del ferro. Quelle
usate dagli uomini si
distinguono da quelle femminili per l'arco spezzato e
serpeggiante. Le fibule
si confezionano generalmente di bronzo, ma anche di
metalli preziosi e
riccamente adorne con pezzi di pasta vitrea e d'ambra:
alcuni esemplari di
età orientalizzante, come la fibula aurea a disco della
tomba
Regolini-Galassi, sono di proporzioni colossali e
sfarzosamente
decorate.
L'uso delle fibule si attenua nel VI secolo e
cessa quasi del tutto dopo il
V: si conserva soltanto in costumi
tradizionali, come quello dei sacerdoti
aruspici. Altri tipi di gioielli sono
i diademi, gli orecchini, le collane,
i braccialetti, gli anelli. Nel periodo
orientalizzante lo sfarzo del loro
impiego ha un aspetto barbarico: e lo
stesso si può dire per l'età
ellenistica. Il solo periodo in cui i gioielli
furono impiegati dagli
Etruschi, e specialmente dalle donne, con parsimoniosa
eleganza è la fase
aurea del VI-V secolo: ad essa si attribuiscono magnifici
esemplari di
collane con bulle o ghiande ed orecchini lavorati con la
raffinata tecnica
della granulazione.
La
medicina
La perizia degli Etruschi nell'Arte Medica era celebre e gli
antichi
scrittori Greci e Romani ne parlano soprattutto riguardo alla
conoscenza
delle proprietà officinali delle piante. Per conoscere il grado
di
preparazione raggiunto dai "medici" etruschi ci viene in
aiuto
l'Archeologia: il rinvenimento di numerosi ex voto in terracotta o
bronzo
raffiguranti anche organi interni del corpo umano denota chiaramente
l'
estrema abilità anatomica di questo popolo; così come la presenza
di
numerosi ferri da chirurgo e da dentista nel corredo di alcune tombe.
Nel
Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia è conservato un teschio umano
che
reca una protesi dentaria in oro, prova dell'abilità dei dentisti.
Grande
importanza avevano poi le acque termominerali, di cui la Tuscia è
ancora
oggi ricchissima: gli Etruschi conoscevano bene le proprietà
medicamentose
di ogni sorgente, sacra e dedicata a divinità diverse, così
come i Romani i
quali, con la conquista di queste terre, eressero spesso
grandi impianti
termali alimentati dalle preziose acque di queste
sorgenti.
L'Arte
La letteratura ed i libri
Le musiche e la danza
La
scultura
La pittura
Finalità, condizionamenti e tendenze
Arte
profana
I monumenti architettonici
Il problema dell' «arte
etrusca»
La letteratura ed i libri
Per molti
aspetti la civiltà degli Etruschi, pur appartenendo ad un'età
pienamente
storica, deve essere considerata e studiata alla stregua di una
civiltà
preistorica, vale a dire essenzialmente nelle sue testimonianze
esteriori e
materiali. Manca infatti la luce diretta di una grande
tradizione letteraria
originale che ci consenta di penetrare profondamente
nel pensiero, nei
sentimenti e nelle concezioni di vita di questo popolo,
come invece è
possibile per altre genti del mondo classico. Le notizie
indirette,
collaterali o tardive, che scrittori greci e romani ci hanno
lasciato
sull'Etruria antica e gli stessi documenti scritti etruschi (che
consistono
per lo più di brevi iscrizioni, non tutte facilmente
interpretabili) offrono
senza dubbio preziosi elementi di informazione: lo
si è visto a proposito
dell'organizzazione politico-sociale e della
religione. Ma essi non possono
in nessun modo compensarci della mancanza di
una letteratura nazionale con
opere poetiche, storiche, filosofiche, quali
ci sono state conservate per la
Grecia e per Roma.
Ciò per altro non significa che gli Etruschi non abbiano
avuto una loro
propria letteratura. Il fatto che essa non sia giunta fino a
noi non è un
argomento valido per escluderla. Noi possediamo la letteratura
greca e
quella latina quasi esclusivamente perche esse ci furono
tramandate
attraverso una tradizione ininterrotta, di copista in copista,
durante i
secoli del medioevo (i testi antichi su papiri dissotterrati
dagli
archeologi e i documenti epigrafici hanno una importanza
relativamente
secondaria). Ma se le opere degli scrittori classici furono
copiate e
trasmesse fino ai tempi moderni, ciò si deve al fatto che esse
erano scritte
in lingue universalmente note e vive (a parte ogni altra
considerazione
sull'importanza essenziale di queste opere per la costruzione
stessa della
cultura del mondo occidentale). Viceversa gli scritti originali
dei popoli
dell'ltalia preromana, tra cui gli Etruschi, avevano perduto ogni
interesse
sin dall'età romana imperiale, essendo redatti in lingue non più
parlate e
presumibilmente incomprensibili a tutti, fatta forse eccezione per
qualche
erudito. È chiaro che a nessuno poteva venire in mente di ricopiarli
e
conservarli per le generazioni future.
Una certa forma di attività
letteraria degli Etruschi è, in vero,
testimoniata positivamente, per quanto
in modo indiretto, dal ricordo che ne
sopravvive nelle fonti greco-latine. Si
tratta di notizie frammentarie che
riguardano soprattutto I' esistenza di
libri a contenuto religioso,
conosciuti attraverso traduzioni o compendi
negli ambienti sacerdotali ed
eruditi romani. Sappiamo che essi erano
classificati in tre fondamentali
raggruppamenti, sotto il nome di Libri
Haruspicini, Libri Fulgurales e Libri
Rituales. I primi trattavano della
divinazione mediante l'esame delle
viscere degli animali; i secondi
contenevano la dottrina dei fulmini. Quanto
ai Libri Rituali, sembra che essi
abbracciassero una materia assai più vasta
e complessa, riguardante le norme
del culto, le modalità per la
consacrazione dei santuari, per la fondazione
delle città, per la divisione
dei campi, gli ordinamenti civili e militari,
ecc.; comprendevano inoltre
scritti speciali sulla divisione del tempo e sui
limiti della vita degli
uomini e dei popoli (Libri Fatales), sul mondo
dell'oltretomba e sui riti di
salvazione (Libri Acherontici) e infine sulla
interpretazione dei prodigi
(Ostentaria).
La tradizione etrusco-romana
tende ad attribuire a queste opere una origine
antichissima e veneranda:
tanto che una parte di esse era addirittura
riferita agli insegnamenti del
genietto Tagete (Libri Tagetici:
corrispondenti, per quanto sappiamo, ai
Libri Aruspicini e agli Acherontici)
o a quelli della ninfa Vego(n)ia o
Begoe, cui si assegnavano i Libri
Fulgurali e gli scritti di agrimensura
contenuti nei Libri Rituali. In
sostanza si credeva in una loro ispirazione
divina, facendone risalire
l'origine ad una specie di primordiale
"rivelazione" che si identificava con
le origini stesse della civiltà
etrusca. E non è da escludere che la
raccolta dei libri sacri, quale si
conosceva neg.i ultimi secoli della vita
del popolo etrusco e quale fu,
almeno parzialmente, tradotta in latino,
comprendesse elementi di formazione
assai antica. Ma nel complesso il
carattere essenzialmente normativo degli
scritti sembra riflettere piuttosto
una fase evoluta e forse finale dello
sviluppo spirituale e religioso della
società etrusca. Si può immaginare che
la loro elaborazione definitiva e,
per così dire, "canonica" abbia avuto
luogo nell'ambito di ristrette cerchie
sacerdotali, come l'ordine dei
sessanta aruspici fiorente ancora a Tarquinia
in età romana: un mondo al
quale senza dubbio appartenne quel Tarquitius
Priscus (o Tuscus ?), al quale
la tradizione romana attribuiva la
composizione, la volgarizzazione e la
traduzione in latino di diversi libri
sacri. Con questo siamo portati a
considerare la natura stessa della
letteratura religiosa etrusca. Essa aveva
probabilmente un aspetto vario ed
eterogeneo, con parti poetiche o almeno
redatte metricamente (carmina) ed
altre minuziosamente rituali e
prescrittive: delle quali ultime è possibile
formarsi direttamente un'idea
considerando testi originali etruschi
superstiti, quali il manoscritto della
mummia di Zagabria o la tegola di
Capua.
Si è già, anzi, accennato ad un'
eventuale connessione fra il rituale
funerario di Capua e i Libri
Acherontici. Nel suo complesso il corpo dei
libri sacri doveva avere una
ispirazione fondamentale religiosa, ma nello
stesso tempo anche un certo
carattere giuridico. Era un trattato di dottrine
sacrali e insieme una
costituzione ed una collezione di leggi, anche profane
(ius Etruriae).
Carattere del tutto particolare, profetico e insieme
etico-giuridico, ha il
frammento di testo tramandato dai gromatici latini
con l'insegnamento della
ninfa Vegoia (cioè la Lasa Vecui) ad Arunte
Veltimno (che sarà stato in
etrusco un Arnth Veltimna, presumibilmente di
Chiusi o di Perugia), in cui si
parla di punizioni per appropriazioni di
terre altrui mediante lo spostamento
dei segnali di confine, da parte di
servi o anche con l'acquiescenza dei loro
padroni: punizioni consistenti
nell'insorgere di morbi e in catastrofi
naturali, minacciate verso la fine
dell'VIII secolo (naturalmente etrusco,
che secondo attendibili computi di
altre fonti sarebbe da collocare nell'anno
88 a.C.). Il passo termina con
l'esortazione: Disciplinam pone in corde tuo
(metti nel tuo cuore la
disciplina). Si suppone che lo scritto sia stato
ispirato in età sillana da
ambienti conservatori etruschi di fronte al
pericolo di riforme agrarie e di
sovvertimenti sociali.
Resta il problema
se gli Etruschi abbiano avuto altre forme di attività
letteraria e sino a
qual punto tali manifestazioni si siano svolte in modo
autonomo rispetto alla
letteratura sacra. L'esistenza di documenti
annalistici o storici sembra
accertata dal ricordo di Tuscae historiae
citate da Varrone (Censorino, de
die nat., 17, 6). Mancano invece del tutto
riferimenti ad una narrativa epica
o mitologica: pur non escludendosi la
possibilità che questo genere sia stato
coltivato in Etruria, giova rilevare
che la mentalità degli Etruschi non
sembra portata alla feconda inventiva
mitografica propria dei Greci. Salvo
rare eccezioni, l'arte figurata imita e
rielabora soltanto le saghe divine ed
eroiche accolte dal mondo greco. Che i
carmi conviviali e le satire
fescennine (la cui origine si riportava alla
città falisca di Fescennio)
avessero paralleli in Etruria è possibile, ma
non documentabile con certezza.
Di elogi cantati in onore di personalità
defunte s'intravvedono invece
riflessi in alcune iscrizioni funerarie più
lunghe e forse a struttura
metrica o ritmica. La poesia drammatica, cui si
riporta il ricordo di una
certo Volnio autore di tragedie etrusche, nasce
probabilmente soltanto in
epoca tarda come imitazione del teatro greco.
Le musiche e la
danza
Si è più volte rilevata, nei testi etruschi, la presenza di
raggruppamenti
regolari di parole e di sillabe, ripetizioni, allitterazioni,
rime, ecc. ,
che denunciano una forte disposizione alla forma ritmica. Non
abbiamo invece
finora dati sicuri per la individuazione di una metrica
quantitativa, come
nei versi greci e latini. Ma è in ogni caso assai
probabile che le
iscrizioni dedicatorie, specialmente arcaiche, ed alcune
iscrizioni
funerarie fossero verseggiate, come era uso frequente presso i
Greci e i
Romani.
danzatrice etrusca Ovviamente metrici e cantati
erano i carmi sacri, inni o
preghiere, e forse anche quelli di contenuto
profano. La musica accompagnata
dal canto, ma specialmente quella senza
canto, deve aver avuto grandissima
importanza nelle cerimonie e nella vita
pubblica e privata degli Etruschi, a
giudicare dalla testimonianza concorde
delle fonti letterarie e dei
monumenti figurati.
Gli strumenti (e di
conseguenza anche il ritmo, l'armonia, le disposizioni
melodiche) sono
manifestamente gli stessi che troviamo nel mondo musicale
dei Greci: una
identità che non sorprende, se si tien conto degli stretti
rapporti di
dipendenza che legano le città etrusche alla civiltà ellenica
per tanti altri
aspetti.
Fra gli strumenti a corda, rappresentati o ricordati, sono la cetra,
la
lira, il barbiton; fra gli strumenti a fiato, il doppio flauto (tibiae) e
la
tromba diritta (salpinx, tuba) o ricurva (cornu); fra quelli a
percussione,
i crotali delle danzatrici. Il duo del suonatore di cetra (o
lira, o
barbiton) e del suonatore di doppio flauto costituisce, come in
Grecia, un
accoppiamento normale: lo vediamo rappresentato con particolare
frequenza
nelle scene di banchetto o di danza delle pitture funerarie.
Eppure,
nell'ambito di una comune civiltà musicale l'Etruria deve aver avuto,
così
nei generi come nella pratica, certe sue particolari tendenze e
tradizioni.
Non può trascurarsi l'insistenza con la quale gli scrittori
antichi parlano
dell'impiego del doppio flauto presso gli Etruschi, quasi di
uno strumento
nazionale derivato dalla Lidia e poi trasmesso dagli Etruschi
ai Romani: il
flautista o auleta si chiamava a Roma, con nome derivato
dall'etrusco,
subulo. In verità l'auletica è un genere largamente diffuso in
Grecia, ma
attribuito originariamente ai Frigi ed ai Lidi: esso risponde ad
un gusto
musicale per il patetico e per l' orgiastico.
Anche in questo
caso, come in altre manifestazioni della civiltà artistica,
gli Etruschi
avrebbero accolto dalla complessa esperienza ellenica certi
elementi più
vicini alla loro sensibilità, orientandosi specialmente verso
le forme
elaborate nelle città greco-orientali dell'Asia Minore. Logicamente
dobbiamo
supporre che la musica etrusca preferisse quei «modi» che i teorici
greci
definivano lidio, ipolidio, frigio e ipofrigio, con i relativi
sistemi
tonali, in contrapposizione con la grave e solenne musica dorica.
D'altro
canto la tradizione greca, antica e concorde (Eschilo, Eumen., 567
sgg.;
Sofocle, Aiace, 17; Euripide, Fen., 1377 sgg., ecc.), attribuisce
agli
Etruschi la tromba: salpinx. Pur non significando che questo
antico
strumento sia stato inventato realmente in Etruria, ciò vuol dire che
esso
era caratteristico delle costumanze militari e forse anche
religiose
etrusche, ed eventualmente fabbricato ed esportato da botteghe di
bronzisti
etruschi (ma i monumenti figurati rappresentano di preferenza la
tromba
ricurva, il corno, o diritta con la sua estremità ricurva come il
lituo). In
ogni caso il favore accordato agli strumenti a fiato corrisponde
ad un
notevole sviluppo delle pratiche musicali distaccate dal canto.
La
musica non soltanto si collega con la danza e con la mimica nelle
grandi
celebrazioni religiose e nelle manifestazioni sceniche, ma
sovente
accompagna singoli momenti del rito ed azioni della vita pubblica e
privata,
come le gare sportive, la caccia, la preparazione dei banchetti e
persino
la fustigazione degli schiavi. Questo rapporto della musica piuttosto
con il
gesto che con la parola trova il suo parallelo nelle forme peculiari
degli
spettacoli scenici etruschi, che avevano, per quanto sappiamo (Livio,
VII,
2, 4 sgg.), carattere di mimo ed erano rappresentati da
attori-danzatori
mascherati (histriones o ludiones), talvolta anche con
allusioni buffonesche
e satiriche. Ciò non esclude la possibilità di vere
azioni drammatiche
dialogate, certamente favorite, a partire dal IV secolo,
dall'influsso delle
forme del teatro greco (come attestano i frequenti
modellini di maschere
comiche trovati nelle tombe etrusche).
La danza ci è
nota soprattutto dalle figurazioni funerarie del VI e del V
secolo. Sembra di
regola eseguita da ballerini professionali: danzatrici
singole accompagnate
da un suonatore di doppio flauto; danzatori a coppia;
ma soprattutto cori di
uomini e donne procedenti in fila distaccati e con
movimenti individuali,
guidati da musici (suonatori di cetra o lira e
flautisti) forse in funzione
di corifei. I musici partecipano ai passi della
danza. Qualche volta si
colgono nell'atto di ballare anche personaggi della
classe gentilizia alla
quale apparteneva la famiglia del defunto. I
movimenti saltellanti delle
gambe e i gesti accentuati e presumibilmente
rapidi delle braccia e della
testa rivelano un genere di danza fortemente
scandito, agitato se non
addirittura orgiastico, che si ispira
presumibilmente alla greca sikinnis di
origine dionisiaca. Ma i documenti
limitati nel tempo e nell'ambito dell'arte
funeraria non sono sufficienti a
provare che questo genere sia stato il solo
coltivato in Etruria. Esso,
comunque, si accorda con i «modi» musicali che
abbiamo supposto dominanti
nel mondo etrusco.
La
scultura
Primi e assai caratteristici documenti della plastica etrusca
sono, già a
partire dal VII sec., i canopi, ossia vasi cinerari di bronzo e
di argilla
dal corpo panciuto, con il coperchio interamente a foggia di testa
umana.
Talvolta al vaso erano applicate due braccia, in luogo delle anse, ed
il
tutto era collocato su di una sorta di tronetto circolare. Abbiamo poi
i
grandi sarcofaghi fittili, in forma di letto conviviale, sul quale
si
trovano una o due persone recumbenti, in atto di partecipare al
proprio
banchetto funebre. Nel Sarcofago degli Sposi sono visibili alcuni
elementi
di derivazione ionica: l'acconciatura dei capelli, la finezza dei
volti, la
levigatezza delle superfici. Ma tutto è interpretato in
maniera
anticlassica.
La posizione stessa della coppia sposta il peso
verso destra, rompendo
l'equilibrio della composizione. Tutto è spigoloso: i
volti triangolari, i
menti aguzzi, gli occhi a mandorla. Il sorriso, invece
dell'impertubabile
serenità greca, esprime piuttosto qualcosa di ironico.
Anche l'Apollo di
Veio mostra rapporti con la scultura ionica, non solo
nell'acconciatura dei
capelli e nel sorriso, ma anche nella veste
pieghettata.
Apollo di Veio
Lupa Capitolina
Ma le somiglianze
sono solo esteriori. La veste, a pieghe larghe e pesanti
aderisce al corpo,
sembra frenare il passo veloce del dio, il quale nel
volgersi, compie, con la
gamba sinistra uno sforzo muscolare tale che il
polpaccio si avvolge come una
molla pronta a scattare. La linea ionica,
persa la sua eleganza raffinata,
diventa mezzo per esprimere violenza. Lo
stesso sorriso, per lo spessore
delle labbra taglienti, si trasforma in un
ghigno beffardo. Una delle opere
di più alto valore della scultura bronzea
etrusca è la Lupa Capitolina. In
essa, l'animale, ferocemente ringhiante, è
rappresentato saldamente poggiato
sulle quattro zampe, con la testa rivolta
verso lo spettatore. Sono poche le
somiglianze con una lupa autentica, non
soltanto per la forma anatomica, ma
perfino per l'assenza quasi totale del
manto peloso, che permette di far
risaltare la potente struttura ossea, lo
smagrimento del ventre, la vena
gonfia sul muso, le mammelle. Il pelo,
limitato a una striscia che riveste il
collo possente, non è morbido, ma
bensì squamoso e duro ed esalta perciò
l'asprezza che emana da tutta la
statua.
Chimera di
Arezzo
Bruto Capitolino
Vaso Canopo
Un'altra scultura bronzea
di grande importanza è la Chimera di Arezzo, il
mitico mostro con il corpo di
leone, la coda anguiforme e, sporgente dal
dorso, una testa di capra ferita.
La bestia è rappresentata con il muso
minaccioso rivolto in alto, verso
l'avversario. Tutti i muscoli sono tesi,
le costole sporgono dal torace, le
unghie, allungate come artigli,
fuoriescono dalle dita. I peli, anche qui
limitati a rivestire solo alcune
zone del corpo, si drizzano come aculei. Tra
la ritrattistica scultorea
abbiamo il Bruto Capitolino, che per alcuni è
etrusco, per altri romano.,Il
ritratto è fortemente tipizzato ed esprime la
severità morale del
personaggio. Il movimento delle ciocche ineguali dei
capelli e della barba
non curata, i piani facciali irregolari e chiaroscurati
per le forti
sporgenze e rientranze e, soprattutto la terribile intensità
degli occhi
fissi, rendono la complessa psicologia dell'uomo. Accanto al
Bruto
Capitolino, di cui ci è pervenuto solo il busto, l'unico esempio intero
di
ritratto bronzeo etrusco è il cosiddetto Arringatore del Trasimeno. Egli
non
è il giovane armonicamente strutturato dei greci. Le rughe che solcano
il
volto sulla fronte e alle estremità degli occhi, indicano un uomo di
mezza
età. Il viso, relativamente piccolo e sostenuto dal collo robusto e
lungo, è
sobrio, concentrato nel pensiero e nell'esposizione verbale. Il
braccio
alzato e la mano proporzionalmente più grande del naturale
sottolineano
l'importanza di un passo del discorso: l'oratore parla a un
vasto uditorio
che, attraverso il suo gesto, deve intuire i concetti, prima
ancora che
comprenderli con la ragione.
Continua>
|
|
|
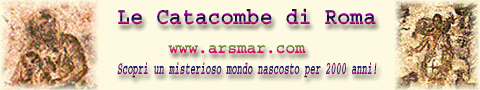
|
|
|
|
|
 | |