 |
|
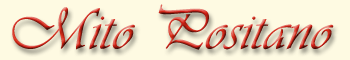 |
|
LA LETTERATURA
LATINA
|
|
|
|
LETTERATURA LATINA -
SECONDA PAGINA |
Pagina precedente
Cecilio Stazio
(230/220 - 168 a.C.)
VITA, OPERE,
CONSIDERAZIONI.
L'opera di S. attenuava, agli occhi degli antichi, il
contrasto tra Plauto e
Terenzio, così netto e istruttivo ai nostri occhi,
poiché ci rivela
l'evoluzione della mentalità pubblica tra gli anni della II
guerra punica e
quelli delle conquiste orientali.,
Gallo di Milano,
schiavo, era stato allevato a Roma, poi affrancato. Divenne
amico di Ennio, e
fu legato all'attore Ambivio Turione.
Di gusti più letterari di Plauto,
imitava di preferenza le opere di
Menandro, il più conforme ai canoni
classici fra i poeti della "commedia
nuova". Sotto questo riguardo,
anticipava Terenzio, pur conservando alle
proprie commedie un "movimento"
paragonabile a quello di Plauto (grande
ricchezza di metri, vis comica, gusto
per il farsesco). Giudicato in seguito
scrittore piuttosto mediocre, si
pensava che avesse introdotto della
profondità (gravitas) nelle sue commedie.
Come Terenzio, S. "fa riflettere".
Delle sue opere non conosciamo che alcuni
titoli, 40 per l'esattezza (in
parte greci, in parte latini), tutti di
palliate: Meretrix ("La
cortigiana"), Portitor ("Il doganiere"), Pugil ("Il
pugile"), Epistula ("La
lettera"), Exul ("L'esule"), Fallacia, ("L'inganno"),
eccetera.
LE ORIGINI DELLA STORIOGRAFIA ROMANA.
In modo
abbastanza paradossale, sembra che l'influenza dell'ellenismo abbia
avuto
sulla formazione della prosa latina un ruolo più importante che
nella
formazione della poesia. Questa prosa fece la sua prima apparizione
in
coincidenza con la II guerra punica, allorché si avvertì il bisogno
di
opporre agli storiografi greci che si trovavano nel campo di Annibale,
una
storiografia d'impronta nazionale.
E' significativo, a questo
proposito, che il primo storico romano, Q. Fabio
Pittore (vissuto all'incirca
fra il 260 e il 190 a.C.), abbia composto la
sua opera storica ("Rerum
gestarum libri": a carattere annalistico, dalla
fondazione di Roma alla fine
della II guerra punica) sia in greco che in
latino (salvo che addirittura
l'opera non si limitasse in origine
all'edizione greca, e che la versione
latina non sia altro, perciò, che un
semplice rimaneggiamento successivo):
ciò rispondeva alla necessità di
raggiungere un pubblico di ambito appunto
mediterraneo e significò una
rottura con la tradizione della cronaca
pontificale, da cui pur erano tratti
strutture e materiali.
P. apparteneva
alla gens Fabia. Senatore e magistrato, aveva combattuto i
Galli Insubri.
Ebbe l'incarico di un'ambasciata sacra a Delfi nel 216, dopo
la battaglia di
Canne, per riannodare i rapporti esistenti da molto tempo
fra Roma e il dio
(si pensava, sicuramente, che nessuno meglio di lui
avrebbe potuto perorare
la causa di Roma nei confronti del mondo greco, del
quale Delfi era uno dei
centri spirituali).
Nella sua opera, dunque, rappresenta il punto di vista
aristocratico, da cui
l'acceso nazionalismo e il gusto antiquario: notevole
così l'interesse per
le origini di Roma, per l'età regia e per gl'inizi della
Repubblica (epoche
alle quali si facevano risalire molte istituzioni,
costumi, usanze religiose
e civili).
E' assai verosimile supporre che
Pittore e il suo contemporaneo L. Cincio
Alimento (di famiglia plebea,
senatore e magistrato, combattente della II
guerra punica) autore anch'egli
di una storia annalistica di Roma dalle
origini in lingua greca (storia che
si distingue per obbiettività e capacità
di analisi), abbiano subito
l'influenza della storiografia ellenica, e in
particolare quella degli
storici siciliani, che a Siracusa, città con la
quale a partire dalla prima
guerra punica si erano stabiliti rapporti
profondi e amichevoli, erano stati
numerosi e brillanti.
Timeo di Tauromenio, fra gli altri, può essere
considerato uno dei "padrini"
della giovane storiografia romana. L'opera dei
primi annalisti romani è
andata quasi interamente perduta. Le poche notizie
di cui disponiamo
provengono tutte da citazioni di autori più tardi e
dall'uso che delle loro
opere è stato fatto da Tito Livio. Su quali documenti
operavano questi primi
storiografi?
Possiamo unicamente immaginarlo, ed è
questa la ragione fondamentale della
grande varietà di ipotesi fatte, al
riguardo, dagli studiosi moderni. Per
alcuni, questi disponevano solo di
leggende elaborate dall'orgoglio
nazionale o, più di frequente, dall'orgoglio
delle famiglie nobili.
L'indigenza degli archivi di Stato (che, per giunta,
sarebbero andati
distrutti durante l'incendio di Roma ad opera dei galli nel
390 a.C. e
sarebbero stati ricostituiti successivamente alla meno peggio),
l'incertezza
stessa dell'elenco dei consoli dei primi secoli, tutto ciò
avrebbe
contribuito a far sì che i primi storici costruissero vicende in gran
parte
inventate, colmando le lacune con racconti favolosi forniti dalle
epopee
popolari (carmina convivalia), con l'aiuto di "ricalchi" immaginati
a
partire da circostanze posteriori o con anticipazioni anacronistiche. Tale
è
stata e rimane l'opinione dei moderni "ipercritici". Ma nei casi,
piuttosto
rari, nei quali l'archeologia ha potuto stabilire un qualche
riscontro (come
sul problema delle origini di Roma, quello delle tradizioni
dei re,
eccetera), i fatti tramandati dalla tradizione annalistica si sono
rivelati
più solidi di quanto si potesse immaginare.
Quinto
Ennio
(239 a.C. Rudiae vicino Lecce, Messapia)
VITA.
Uno dei massimi
esponenti del circolo scipionico fu E. che, dagli autori
successivi sarà
considerato pater. Egli nacque in una città non greca ma
messapica: tutta la
zona era comunque ellenizzata ed E. si vantava di
possedere la "tria corda",
tre anime, per la sua conoscenza di tre lingue:
latino, greco e
osco.
Combattè nella II guerra punica, e nel 204 a.C. era in Sardegna
negli
ausiliari romani, dove incontrò Catone il censore, che notò il suo
spessore
culturale e lo condusse a Roma. Catone in seguito diventerà il più
feroce
antagonista degli scipioni e cercherà di contrastare la
dilagante
ellenizzazione e di difendere i mos maiorum, i costumi.
Giunto a
Roma, E. entrerà in contatto con l'Africano e gli dedicherà un'
opera,
"Scipio".
Nel 186 a.C., E. seguirà Marco Fulvio Nobiliore contro gli Etoli e
assisterà
alla conquista di Ambragia. L'intento era quello di narrare ed
esaltare le
sue imprese, usanza questa tipicamente greca. E. compose anche
una tragedia
in onore del magnate, "Ambragia".
Nel 184 a.C. il figlio di
Nobiliore, Quinto Fulvio, fondò la colonia di
Pesaro e concesse ad E. delle
terre e la cittadinanza. Con grande orgoglio
scriverà: "Nos summus Romani qui
fumus ante Rudini". Nell'ultima parte della
sua vita si dedicò alla fatica
degli "Annales".
OPERE.
*E. compose molte sceneggiature sia
drammatiche che comiche (mediocri); fu,
tra l'altro, l'ultimo poeta latino a
coltivare assieme commedia e tragedia.
Nella produzione drammatica, puntava
sulla tensione stilistica dei suoi
versi e sulla ricerca del pathos. Il
modello era Euripide: la rielaborazione
dei modelli classici permetteva di
creare effetti di scena e di rafforzare
gli elementi drammatici della
rappresentazione. Un altro punto su cui E.
fondava la propria forza era la
partecipazione emotiva degli spettatori: le
sue tragedia dovevano suscitare
nel pubblico processi psicologici di
identificazione con i
personaggi.
Delle sue opere minori, ricordiamo così: tragedie [tra queste, il
ciclo
troiano comprendeva i seguenti titoli: Achilles, Aiax, Alexander (era
il
soprannome dato a Paride fra i pastori), Hectoris lytra ("Il riscatto
di
Ettore"), Iphigenia, Hecuba, Andromacha aechmalotis ("Andromaca
prigioniera
di guerra"), Telamo e Telephus; aveva, inoltre, trattato leggende
di origini
diverse: Alcmeo, Andromeda, Athamas, Cresphontes, Erechtheus,
Eumenides,
Medea exul, Melanippa, Nemea, Phoenix e Thyestes, rassegna nella
quale si
riconoscono titoli (e senza dubbio i soggetti) ripresi da Euripide];
2
praetextae (l' "Ambracia" e le "Sabinae");
lo "Scipio", celebrazione di
Scipione l'Africano vincitore a Zama; un
"Hediphagetica" (il mangiar bene,
poemetto gastronomico in esametri); 3
operette di carattere filosofico (l'
"Epicharmus" e il "Protrèpticus", in
settenari trocaici, e l' "Heuhemerus" -
che tratta della relativa dottrina -
in prosa); il "Sota"; e infine le
"Saturae", 4 libri in versi polimetri, di
cui 70 conservati. Scrisse anche
epigrammi.
*Tuttavia, sua opera più importante, una delle pochissime opere
scritte in
età medio-repubblicana, è un poema epico di 18 libri e di ca 30000
versi (ce
ne restano 600 ca), gli "Annales", titolo che indubbiamente si rifà
agli
Annales Maximi, ossia alle registrazioni degli eventi che capitavano di
anno
in anno. E., come Nevio, coltiva l'epica storica; la poesia che cerca
di
creare è cioè poesia celebrativa di gesta eroiche: si rifaceva così sia
ad
Omero, sia alla più recente tradizione ellenistica. Scritta dopo la
vittoria
che pose fine alla II guerra punica, essa tuttavia non è più opera
di
combattimento, ma di meditazione sulla grandezza e sulla missione storica
di
Roma. Apparteneva, dunque, alla generazione successiva a quella di Livio
e
di Nevio.
Gli Annales sono così un poema epico celebrativo di tutta la
storia di Roma,
che E. decise di narrare senza stacchi e in ordine
cronologico,
privilegiando tuttavia alcuni periodi ad altri. Particolarmente
sacrificata
fu in questo senso la I guerra punica, già trattata dal suo
battistrada
Nevio (che, quindi, a sua differenza, s'era limitato ad esaltarne
un solo
episodio). Anche dal punto di vista concettuale E. non fu
totalmente
equilibrato: si occupò maggiormente di avvenimenti bellici che di
vita
politica interna. Altra differenza con Nevio è l'utilizzo
dell'esametro
dattilico, che da E. in poi diverrà tipico della poesia epica.
Infine,
innovativa fu anche la raccolta della storia in libri, concepiti come
unità
narrative comprese in un'architettura complessiva (gli ultimi 3 libri
furono
da lui aggiunti al piano originale che ne prevedeva solo 15).
Per
tutte queste ragioni, E. è spesso considerato dai romani come il vero
"padre"
della loro letteratura, il che non mancò di provocare l'ironia di
Orazio, al
tempo di Augusto.,
*Ci è pervenuto l'inizio del poema, in cui E. non fa
l'invocazione alle
Camene romane, come fece Livio Andronico, bensì alle muse
greche. Seguiva
all'invocazione il proemio con un sogno (nei proemi sono
enunciate, in forma
programmatica, le idee di poetica del nostro autore):
l'anima di Omero
apparsagli appunto in sogno gli illustra la dottrina
pitagorica della
metempsicosi (egli stesso un adepto delle dottrine
pitagoriche, che
restavano vitali nei dintorni di Taranto e contavano
seguaci
nell'aristocrazia romana), secondo cui l'anima di Omero si era
incarnata
prima in un pavone e successivamente in E., l'alter Omerus o Omero
Romano.
Nel I° libro, E. inizia il racconto dalla sconfitta di Troia con la
fuga di
Enea e l'arrivo nel Lazio. dalle nozze di Enea con la principessa del
Lazio
nasce una figlia, Ilia, madre di Romolo e Remo. Uno dei più lunghi
frammenti
narra il sogno profetico di Ilia. È un passo significativo con uno
stile
profetico e drammatico.
I libro: Romolo contro Remo per la
fondazione di Roma; II: altri re di Roma;
III: passaggio dalla monarchia alla
repubblica e guerra contro Pirro; VII:
un secondo proemio sottolinea la sua
distanza dal rozzo Nevio che parlò di
saturno e si definì Docti Studiosus,
esperto di lingua e arte (E. contesta
anche Livio Andronico per l'uso dei
versi saturni nella traduzione
dell'Odissea: egli infatti riteneva questi
versi adatti solamente alle
divinità campestri.); VIII: guerre puniche,
contro la Macedonia, la Siria e
gli Etoli.
CONSIDERAZIONI.
*Grazie
a Cicerone ci è pervenuto un frammento gli "Annales" in cui è
espressa
l'ideologia dell'intera opera: "Moribus antiquis res stat Romana
virisque" in
cui si giustifica l'espansione romana sulla base della sua
virtus. I mores
erano i grandi uomini antichi a cui si deve la potenza
romana. Pur parlando
di guerra, E. non esalta la violenza, bensì la saggezza
politica e la
dedizione allo stato. Nella guerra fra Roma e Cartagine, Roma
corrispondeva a
pace e concordia e Cartagine a discordia e violenza, per
questo destinata a
soccombere.
Così, l'autore tenta di fissare negli Annales non solo racconti
di gesta, ma
anche valori, insegnamenti, esempi di comportamento e modelli
culturali. La
visione del mondo che viene comunicata è il trionfo
dell'ideologia
aristocratica.
*E. è più filosofo che "teologo". Insiste di
più sui valori strettamente
umani. Due dei suoi poemi (perduti ancor più
interamente degli Annales, di
cui restano invece numerosi frammenti),
l'"Epicharmus" e l'"Euhemerus", lo
rivelano occupato in speculazioni
cosmogoniche e morali molto lontane
dall'atteggiamento religioso tradizionale
dei romani. Nel secondo, egli
espone, con particolare congenialità, la
dottrina di Evemero di Messina,
secondo il quale gli dèi e le dee del
pantheon tradizionale altro non sono
che re e principesse del tempo antico,
divinizzati per i servizi resi
all'umanità. Ciò consentiva naturalmente di
esaltare maggiormente i
condottieri romani, le cui imprese dominavano sempre
più la storia umana.
*Infine, riguardo allo stile e al linguaggio, è da dire
che E. è raffigurato
come il primo poeta filologo, cultore della parola,
l'unico capace di stare
alla pari con la raffinata cultura greca. Si può
definire poeta sperimentale
per l'immissione di numerosi grecismi nelle sue
composizioni quali le
innumerevoli pause sintattiche, l'allitterazione e
altre figure di suono.
Afro Publio Terenzio
(195 o 185 ca
Cartagine - 159 a.C., in viaggio)
VITA.
Sulla vita di T. abbiamo una
biografia risalente a Svetonio. A questa
attinse Donato, che la premise al
suo commento delle commedie del nostro. T.
nacque a Cartagine e giunse a Roma
come schiavo del senatore T. Lucano, dal
quale fu affrancato "ob ingenium et
formam", per il suo ingegno e la sua
bellezza. Divenne intimo di Scipione
Emiliano e di Gaio Lelio; entrò a far
parte dell'entourage scipionico e fu
portavoce dell'ideale di humanitas da
esso elaborato. Questa sua posizione di
prestigio suscitò l'invidia dei suoi
contemporanei, soprattutto degli altri
letterati. Sul conto di T. sorsero
calunnie e pettegolezzi: lo si accusava di
essere un prestanome dei suoi
importanti protettori che sarebbero i veri
autori delle commedie terenziane.
Era, infatti, considerato disdicevole per
un civis Romanus, impegnato
politicamente, dedicare il proprio tempo alla
composizione di commedie (l'
unica attività che era concesso coltivare era
l'oratoria o la storiografia).
Da questa accusa T. si difende nel prologo
della sua ultima commedia, l'
"Adelphoe" (da adelfoi fratelli). Nel prologo,
l'autore afferma che ciò che
gli altri ritengono una colpa e di cui lo
accusano, è per lui motivo di
vanto e di orgoglio: ritiene un merito essere
aiutato dagli uomini più
importanti di Roma, delle cui imprese tutto il
popolo si serviva. La difesa
di T. risulta debole, forse perché non voleva
urtare la suscettibilità dei
protettori, a cui le calunnie e le dicerie non
dispiacevano affatto.
Amareggiato dal complessivo insuccesso della sua
produzione, T. lasciò Roma
nel 160 a.C. e volle fare un viaggio in Grecia e
in Asia Minore, da cui non
fece più ritorno. Morì qualche anno più tardi, o a
causa di una malattia, o
a causa di un naufragio, oppure per il dolore
procuratogli dalla perdita dei
bagagli che contenevano molte commedie che
aveva tradotto da originali
menandrei reperiti in Grecia.
OPERE.
T.
compose in tutto 6 commedie, pervenuteci interamente con le
didascalie
relative alla rappresentazione. La sua carriera drammaturgica non
fu facile
come per Plauto: non ebbe lo stesso successo perché la sua commedia
non
rispondeva ai gusti del grosso pubblico romano. Quella di T. era
una
commedia che voleva trasmettere un messaggio morale estraneo alla
mentalità
romana abituata al teatro plautino che interpretava i
rapporti
interpersonali come basati sull'inganno, sulla violenza e
sulle
prevaricazioni.
Il circolo scipionico tendeva ad imporre diversi
modelli di comportamento,
ispirati al costume greco, e il messaggio
terenziano risulta
emblematicamente contenuto nella famosa frase
dell'"Heautontimorumenos" (da
timoreo, ossia il punitore di se stesso): "homo
sum humani nihil a me
alienum puto", "sono uomo e niente di ciò che è umano
considero a me
estraneo". T. esordì nel 166 a.C. con una commedia, l'"Andria"
(la ragazza
dell'isola di Andrio).
Nel 165 a.C. fece rappresentare una
seconda commedia, l'"Hecyra" (la
suocera). Il pubblico dopo le prime scene
abbandonò il teatro preferendo
assistere ad una manifestazione di pugili e
funamboli; fu un fiasco
clamoroso.
Nel 163 a.C. fece rappresentare
l'"Heautontimorumenos".
Nel 169 a.C. furono rappresentate 2 commedie,
l'"Eunucus" e il "Phormio". L'
"Eunucus" fu il più grande successo di T.,
perché è la commedia terenziana
più simile alla comicità plautina.
Nel
160, durante i giochi funebri per celebrare la morte di Lucio Emilio
Paolo,
padre di Scipione Emiliano, T. fece rappresentare la sua ultima
commedia,
l'"Adelphoe", nella stessa occasione tentò una seconda
rappresentazione
dell'"Hecyra", ma anche questa volta il pubblico abbandonò
il teatro
preferendo i gladiatori. Una terza rappresentazione avvenne
durante i Ludi
Romani dello stesso anno e, finalmente, fu rappresentato dall
'inizio alla
fine, il pubblico rimase in teatro grazie alla presenza di
Ambivio Turpione,
attore molto celebre.
*L'"Hecyra". Il protagonista dell'"Hecyra" è il giovane
Pamfilo, tormentato
e patetico, in perenne conflitto fra amore e pudore. È
innamorato di
Bacchide, una cortigiana, ma il padre lo costringe a sposare
Filumena, una
ragazza perbene. Pamfilo è combattuto fra la passione per
Bacchide e il
rispetto della volontà paterna. Sposa Filumena senza amarla e
si rifiuta di
avere rapporti intimi con la moglie, scarica su di lei le sue
delusioni.
Filumena accetta con umiltà i torti del marito che, dopo averla
conosciuta
meglio e confrontata con le altre donne, impara ad apprezzare il
pudore
della moglie e dalla stima nasce l'amore; un sentimento più profondo
dell'
attrazione per Bacchide. Ad un certo punto, Pamfilo parte per un
viaggio di
affari; la moglie lascia la casa del marito, dove viveva con la
suocera
Sostrata, e torna a vivere dai genitori. Nessuno sa con precisione le
cause
di questo allontanamento. Un servo riferisce che Filumena ha
giustificato il
suo allontanamento con motivi di salute, una malattia
l'avrebbe costretta a
tornare a casa. Tutti gli altri personaggi ritengono
che la causa dell'
allontanamento siano stati i conflitti con la suocera. È
soprattutto il
marito di Sostrata ad accusarla di aver reso la vita
impossibile a Filumena
e di averla costretta ad allontanarsi da casa.
Sostrata si ritiene innocente
e in un monologo lungo e toccante si dichiara
vittima dei pregiudizi che
vogliono tute le suocere ostili alle proprie
nuore. Nessuno conosce i motivi
reali che l'hanno indotta a lasciare la casa,
ma tutti i personaggi avanzano
supposizioni infondate. Il messaggio che T.
vuol trasmettere è che non
bisogna giudicare dalle apparenze e lasciarsi
guidare dai soliti pregiudizi.
La realtà è spesso ben diversa dalle
apparenze. Ritorna Pamfilo dal viaggio
e viene informato dell'accaduto; si
reca a casa dei genitori della moglie
per constatare di persone le condizioni
di salute di Filumena. A casa di
Filumena, Pamfilo scopre la verità, ben
diversa da ciò che gli altri
pensavano. Filumena ha lasciato la casa perché
sta per partorire un figlio
non di Pamfilo, ma che è stato concepito prima
del matrimonio, frutto di una
violenza notturna subita da Filumena durante
una festa, ad opera di uno
sconosciuto. In un monologo lungo e patetico,
Pamfilo rivela al pubblico
questa verità e mette a nudo i suoi sentimenti, il
conflitto che si agita in
lui fra amore e pudore. Sa che la sua vita senza la
moglie sarà una vita
vuota, però sa che l'onore e la società lo costringono a
separarsi dalla
moglie e a non considerare come suo l'alienus puer. Pamfilo
non rivela però
il vero motivo per cui divorzia per non compromettere il buon
nome di
Filumena. I due suoceri, all'oscuro della verità, pensano che pamfilo
voglia
ancora Bacchide e che abbia ripreso la relazione con lei. Vanno a
parlare
con Bacchide che rivela ai due che non ha più rapporti con Pamfilo
dal
giorno del matrimonio. Pur essendo una cortigiana, Bacchide accetta
un
compito che nessun'altra al suo posto avrebbe accettato: andare da
Filumena
per dirle che Pamfilo la ama. Bacchide è uno dei personaggi più
peculiari
del teatro di T., si contrappone allo stereotipo della cortigiana,
agisce
contro i suoi interessi perché affezionata a Pamfilo e vuole la
sua
felicità.
Bacchide va da Filumena e la madre nota al dito della
cortigiana un anello
che apparteneva alla figlia e che Filumena portava la
notte in cui aveva
subito la violenza e che le era stato strappato dal
giovane. Bacchide rivela
che l'anello le era stato dato da Pamfilo, il
giovane stupratore era quindi
il marito. La commedia si conclude con il
ristabilimento dell'unione che una
serie di equivoci avevano
minato.
*Altre commedie interessanti sono l'"Heautontimorumenos" e gli
"Adelphoe".
In queste commedie, il tema principale è il problema pedagogico
del rapporto
fra genitori e figli e di quale sia il migliore metodo per
educare i
giovani. Protagonista della prima, è un vecchio genitore, Meneremo,
che con
la sua severità ha costretto il figlio a lasciare la sua città e
ad
arruolarsi come soldato, iniziando così una vita di pericoli e di
disagi.
Dopo essersi reso conto di ciò che ha fatto, il genitore si pente e
decide
di autopunirsi, vende tutti i suoi beni, va in campagna sottoponendosi
a
lavori massacranti. Un altro anziano, Cremete, che ha un campo vicino
al
suo, nota il comportamento di Menedemo e lo invita ad aprirsi con lui,
a
confidarsi. È Cremete a pronunciare il famoso verso"homo sum humani nihil
a
me alienum puto".
Negli "Adelphoe" sono protagonisti 2 fratelli, Demea e
Micione. Il primo è
un uomo all'antica, rigido e austero che ha due figli,
uno dei due lo educa
personalmente secondo i sistemi tradizionali, l'altro,
invece, lo affida al
fratello Micione, che, non sposato, vive in città e ha
idee moderne. È padre
per libera scelta e decide di educare il figlio
adottivo con indulgenza e
liberalità. Secondo lui i giovani devono instaurare
un rapporto basato sul
dialogo con i genitori. Non bisogna costringerli a
fare il bene solo per
paura di una punizione, ma per una scelta personale,
sua spunte e non per
metus (Timore).
CONSIDERAZIONI.
Quattro delle
6 commedie terenziane si rifanno ad originali menandrei: solo
l'"Hecyra" ed
il "Phormio" riprendono commedie di Apollodoro di Caristo, un
altro
commediografo greco che non conosciamo.
Cesare definì T. "Dimidiatus
Menander", ossia un Menandro dimezzato;
giudizio questo che svalutava T.
rispetto al greco. Rispetto a Plauto, le
commedie di T. presentano maggiore
fedeltà ai modelli greci, ma si tratta
sempre di una fedeltà relativa: anche
T., come Plauto, ricorreva alla
contaminazione, ovvero non traduceva alla
lettera i testi greci. Rispetto a
Plauto, T. mantiene un'ambientazione
rigorosamente greca, senza surreali
intrusioni di usi e costumi romani. T.
elimina quasi completamente i
cantica, facendo invece uso abbondante dei
versi lunghi. Altra notevole
differenza con Plauto è quella relativa allo
stile e al linguaggio: non
troviamo in T. l'esuberanza, le acrobazie verbali,
i giochi di parole e le
parodie dello stile tragico; evita vigorosamente
espressioni popolari e
volgari; segue, stilizzandolo, il linguaggio della
conversazione ordinaria.
Quello di T. è insomma uno stile sobrio, naturale,
all'insegna della
compostezza, della semplicità.
Anche in T., al centro
della vicenda comica troviamo amori ostacolati che,
alla fine si realizzano
felicemente. I personaggi sono quelli della commedia
nea, giovani innamorati,
ragazze oneste ecc.; troviamo anche qui i soliti
stereotipi della nea
equivoci, inganni ecc. Il topos del riconoscimento
conclude 5 commedie su 6,
mancando solo negli " Adelphoe ". Sempre 5 su 6 si
concludono con uno o più
matrimoni: solo nell'"Hecyra " troviamo il
ristabilimento di una unione
matrimoniale che era entrata in crisi a causa
di equivoci e sospetti
infondati.
T. tende a complicare gli intrecci menandrei, inserendo nella
commedia,
accanto alla coppia principale, una seconda coppia. Gli adulescens
sono
quindi 2 e sono 2 i senex. Rispetto a Plauto, T. costruisce i suoi
intrecci
con coerenza maggiore e con più credibilità, caratteristiche queste
mancanti
nell'altro, che puntava sull'efficacia comica della singola scena.
Altra
differenza importante con Plauto e Menandro, è l'abolizione del
prologo
informativo. T. trasforma il prologo informativo in un prologo a
carattere
letterario; nel prologo parla di sè, del suo modo di poetare e si
difende
dalle accuse che i suoi avversari gli rivolgono. Plauto e Menandro
si
servono del prologo per informare il pubblico dell'antefatto e
anticipano
spesso la conclusione; ciò metteva il pubblico nella condizione di
seguire
meglio la vicenda, il cui intreccio era spesso complesso. Ciò rendeva
il
pubblico superiore ai personaggi della commedia. T. elimina il
prologo
informativo, perché punta su effetti di suspense, vuole che lo
spettatore si
immedesimi nel personaggio, vuole che il pubblico sia coinvolto
emotivamente
nelle vicende, provi le stesse emozioni dei personaggi. T. vuole
mascherare
l'aspetto fittizio dell'evento teatrale, vuole che non venga mai
interrotta
l'illusione scenica. Elimina tutti i procedimenti metateatrali a
cui spesso
ricorreva Plauto. Tutto ciò ha uno scopo preciso: mentre Plauto
non
perseguiva nessun fine morale o politico, ma tendeva solo a divertire,
T.,
con le sue commedie, vuole trasmettere un messaggio morale.
T.,
inoltre, attenua i tratti caricaturali dei personaggi della nea e ne fa
delle
figure delicate, tenere, sensibili (ma più "tipi" che
individui).
Protagonista del suo teatro non è più il servus callidus, ma
padri e figli.
Non ridicolizza i sentimenti d'amore dei giovani, ma li segue
con
partecipazione e simpatia. I padri terenziani sono differenti da
quelli
plautini, sono disponibili al dialogo con i figli e si preoccupano
della
loro felicità più che del loro patrimonio e del veder affermata la
loro
autorità. Nel teatro di T. non esistono personaggi del tutto negativi.
Anche
i servi sono spesso vicini ai padroni e partecipano ai problemi
familiari;
non tutte le cortigiane pensano ai propri interessi. Il messaggio
che vuole
trasmettere è quello di aprirsi agli altri, rinunciare
all'egoismo,
comprendere i propri limiti ed essere indulgenti nei confronti
degli errori
altrui, essere tolleranti e solidali. Chi si apre agli altri
vive veramente
da uomo fra gli uomini.
Marco Pacuvio
(Brindisi
220 - Taranto 130 a.C.)
VITA, OPERE, CONSIDERAZIONI.
Introdotto,
grazie all'influenza dello zio Ennio, negli ambienti
filoellenici di Roma, in
particolare nel "circolo degli Scipioni", P. sembra
che abbia imitato più
Sofocle che Euripide, forse sotto l'influsso dei suoi
amici romani, il cui
gusto si volgeva verso il classicismo attico. Ecco i
titoli delle sue
tragedie che ci sono stati tramandati: "Antiopa", "Armorum
iudicium" (la
contesa tra Aiace e Ulisse per le armi di Achille),
"Atalanta", "Chryses",
"Dulorestes" ("L'Oreste schiavo"), "Hermiona",
"Iliona", "Medus" (storia del
figlio di Medea, avuto da Egeo, re di Atene),
"Niptra" ("Il bagno" in cui, si
narrava, Telègono, figlio di Ulisse, aveva
involontariamente ucciso il
padre). Sua è anche una praetexta ("Paulus"),
allestita forse in occasione
del trionfo di Paolo Emilio su Perseo (160
a.C.).
Nella serie dei giudizi
tradizionali dati al tempo di Orazio sugli antichi
tragici romani, P. passava
per un "vecchio sapiente": forse per il fatto che
si era sforzato di
rinnovare le ispirazioni del suo teatro, ricorrendo a
modelli meno ritriti.
In ogni caso, le sue opere teatrali vennero riprese
ancora molto tempo dopo
la sua morte, e persino il pubblico popolare ne
conosceva a memoria lunghi
brani. I frammenti abbastanza lunghi che ce ne fa
conoscere Cicerone lasciano
intravedere, in P., un grande vigore di stile,
un senso del patetico moderato
dalla preoccupazione per la dignità che
conviene agli eroi, un senso tutto
romano della virus, una conseguente
spiccata sentenziosità, una certa
predilezione per il macabro (che ne fanno
una sorta di precursore di
Seneca).
Di conseguenza, la lingua è contraddistinta da parole strane,
forme
insolite, conii artificiosi.
Fu anche autore di "Saturae", in vario
metro, purtroppo perdute.
Lucio Accio
(Pesaro, 170 - 85 ca
a.C.)
VITA, OPERE, CONSIDERAZIONI.
Si tratta di un poeta "moderno" e
"dotto". In viaggio a Pergamo, nel momento
in cui il regno di Attalo III
diventava provincia romana (133 a.C.), era
stato iniziato ai metodi della
filologia pergamena. I suoi interessi si
erano rivolti alla storia del teatro
a Roma e anche in Grecia. Oltre ad
alcuni scritti "minori" - "Didascalica"
(prosimetro, su questioni di storia
letteraria); "Pragmatica" (di tecnica
teatrale); "Annales" (almeno 27 libri
su storie e miti connessi alle
festività), "Sotadica" (poesie erotiche) - la
cui varietà dimostra la vivace
curiosità del suo intelletto e l'estensione
della sua cultura, A. ha lasciato
numerose tragedie, delle quali ci sono
noti circa 45 titoli. Dei testi di
queste opere, però, possediamo solo
alcuni frammenti (700 versi circa), che
non possono darci che un'idea molto
generale della sua arte.
Le tragedie
di A. trattano in genere di leggende greche già più volte
portate sulla
scena. I suoi soggetti preferiti sembrano essere quelli che
comportano
episodi violenti o atroci. La sua fama cominciò verso il 130, con
la messa in
scena di un Tereus (storia del bambino che la madre fa divorare
dal marito
infedele).
Com'era facile prevedere, A. trattò in seguito l'intero ciclo dei
Pelopidi,
con una tragedia dallo stesso titolo, a cui si aggiungevano un
Atreus, un
Chrysippus, una Clytaemestra, un Aegisthus e una tragedia dal
titolo
Agamemnonidae, che sviluppavano tutta intera la serie delle atroci
violenze
che avevano caratterizzato ogni generazione di quella dinastia. Al
ciclo
troiano appartenevano l'Achilles, l'Epinausimache (la ripresa
dei
combattimenti nei pressi delle navi, un celebre episodio
dell'Iliade),
l'Armorum iudicium (la controversia fra Ulisse e Aiace
sull'attribuzione
delle armi di Achille), la Nyctegresia (la spedizione
notturna di Diomede e
Ulisse nel campo troiano), Troades, Astyanax,
Deiphobus, eccetera.
Alcune di queste opere si ricollegano direttamente
all'Iliade, altre alla
Piccola Iliade e ad altri poemi ciclici. I soggetti
tebani erano
rappresentati da Phoenissae, Thebais, Antigona ed Epigoni. I
miti dionisiaci
erano largamente ricordati con Athamas, Bacchae, Tropaeum
Liberi e
probabilmente Erigona. Altri soggetti celebri (Medea, Alcestis,
Alcmeo,
Andromeda, Meleager, Prometheus, eccetera.) completavano infine
il
repertorio tradizionale al quale A. si ispirava.
E' stata avanzata
l'ipotesi che il poeta non avesse scelto i suoi soggetti
senza una qualche
finalità recondita e che, in una certa misura, tenesse
conto dei problemi di
attualità, ad esempio della questione sociale nel
periodo dei Gracchi. La
cosa è difficilmente dimostrabile nei particolari.
In se stessa, tuttavia,
l'idea è ben lungi dall'essere inverosimile. Di
sicuro c'è che i romani (e in
particolare Cicerone, grande ammiratore di A.)
trovavano sempre, nelle sue
opere, materiali per inattese applicazioni. Il
che era agevolato
dall'abbondanza delle massime morali e degli sviluppi di
idee comuni, come la
tirannide, l'esilio, eccetera.
La ricchezza oratoria di A., come traspare
anche dai frammenti rimasti,
prelude già allo stile delle tragedie di Seneca:
il linguaggio ha un tono
magniloquente e ridondante, ricco di giochi
allitterativi e di composti
eruditi.
La celebrità di A. si deve anche alle
due tragedie praetextae da lui
composte: il "Decius" o Aeneadae e il
"Brutus". La prima ricordava le
"devozioni" dei Decii, il sacrificio delle
loro vite che quei tre eroi
avevano compiuto, uno dopo l'altro, per
assicurare la vittoria alle armate
romane (295 a.C.). Di queste due tragedie,
noi conosciamo però molto meglio
la seconda, che portava in scena la caduta
della monarchia e l'avvento della
repubblica. Si assisteva all'attentato
contro Lucrezia e alla punizione dei
tiranni. Un sogno e la sua
interpretazione da parte di un indovino davano
luogo a una scena celebre che
Cicerone cita testualmente nel De divinatione.
Essa rivela un senso della
gravitas religiosa e della presenza del divino
che sembra smentire le
affermazioni dei moderni troppo propensi a
considerare la religione
nazionale, in quell'epoea, solo come un'accozzaglia
di leggende
obsolete.
Qualunque fosse la realtà degli dèi, le anime continuavano a essere
agitate
da sogni, da presagi, e conservavano comunque la loro fede nei
riti.
Si è spesso rimproverato ad A. l'eccessiva violenza e ricercatezza del
suo
stile, quella sua volontà di rimanere nel "sublime" ad ogni costo che,
se
non impedì il successo delle sue opere, segnò tuttavia l'inizio del
declino
cui andò incontro il genere tragico dopo di lui.
Fatto sta che la
conseguenza più importante delle carriere di A. e Pacuvio
fu forse, in
definitiva, che la tragedia salì di classe e di tono: la sua
pratica, pur
continuando a godere del successo popolare, divenne sempre più
cosa da
gentiluomini.
Marco Porcio Catone
il Censore o il
Vecchio
(Tusculum, 234 a.C.)
VITA.
C. visse nel periodo più intenso
della storia romana, quello delle guerre
puniche e dell'espansione ad
oriente. Per le guerre contro la Macedonia e la
Siria, s'intensificarono i
rapporti tra Roma e la Grecia. L'ala più
progressista romana, a capo della
quale erano gli Scipioni, si aprì alla
cultura greca; C. fu rappresentante
invece dell'area più tradizionalista
dell'aristocrazia. Di C. abbiamo due
immagini contrastanti:
1.Quella delineata da Cicerone nel "Cato Maior seu De
senectute" è un'
immagine idealizzata, mitizzata. C. diventa cittadino
esemplare e incarna i
mores, i costumi del passato.
2.L'altra la troviamo
nella biografia di Plutarco che, nelle sue "Vite
Parallele", fa di C. un
personaggio contraddittorio, un uomo che si atteggia
a moralista, a censore
dei costumi ma che, nella sfera privata, non disdegna
di esercitare l'usura o
di darsi a speculazioni finanziarie spregiudicate,
esoso verso i suoi
dipendenti e gli schiavi, un uomo che colpisce le vanità
altrui ma che appare
egli stesso vanitoso e ambizioso (e forse è questa l'
immagine più
reale).
Nato da famiglia contadina, C trascorse la giovinezza lavorando le
terre in
Sabina. La sua origine lasciò un'impronta determinante nella sua
mentalità.
Fu arruolato nella II guerra punica e rimase sotto le armi per
quasi tutta
la durata del conflitto. Solo alla fine iniziò il cursus onorum.
Egli era un
uomo novus, la cui famiglia non aveva mai ricoperto cariche
politiche. Per
la sua attività politica si avvalse dell'appoggio di Valerio
Flacco,
aristocratico conservatore.
Nel 204 a.C. fu eletto questore; nello
stesso anno Scipione portava la
guerra in Africa. C. lo seguì. Il contrasto
fra di loro è immediato. C.
infatti contestò l'eccessiva prodigalità di
Scipione e le eccessive
elargizioni alle sue truppe. Quello rispose che non
aveva bisogno di un
questore così preciso e che doveva dare conto a Roma non
del denaro speso,
ma delle imprese portate a termine. Tornato in Italia,
incontra Ennio e lo
porta a Roma.
Negli anni seguenti continua la carriera
politica, e nel 195 a.C. Flacco
diviene console. Nello stesso anno i tribuni
della plebe proposero l'
abrogazione della lex oppia, legge promulgata nel
125 a.C. dopo la disfatta
di Canne che vietava alle donne di indossare abiti
lussuosi e gioielli d'oro
che superassero un certo peso; questo perché
bisognava concentrare le
risorse economiche per le imprese militari. C. si
oppose, però la legge
venne abrogata.
Nel 190 a.C. era finita la guerra
contro Antioco III di Siria che, sconfitto
pagò ai romani 15.000 talenti di
cui 500 andarono direttamente agli
Scipioni. C. colse la palla al balzo e li
attaccò sul loro punto debole, l'
amministrazione del denaro pubblico. Lo
stesso Scipione, in conseguenza dei
processi che ne derivarono, preferì
allontanarsi in volontario esilio.
Nel 184 a.C. C. divenne censore con
Valerio Flacco e lo fece con rigore
proverbiale. Si oppose in tutti i modi al
lusso eccessivo, al mal costume e
alla corruzione di cui davano prova gli
esponenti dell'aristocrazia
progressista. Nel 180 a.C. muore Flacco e C.
smorza i toni aspri della sua
polemica, si avvicina a Lucio Emilio Paolo che
è diventato l'uomo più
rappresentativo del circolo scipionico. Combina il
matrimonio fra il figlio
Marco e Terzia, figlia di quello. Intanto cerca di
arricchirsi con
speculazioni finanziarie e con l'usura.
Continua poi la
polemica contro i greci. Nel 161 a.C. il senato, sotto sua
ispirazione, emanò
un decreto di espulsione per tutti i retori e i filosofi
greci residenti a
Roma. Nel 155 a.C. giunsero a Roma come ambasciatori
ateniesi, 3 filosofi
greci, Carneade, Diogene e Critolao che, in attesa di
essere ricevuti dal
senato, tennero a Roma delle conferenze: i romani li
andarono a sentire e ne
rimasero affascinati. C. consigliò al senato di
riceverli il prima possibile
per farli andare via altrettanto rapidamente.
La paura dei romani per la
retorica e la filosofia è basata sull'autonomia e
sullo spirito critico che
queste comportano; da un lato ne sono affascinati,
dall'altro hanno paura che
esse possano corrompere i valori e i rapporti
sociali tradizionali.
Negli
ultimi anni, C. conduce una campagna politica contro Cartagine, città
non più
un pericolo dal punto di vista militare ma competitiva dal punto di
vista
commerciale. La III guerra punica fu dichiarata nel 149 a.C. anno
della morte
di C..
OPERE.
*Per raggiungere le vette del potere politico, C. fu un
oratore eccellente:
con lui sarà inaugurato il nesso fra politica e arte
oratoria, la capacità
di tenere discorsi persuasivi. L'oratoria diventa
strumento politico. Nel
corso della sua vita, a detta di Cicerone, C.
pronunciò moltissimi discorsi
(almeno 160) e fu anche il primo a scriverli
per rielaborarli. Noi
possediamo circa 80 titoli e qualche frammento delle
sue orazioni. Per C. l'
oratore perfetto doveva essere Vir Bonus Dicendi
Peritus. C. inoltre dà la
precedenza al vir e alla sua integrità morale,
ponendo in secondo piano l'
abilità nel parlare. Ciò che conta per lui è
l'interiorità, senza la quale
non si può essere un buon oratore. Altro
precetto che ci ha lasciato è la
famosa frase: "Rem tene, verba
sequentur".
Fra le orazioni di C. ricordiamo il "De sumptu suo": qui C.
contrappone il
"proprio tenore di vita" a quello dei suoi avversari e traccia
l'immagine di
sé come di un politico onestissimo che esercita le sue cariche
con
disinteresse, ligio al proprio dovere. Contrapponeva quindi questa
immagine
di perfezione a quella degli altri che esercitavano il loro potere
per
interesse personale, sfruttando il prestigio che avevano.
Altra
orazione fu quella del 167 a.C. "Pro Rodiensibus" (In difesa degli
abitanti
di Rodi). Rodi era alleata romana e durante la guerra tra Roma e
Perseo
rimase neutrale. Dopo la vittoria fu accusata dai romani di
tradimento. Roma
la voleva punire e C. intervenne in sua difesa affermando
che si possono
punire le azioni, non i pensieri. Il senato accettò la tesi
di C., ciò
nonostante qualche anno dopo Rodi venne punita economicamente:
Roma dichiarò
la vicina Delo porto franco e i traffici si spostarono da Rodi
a
Delo.
*Altra operetta è il "Praecepta ad Marcum filium", a carattere
enciclopedico
e di pronta consultazione; il suo intento era di istruire il
figlio, di
essere il suo primo maestro e di criticare l'uso che si stava
diffondendo di
far educare i propri figli dai greci.
L'opera era divisa a
seconda della disciplina che voleva insegnare: arte,
retorica, medicina
ecc.
Vi è un frammento in cui parla al figlio dei greci screditandoli.
Secondo C.
è necessario conoscere i greci ma non farsi influenzare poiché
sono corrotti
e corruttori.
*L'unica opera pervenutaci interamente è il
"De agri cultura", la prima
scritta in prosa della letteratura latina: è un
trattato sull'agricoltura.
Non è a carattere sistematico: sono 162 capitoli
in cui sono esposti
consigli circa la conduzione di un'azienda agricola.
L'azienda di cui parla
è finalizzata non ad un'economia di sussistenza ma di
mercato: si
contrappone il modello del podere di medie dimensioni al nascente
latifondo.
C. consiglia il podere da acquistare, i lavori da compiere,
insegna la cura
delle malattie di piante e animali, i compiti del fattore,
insegna come
trattare i dipendenti e come comportarsi con gli schiavi che,
per lui non
sono persone ma res.
Nelle sue intenzioni, l'opera ha anche
funzione morale e sociale: C. infatti
ritiene che l'agricoltura innanzitutto
è l'attività più sicura ed onesta, e
che poi è solo col lavoro agricolo che
si formano i buoni cittadini ed i
buoni soldati.
*C. si cimentò anche nel
genere storiografico, e da vecchio scrisse un'
pera - "Origines" - di cui
abbiamo solo frammenti: le uniche testimonianze
unitarie le possediamo
tramite Cornelio Nepote. Sappiamo che l'opera era in
7 libri, e seguiva
questo profilo: I libro: origini di Roma e periodo
monarchico; II e III:
storia delle altre città e popolazioni italiche; IV:
Iª guerra punica; V :
IIª guerra punica; VI e VII: avvenimenti successivi
sino al 151 a.C., anno in
cui il pretore Servio Sulpicio Galba vinse sulla
popolazione spagnola dei
Lusitani grazie ad atti di grande ferocia e
crudeltà che C. denunciò in
un'orazione del 149 a.C. poco prima di morire.
C. Vuole, con questa opera,
porre sullo stesso piano Roma e le altre città
italiche (per lui la potenza
di Roma è frutto anche dell'appoggio delle
altre popolazioni); inoltre non
cita i nomi dei generali, ma li indica con
la carica ricoperta, e lo fa per
contestare la concezione individualistica,
"carismatica" della storia, cosa
evidente nell'epica storica di Ennio e
nelle prime opere storiografiche
romane, gli Annales. Di contro, C. vedeva
invece la creazione e la storia
dello stato romano come l'opera collettiva e
progressiva del "populus
romanus", stretto intorno all'ideologia e agli
uomini della classe dirigente
senatoria.
LA STORIOGRAFIA DOPO CATONE
*Già nel 149, quando
Catone morì, l'ellenismo invadeva Roma o, quanto meno,
produceva nelle
coscienze un riequilibrio di valori del quale abbiamo già
avuto modo di
rilevare l'ampiezza, a proposito di Terenzio e di Lucilio. I
generi in prosa
non si sottraevano a tale influenza. Gli eruditi greci
cominciavano a essere
conosciuti a Roma parallelamente ai filosofi e, mentre
grazie a questi ultimi
gli oratori cominciavano a interrogarsi sul valore e
sui limiti
dell'eloquenza, insieme all'erudizione venivano crescendo anche
le esigenze
nei confronti della storiografia.
*Da questo punto di vista, è caratteristica
la parte avuta dallo scrittore
greco Polibio. Alto magistrato della lega
achea al momento di Pidna, si
trovò compreso nell'elenco degli ostaggi achei
rivendicati da Roma dopo la
vittoria (167). Ciò spiega la ragione per cui
visse a Roma per molti anni.
Legato a L. Emilio Paolo, fu precettore dei suoi
figli e "guida spirituale"
del giovane Scipione Emiliano. Storico egli
stesso, cercò di comprendere il
fenomeno storico costituito da Roma: in che
modo, in meno di una
generazione, la repubblica avesse raggiunto i risultati
che, nello spazio di
due secoli e mezzo, i re orientali non avevano ottenuto,
e cioè riportare la
pace nel bacino del Mediterraneo e imporre al mondo un
potere forte e
stabile. Intorno a quest'uomo, l'élite dei giovani romani è
portata a
riflettere sul ruolo della propria città, e a sottoporre ogni
azione alla
critica della ragione e della conoscenza.
*Ma dalle lezioni di
Polibio trassero profitto soprattutto gli uomini di
stato filoellenici e i
teorici della filosofia politica; quanto agli
storici, bisognerà aspettare
fino a Tito Livio, e cioè fino ai tempi di
Augusto, per trovare in modo certo
un impiego diretto della sua opera. In
verità, noi non conosciamo quasi nulla
degli annalisti del secondo secolo
a.C. Cosa mai contenessero le opere
storiche di P. Cornelio Scipione, figlio
di Scipione l'Africano, o quelle di
C. Acilio o, infine, la storia di A.
Postumio Albino, aspramente ripreso da
Catone perché, al pari di Scipione e
Acilio, era uso scrivere in greco, ci è
ignoto. Essi avevano scelto
quest'ultima lingua per disprezzo verso il
latino, per conformarsi alla
tradizione di Fabio Pittore e di Cincio
Alimento, o perché si trovavano
sotto l'influenza di Polibio? Non lo
sappiamo. E' probabile però che
l'impiego del greco permettesse a questi
autori di rompere il quadro,
essenzialmente romano e quasi rituale,
dell'esposizione successiva, anno per
anno, degli avvenimenti.
*Gli
storici di lingua latina di quest'epoca si adattano, infatti, ancora
allo
schema annalistico. Così, oltre a L. Cassio Emina e a L. Calpurnio
Pisone,
uno degli autori più "critici" nei confronti delle antiche leggende,
C.
Fannio, genero di C. Lelio e membro, perciò, del "circolo degli
Scipioni",
nel quale s'incarna la tendenza modernista e filoellenica. Pisone
e Fannio
erano stati gli ascoltatori e, in una certa misura, i discepoli di
Panezio,
il filosofo stoico che, trasferitosi a Roma, vi era rimasto fino al
130
circa, in contatto anch'egli col "circolo degli Scipioni".
Com'è noto, la
dottrina stoica comportava delle riflessioni sulla storia,
attraverso le
quali essa si sforzava di dare una lettura dei disegni della
provvidenza, di
quel dio che, a suo giudizio, governa il mondo. La ricerca
storiografica
delle cause, piuttosto che dalla diretta imitazione degli
storici greci, nei
quali la nozione di causa (ad esempio in Tucidide)
rimaneva piuttosto confusa
e relegata nella contingenza, ebbe dunque origine
in questo modo.
*Vi
furono anche, alla fine del II secolo e all'inizio del I, altri
annalisti che
si limitarono a dare continuità alla tradizione dei più
antichi. Claudio
Quadrigario, diffidando dei documenti relativi ai primi
passi della
repubblica, diede avvio ai suoi "Annales" con l'evento della
presa di Roma da
parte dei Galli. A quanto pare, tendeva soprattutto ad
evidenziare il
carattere pittoresco del racconto e a privilegiare le
situazioni drammatiche.
Il suo contemporaneo, Valerio Anziate, si è meritato
invece la cattiva fama
d'essere stato un compilatore poco scrupoloso, avendo
inventato particolari
che non si trovavano nelle fonti ed esagerato le cifre
(degli armati, dei
caduti in battaglia, eccetera), e avendo scelto sempre,
fra le varie versioni
di un evento, quella più ricca di elementi fantastici.
*Tuttavia, in questa
II metà del II sec., si vede sorgere una forma di
narrazione storica che non
ha più nulla a che vedere col metodo annalistico,
e il cui interesse è
rivolto, al contrario, alla trattazione di un periodo o
di un evento ben
determinati. Così i 7 libri di Celio Antipatro sulla guerra
di Annibale, o le
"Historiae" di Sempronio Asellione che esaminavano un
periodo di cui l'autore
era stato testimone diretto (dal 134 al 90 a.C.).
Antipatro e Asellione
applicavano, in questo modo, la concezione storica
prevalente presso i greci
in quello stesso periodo. Il fatto che l'opera di
un Posidonio, discepolo di
Panezio, sia stata concepita nel medesimo spirito
(la ricerca delle cause
all'interno
di un periodo definito), lascia supporre che l'origine comune sia
da
ricercare nella dottrina elaborata dagli stoici già romanizzati
e
nell'ambiente dello stesso Polibio, il quale aveva a sua volta
tratto
profitto dall'esperienza e dalla riflessione dei suoi amici sulla
gestione
pratica degli affari pubblici. E' significativo inoltre che questi
storici
abbiano cominciato la loro carriera come uomini d'azione:
Sempronio
Asellione aveva servito sotto il comando di Emiliano a Numanzia,
Polibio,
nella sua giovinezza, aveva cominciato con l'essere "ipparco" nella
lega
achea; Posidonio era stato "pritano" della repubblica di Rodi. Per loro
la
storia è la prosecuzione dell'azione, non è ancora diventata
opera
esclusivamente erudita o letteraria.
Gaio Lucilio
(Sessa
Aurunca, Campania/Lazio 148/7 - 102/1 a.C)
VITA.
Di origini
nobili, fu uno fra i primi romani che abbiano affrontato il
viaggio in Grecia
per farsi una cultura filosofica e sicuramente fu il primo
letterato di buona
famiglia a condurre una vita da scrittore,
volontariamente appartata dalle
cariche pubbliche.
La sua biografia è segnata dall'incontro con gli Scipioni:
fu compagno di
Scipione Emiliano in Spagna, nel l33, in occasione della
guerra di Numanzia.
Poco dopo, giovanissimo, esordiva come poeta, riprendendo
il genere della
"satira". Divenuto adulto, saranno proprio i grandi
personaggi del partito
scipionico a proteggerlo. Per le sue origini
aristocratiche, i suoi
rapporti, l'ambiente in cui viveva, L. fu infatti
spinto a prendere partito
nelle lotte politiche; lo fece con vivacità e
persino con violenza. Evoca
per esempio i grandi processi del tempo, il che
lo porta a rappresentare
scene di vita nel foro. Altre volte, affidando ai
versi gli avvenimenti
della sua vita quotidiana, racconta un viaggio in
Campania e in Sicilia,
dove lo chiamavano gli affari privati. Quasi nulla si
sa, comunque, del
periodo più tardo della sua vita.
IL SIGNIFICATO DI
"SATIRA".
Le origini della satira sono abbastanza confuse: la connessione col
termine
greco "satyros" è del tutto falsa: la satira in origine non sembra
aver
avuto niente a che fare con i satiri e con il teatro comico greco.
Sembra
invece che "satura lanx" indicasse nell'antica Roma un piatto misto
di
primizie che venivano offerte agli dei. È probabile allora che il valore
di
mescolanza e varietà fosse quello originario. Il nome, dunque, non è
greco
ma romano (come l'atellana), ed è proprio per questo che
Quintilliano
contrappone la satira agli altri generi di letteratura latina
come l'unica
veramente e solamente romana.
Per i primi poeti la satira era
intesa come spazio personale, in cui si
poteva esprimere la voce personale
del poeta. Già ai tempi di Ennio la
produzione letteraria era abbastanza
articolata ma nessuno dei generi
canonici dava spazio ai pensieri diretti del
poeta. Nelle satire varietà,
voce personale e realismo sono le
caratteristiche principali: L. decide di
specializzarsi nel genere satirico e
lo sviluppo della satira negli anni
seguenti segnò lo sviluppo di un nuovo
pubblico, interessato alla poesia
scritta, culturalmente avvertito e
desideroso di una letteratura che
rispecchiasse la realtà
OPERA.
Di
L. abbiamo esclusivamente "Satire" (egli stesso le chiama "poemata" o
anche
"ludus ac sermones", poesie scherzose), in 30 libri, di cui ci restano
900
frammenti ca.
Furono raccolte ed ordinate con criterio metrico: l'autore
aveva pubblicato
progressivamente i libri XXVI-XXX, contenenti le satire in
settenari
trocaici e semari giambici e, verso la fine, in esametri dattilici;
i libri
I-XXI, in esametri (forse sua ultima e definitiva scelta); i libri
XXII-XXV,
nei quali pare prevalesse il verso elegiaco (sono stati aggiunti al
corpus
postumi).
I temi delle satire luciliane si possono riassumere nel
seguente elenco: la
parola del Concilium Deorum: attraverso una parodia di
concili e decisione
divine, L. prende di mira un certo Lentulo Lupo,
personaggio antipatico agli
scipioni (lo farà morire di indigestione); la
descrizione di viaggi e il
filone gastronomico: vi è un libro di satire (III)
in cui si parla di un
viaggio in Sicilia e altri in cui sono scritte delle
ricette succulenti;
l'amore e le questioni letterarie: nel XVI libro L. parla
della donna di cui
è innamorato.
CONSIDERAZIONI.
*L., dunque, si
dedicò esclusivamente alla satira, trattandola inizialmente,
come già aveva
fatto Ennio, in versi trocaici e giambici, i versi dei generi
drammatici; in
seguito, nell'ultima parte della sua produzione (quella che,
nella raccolta
pubblicata, forma i primi 20 libri), userà solo l'esametro,
creando in tal
modo la forma definitiva della satira, poema "ragionato", più
narrativo e
meditativo che drammatico, portato gradualmente a quell'ordine
formale con
cui ci apparirà più tardi.
*Il realismo, il gusto dell'aneddoto che
ritroviamo nelle arti plastiche
romane, l'interesse per i paesaggi, gli
oggetti, i dettagli dell'esistenza
reale e quotidiana, tutto ciò traspare nei
frammenti rimasti e delinea una
tradizione.
Aperto alle influenze
elleniche (in particolare, i commediografi greci e la
filosofia stoica
neoaccademica), L. resta partigiano convinto dei valori
romani tradizionali,
ma senza essere schiavo dei pregiudizi e della
grettezza della generazione
precedente. In un celebre passo, proclama che il
primo posto si deve dare
alla patria, il secondo ai componenti la propria
famiglia, e solo il terzo a
se stessi, il che significa, in questa morale
della saggezza, subordinare la
propria felicità a quella degli gli altri,
atteggiamento che, dopo Epicuro e
Zenone, non è più quello dei filosofi
greci.
Con lui vediamo come la
mentalità romana, quanto meno nell'élite cittadina,
abbia superato la crisi,
l'inquietudine di cui l'opera di Terenzio era
testimonianza, proseguendo con
successo la sintesi di cultura ellenica e
tradizione nazionale.
*Infine,
dal punto di vista stilistico, la poesia di L. si apre in tutte le
direzioni:
amalgama il linguaggio celebrativo dell'epica, come fosse
parodia, e fa uso
di termini tecnici e retorici che finora non erano mai
stati
usati.
Neoteroi (I sec. a.C.)
Quello dei n. (o "poetae novi")
è un gruppo di poeti, quasi tutti
provenienti dalla Gallia Cisalpina, che
operò a Roma nel I sec. a.C.
Vennero così definiti polemicamente da Cicerone,
nel senso di "quelli alla
moda", con allusione al loro gusto ellenizzante e
aristocratico, e al loro
atteggiamento di innovatori d'ispirazione
alessandrina (riflesso della
situazione politica - conquiste di Roma in
oriente - e della lezione
epicurea). "Lepos", "venustas" e "urbanitas" sono
dunque le loro
parole-chiave, armonizzate in un rapporto ch'è al contempo
etico ed
estetico.
Legati da reciproca amicizia, liberi e spregiudicati
nella vita privata, i
n. avevano in comune il culto della letteratura e
l'esigenza di esprimersi
con spontaneità e insieme estrema consapevolezza
d'arte: contrapponevano,
cioè, alla letteratura usata solo per fini
etico-politici, l'otium
letterario individuale: il piacere di scrivere
diventa lo scopo e il fine
della vita.
Insomma, proclamavano una poesia
affermatrice dell'individualismo, che
avvertiva i problemi inquietanti della
crisi repubblicana e che, se pur si
schierava con spirito di fronda contro i
nuovi dittatori (Cesare), avversava
paritempo - in letteratura - il
tradizionalismo (per quanto illuminato - di
un Cicerone.
Dichiararono,
così, guerra ai lunghi poemi epici di imitazione enniana,
privilegiando gli
epilli, i "carmina docta" (brevi componimenti di argomento
poco noto a
imitazione di Callimaco e di Euforione), la diretta confessione
lirica e le
divagazioni leggere ("nugae") sempre nel più meticoloso rispetto
della
tecnica metrica.
Cercarono l'ispirazione preferita nel tema amoroso (e in
questo punti
patenti sono le differenze con l'epicureismo).
Tra gli altri
- oltre che ovviamente Catullo - vanno ricordati almeno:
Levio (che, in
verità, è più un prenoterico), autore di una vasta raccolta
di "Erotopaegnia"
(ossia, "scherzi d'amore"), di cui restano frammenti. In
essa, trattava, con
toni sentimentali e romanzeschi, ma smitizzando il
materiale della tradizione
epico-tragica, gli amori di personaggi del mito o
di eroi troiani. Poeta
colto, introdusse in Roma il genere alessandrino dell
'elegia narrativa,
influendo - coi suoi arditi neologismi, con pittoreschi
impasti di lingua
colta e colloquiale, coi diminutivi affettivi - la
generazione
neoterica.
Varrone Atacino, che iniziò con un poema sulla campagna di Cesare
contro
Ariovisto ("Bellum Sequanicum") e con "Satire" di tipo luciliano, e si
fece
poi divulgatore della poesia alessandrina rielaborando in latino
le
"Argonautiche" di Apollonio Rodio, componendo poesie d'amore,
una
"Chorographia", d'argomento geografico, e un calendario agricolo in
versi
("Ephemeris").
Licinio Calvo, oratore di tendenza attica, scrisse
anche, oltre ad epigrammi
di invettiva politica, epitalami e altri
componimenti di soggetto amoroso,
nonché un epillio ("Io").
Elvio Cinna,
la cui fama è legata soprattutto all'epillio "Zmyrna", sull'
amore incestuoso
di Mirra per il padre, caratterizzato dalla "brevitas"
dello stile, dalla
densità della dottrina e dalla mostra di conoscenza della
psicologia
amorosa.
Furio Bibaculo, di cui restano 2 epigrammi su Valerio Catone, suo
maestro, e
si sa di altri contro Augusto. Alcuni critici lo identificano con
un Furio
Alpino, autore di 2 poemi perduti: "Pragmatica Belli Gallici", di
carattere
storico, e "Aethiopis", di carattere mitologico.
Gaio
Valerio Catullo
(SirmioneVerona, 84? - Roma, 54? a.C.)
VITA.
C.
apparteneva ad una famiglia agiata, e suo padre ospitò più di una
volta
Cesare nella loro villa a Sirmione, sulle rive del Lago di
Garda.
Trasferitosi a Roma per gli studi, secondo la consuetudine dei giovani
di
famiglie benestanti, trovò il luogo adatto dove sviluppare le sue doti
di
scrittore ed entrò a far parte dei neóteroi o poetae novi. Il poeta entrò
in
contatto anche con personaggi di notevole prestigio, come Quinto
Ortensio
Ortalo, grande uomo politico e oratore, e Cornelio Nepote.
C. è
stato definito come il poeta della giovinezza per il suo modo di
scrivere e
di pensare: il tema principale della sua poesia è Lesbia, che il
poeta amò
con tutto il cuore. Il vero nome della donna era Clodia (chiamata
Lesbia,
perchè il poeta implicitamente la paragona a Saffo, la poetessa e la
donna
amorosa di Lesbo), identificabile con la sorella del tribuno Clodio, e
moglie
del proconsole per il territorio cisalpino (tra il 62 e il 61) Q.
Metello
Celere. La storia fra il poeta e Lesbia è molto travagliata: nelle
sue poesie
abbiamo diversi accenni allo stato d'animo che C. provava per
lei, a volte di
affetto e amore, a volte di ira per i tradimenti di lei:
tutto, fino
all'addio finale.
Deciso, infine, ad allontanarsi da Roma, per dimenticare le
sofferenza e
riaffermare il proprio patrimonio, il poeta accompagnò, nel 57,
il pretore
Caio Memmio in Bitinia. Laggiù, in Asia, il giovane C. entra in
contatto con
l'ambiente intellettuale dei paesi d'Oriente. E' probabilmente
dopo questo
viaggio, dopo essersi recato alla tomba del fratello nella Troade
per
compiangerlo, che compone i suoi poemi più sofisticati, una volta tornato
in
patria.
Morì a poco più di 30 anni, per il dolore che Lesbia gli dava
trastullandosi
con i nuovi amanti a Roma.
OPERA.
Il "liber"
catulliano di "carmi" (116 e circa 2300 versi) si può dividere,
su base
metrica, in 3 sezioni:
- (1-60) sono brevi carmi polimetri che C. chiama
"nugae", o coserelle;
- (61-68) sono definiti "carmina docta": elegie, epilli
ed epitalami nei
quali cresce il tono esplicitamente letterario, lasciando
naturalmente
ancora spazio alle caratteristiche catulliane: ovvero,
l'epitalamio per le
nozze di Manlio Torquato; un altro epitalamio, in
esametri, studiata e
felice trasposizione moderna di Saffo; l' "Attis",
poemetto in versi
galliambi, strana evocazione dei riti dedicati alla dea
Cibale, un pezzo di
bravura callimachea; il celebratissimo carme 64, il vasto
epillio per le
nozze di Péleo e Tétide (con inclusa la storia di Arianna),
che è una
piccola epopea mitologica sempre alla maniera di Callimaco; la
traduzione in
esametri della "Chioma di Berenice" di Callimaco, preceduta
dalla dedica all
'amico Ortalo in distici elegiaci; un'elegia epistolare di
gusto
alessandrino, che ricorda il tempo felice dell'amore di Lesbia.
-
(69-116) sono carmi brevi o "epigrammi" in distici
elegiaci.
CONSIDERAZIONI.
*Il I e il III gruppo costituiscono, come
detto, le "nugae", a cui è
consegnata tutta la storia dell'amore di C. per
Lesbia. Le peripezie di
questo romanzo d'amore non ci appaiono molto chiare:
dovettero esservi
giorni (e per lo meno una notte) di felicità, ma anche
molte sofferenze,
giacché Clodia, checché se ne dica, nutriva grande
attenzione per la sua
reputazione e per il suo onore di gran dama, e anche,
probabilmente, perché
lei e C. non concepivano l'amore nello stesso modo.
Egli l'amava con la foga
di un uomo giovane, si compiaceva nel fantasticare
sull'idea che Clodia
fosse per lui "la sposa". A lei, invece, quel nodo
nuziale, dal quale la
morte di Metello la liberò peraltro piuttosto presto,
ripugnava. Clodia,
inoltre, era una donna che amava civettare con uno stuolo
di giovani al suo
fianco. C. era solo uno fra i tanti, mentre avrebbe
desiderato essere
l'unico, in nome degli illusori diritti che dà l'amore.
Quando si avvide che
non era più amato, o quando se ne persuase, lo proclamò
ad alta voce in
versi atroci, dove pretendeva che Lesbia si prostituisse con
chi le
capitava. Seguì la separazione, dolorosa per lui e forse non senza
noie per
lei. "Amo e odio", le scriveva, "tu vuoi sapere perché è così? Non
so, ma so
che è così, e soffro."
*Dunque, il rapporto con Lesbia - cui C.
programmaticamente trasferisce
tutto il suo impegno, sottraendosi ai doveri e
agli interessi del civis
romano (del resto, sebbene vissuto in un'epoca di
grandi cambiamenti
politici, C. nelle sue opere dimostra tra l'altro una
grande indifferenza
per le situazioni e per gli uomini più in vista, quali ad
es. Cesare e
Cicerone) - nato essenzialmente come adulterio, come amore
libero e basato
sull'eros, nel farsi oggetto esclusivo dell'impegno morale
del poeta tende
però, paradossalmente, a configurarsi nelle aspirazioni dello
stesso come un
tenace vincolo matrimoniale, o quantomeno ad un "foedus", un
ibrido - se
vogliamo - dei due valori cardinali dell'ideologia e
dell'ordinamento
sociale romano: la "fides" e la "pietas". Tuttavia, l'offesa
ripetuta del
tradimento (il "foedus violato") produce in C. una dolorosa
dissociazione
fra la componente sensuale ("amare") e quella affettiva ("bene
velle").
*Il II gruppo di carmi, invece, è quello che più lega C. al
movimento
neoterico e quella che più corrisponde alla variante romana del
gusto
alessandrino.
Ma la critica recente ha sottolineato come la
distinzione tra "nugae" e
"carmina docta" non implichi in C. l'impiego di un
diverso impegno
letterario o di una tecnica differente, bensì solo di un
diverso livello
espressivo: si tratta, insomma, sempre di una lirica dotta e
aristocratica
(come i fruitori dell'opera), secondo i canoni estetici dei
neoteroi, anche
laddove l'effetto patetico e certe movenze apparentemente
dimesse potrebbero
far pensare ad un'espressione per così dire popolare (è,
invece, più
giustamente, "ricercata spontaneità").
La stessa lingua è il
risultato di un originale impasto di linguaggio
letterario e "sermo
familiaris".
*L'opera di C., anche se non è ancora quella di un "elegiaco", è
comunque
l'espressione vivente di un sentimento personale e profondo che ha
già
acquistato diritto di cittadinanza nella poesia. Per ciò che conserva
ancora
in sé di tumultuoso, di ricercato e, in qualche modo, di impuro, C. è
da
mettere piuttosto fra i predecessori immediati che fra i poeti augustei
che
formeranno in seguito il "classicismo" della poesia romana. E' però
l'unico
a emergere rispetto alla produzione dei neoteroi, condannata in modo
così
fermo da Orazio nella sua "Ars poetica" in nome del "ritorno ai
valori
classici dell'atticismo", che sarà la parola d'ordine (quanto
meno
ufficiale, ma non sempre seguita) degli augustei.
Tito
Lucrezio Caro
(99? - 55? a.C.)
VITA.
Della vita di L. rimane poco o
nulla: due righe di san Gerolamo ed un
accenno (o forse due) di Cicerone,
entrambi ideologicamente avversi alla
dottrina epicurea e, perciò, quantomeno
da considerare con ponderatezza. Il
silenzio su questo grande poeta, che
dovette provocare comunque un certo
scalpore nella Roma di Cesare, è tuttavia
emblematico della stigmatizzazione
che dovette subire il "De rerum natura",
lontano com'era sia dagli allora in
voga poetae novi di ispirazione
alessandrina, sia dallo stoicismo eclettico
di Cicerone, sia dall'esaltazione
della politica attiva o della guerra fatta
da Catilina e Cesare.
Nato nei
burrascosi tempi della guerra civile fra Silla e Mario,
probabilmente
proveniva da Napoli o da Roma (dalla sua opera e dal modo in
cui si rivolge
all'aristocratico Memmio non si riesce però ancora a capire
se fosse
anch'egli un aristocratico oppure un liberto) e altrettanto
probabilmente
trascorse una vita tormentata da forti passioni, come si
rileva in molti
passi del "De rerum natura". Va, tuttavia, respinta la
teoria di San Girolamo
riguardo la presunta follia di L. causata da un
filtro d'amore: si pensa
infatti che l'accusa sia nata nel IV secolo al fine
di screditare la polemica
antireligiosa del nostro poeta.
L. E L'EPICUREISMO A ROMA. Torna al
sommario
A parte il rigore intollerante di Catone il Censore, la cultura e
il
pensiero greco erano penetrati, attentamente filtrati, nel mondo
romano.
Naturalmente venivano eliminati tutti i risvolti del pensiero
greco
pericolosi per la conservazione dello stato: non a caso Cicerone
trovava un
elemento di forte contrasto nella dottrina di Epicuro:
l'epicureismo era
visto come una dottrina che portava alla dissoluzione della
morale
tradizionale soprattutto perché, predicando il piacere come sommo
bene,
distoglieva i cittadini dall'impegno politico per la difesa
delle
istituzioni. Inoltre l'epicureismo, negando l'intervento divino negli
affari
umani, portava molti svantaggi anche alla classe dirigente la quale
non
poteva più usare la religione come strumento di potere.
Poco si
conosce riguardo la penetrazione dell'epicureismo nelle classi
inferiori
della società romana; probabilmente divulgazioni dell'epicureismo
circolavano
presso la plebe attratta dalla facilità di comprensione di quei
testi e dagli
inviti al piacere in essi contenuti.
Per divulgare a Roma la dottrina
epicurea, L. scelse la forma del poema
epico didascalico. Vi è, tuttavia, una
contraddizione nell'agire di L.: se
da un lato condanna la poesia per la sua
stretta connessione col mito e per
il fatto che può arrecare infelicità agli
uomini, dall'altro ne fa uso per
divulgare i principi della dottrina
epicurea. Con la forma scelta da L.,
così alta e grandiosa, per divulgare il
suo messaggio si è pensato di dover
spiegare anche l'atteggiamento di
Cicerone nei suoi confronti: evidentemente
Cicerone non poteva accettare gli
ideali filosofici epicurei, ma forse è
proprio l'eccezionalità della forma
poetica che ha spinto Cicerone a non
tenere conto di L. nella sua polemica
all'epicureismo.
OPERE.
La sua più grande opera, il "De rerum natura",
fu scritta in esametri e
suddivisa in sei libri: probabilmente non fu finita
o, in qualsiasi caso,
manca di una revisione. Il poema di L. è dedicato a
Gaio Memmio, che fu
amico e patrono di Catullo e Cinna. San Girolamo
asserisce che il "De rerum
natura" fu rivisto e pubblicato da Cicerone pochi
anni dopo la morte di L..
La data di composizione non è sicura: probabilmente
fu composta nel periodo
successivo al 58, anno in cui fu pretore
Memmio.
Il poema è chiaramente articolato in tre gruppi di due libri
(diadi):
Nel I libro, dopo l'inno a Venere, personificazione della forza
della
natura, sono spiegati i principi generali della filosofia epicurea. Nel
II
libro viene illustrata la teoria del clinamen, la caratteristica
più
originale di Epicuro rispetto a Democrito e Leucippo. Il III e IV
libro
costituiscono la seconda coppia che espone l'antropologia epicurea. La
terza
coppia di libri prende in esame la cosmologia: il libro V espone
la
mortalità del mondo, mentre il VI discorre di come la volontà divina
non
influisca minimamente negli affari degli uomini.
Ogni coppia si chiude
con un quadro impressionante di dissoluzione. All'
attacco di ogni libro,
invece, c'è una celebrazione di Epicureo, del suo
coraggio intellettuale e
del suo ruolo storico (e qui L. evidentemente
intende il riferimento anche
come rivolto a se stesso).
Come detto, il "De rerum natura" probabilmente non
ha ricevuto un'ultima
revisione: il poema avrebbe dovuto chiudersi con una
nota serena, in
corrispondenza con il gioioso inno a Venere, e non con il
terrificante
quadro della peste di Atene.
FILOSOFIA.
*Religio. Il
"De rerum natura" si apre con l'invocazione a Venere, dea dell'
amore, unica
a poter placare la sete di sangue di Marte, dio della guerra:
L. vive i
turbolenti anni della rivolta si Spartaco, della guerra di Gallia
e forse
anche delle ostilità fra Cesare e Pompeo, e vorrebbe un ritorno alla
pace,
ostacolata dalle ambizioni e dalla brama di potere della classe
politica
romana.
La via che L. trova per affrontare i mali della vita è la dottrina
di
Epicuro, cantato come simbolo della ratio umana, che fuga i miasmi
della
religione e della superstizione e prende coscienza dello stato
umano.
All'inizio del poema L. invita il lettore a non considerare subito
empia la
dottrina che egli si accinge ad esporre, e a riflettere su quanto,
al
contrario, sia davvero crudele ed empia la religione tradizionale
(emblema
ne è il sacrificio di Ifigenia): la religione è in grado di
sopprimere e
condizionare la vita di tutti gli uomini immettendo nel loro
cuore un seme
di paura: ma se gli uomini sapessero che dopo la morte non c'è
più nulla,
smetterebbero di essere succubi della superstizione religiosa e
dei timori
che essa comporta. Si vede, quindi, già dai primi versi come L.
offra un
nesso tra superstizione religiosa, timore della morte e necessità di
una
speculazione scientifica per ovviare a questo timore: per lui,
dunque,
questi timori nascono dall'ignoranza delle leggi meccaniche che
governano il
mondo.
L'accesa lotta alla religio è certamente la parte piú
eterodossa della
filosofia di L.: Epicuro non aveva cosí marcate tendenze
atee, auspicava
piuttosto un ritorno ad un culto piú semplice.
*Natura.
Per insegnare agli uomini come la dottrina epicurea possa servire
da
tetrafarmaco, e combattere cioè la paura per morte, malattia, dolore e
dei,
L. inizia la sua descrizione della natura. Tutto ciò che ci circonda
è
formato da piccolissimi granelli indivisibili, gli atomi, i semina rerum
o
genitalia corpora come li chiama il poeta per enfatizzare il loro
originario
ruolo di creazione. Ogni pianta, pietra, uomo è formato da atomi,
e cosí
persino l'animo umano; ed ogni cosa è destinata a nascere e disfarsi
in
eterno; solo gli atomi sono immortali e non i loro aggregati. In
questo
mondo, regolato dalle leggi meccaniche che governano le
particelle
elementari, c'è comunque spazio per la libertà: all'origine
dell'universo c'
è una deviazione del moto atomico, un clinamen, che ha dato
il via alla
formazione delle cose ed al gioco infinito della
natura.
*Morte. Dopo aver descritto la natura della materia l'autore invita i
suoi
lettori (rappresentati da Memmio) ad accettare la morte come qualcosa
di
ineluttabile e comunque esterna all'uomo: quando noi siamo non c'è
morte,
quando c'è la morte noi non siamo: invece di preoccuparsi della
propria fine
l'uomo dovrebbe occuparsi della vita e non sprecarla poltrendo
od inseguendo
stupide ambizioni (E tu esiterai, e per di piú t'indignerai di
dover morire?
Tu cui è morta la vita mentre ancora sei vivo e vedi e consumi
nel sonno la
parte maggiore del tempo, e pure da sveglio dormi e non smetti
di vedere
sogni, e hai l'animo tormentato da vane angosce, né riesci a
scoprire qual
sia cosí spesso il tuo male, mentre ebbro e infelice ti
incalzano da ogni
parte gli affanni e vaghi oscillando nell'incerto errare
della mente - III,
vv. 1045-1052).
*Sensi e amore. Il IV quarto tratta dei
sensi, della loro veridicità, di
come possano essere turbati. I sensi, per
L., non fanno altro che captare
dei flussi atomici particolari: sentiamo
perché arrivano degli atomi alle
nostre orecchie e vediamo perché ne arrivano
altri ai nostri occhi. È dai
sensi che hanno origine ogni forma di conoscenza
e la ragione umana, non
crollerebbe soltanto tutta la ragione, ma anche la
vita stessa rovinerebbe
di schianto, se tu non osassi fidare nei sensi (IV,
vv. 507-8).
Anche stavolta, dopo aver cercato di trasmette l'atarassia
epicurea, L. si
allontana dalla calma del suo maestro e descrive con profonda
partecipazione
quanto piú può turbare i sensi, le passioni amorose e carnali,
a cui dedica
i vv. 1026-1287, di cui diamo qualche saggio: Brucia l'intima
piaga (l'
amore) a nutrirla e col tempo incarnisce, divampa nei giorni
l'ardore, l'
angoscia ti serra, se non confondi l'antico dolore con nuove
ferite, e le
recenti piaghe errabondo lenisca d'instabili amori, e ad altro
tu possa
rivolgere i moti dell'animo (vv. 1068-1073); Infatti proprio nel
momento del
pieno possesso, fluttua in incerti ondeggiamenti l'ardore degli
amanti che
non sanno di cosa prima godere con gli occhi o con le mani.
Premono stretta
la creatura che desiderano, infliggono dolore al suo corpo, e
spesso le
mordono a sangue le tenere labbra, la inchiodano coi baci, perché
il piacere
non è puro, e vi sono oscuri impulsi che spingono a straziare
l'oggetto,
qualunque sia, da cui sorgono i germi di quella furia (vv.
1076-1083).
Dopo aver condannato l'amore come sofferenza (v.vv. 1068-1074),
furore (vv.
1079-1083), amarezza (v. 1134), rimorso (v. 1135), gelosia (vv.
1139 e
segg.), cecità (v. 1153), miseria (v. 1159) ed umiliazione (vv.
1177-1179),
L. cambia tono: "È proprio lei che talvolta con l'onesto suo
agire, / l'
equilibrio dei modi, la nitida eleganza della persona, / ti rende
consueta
la gioia d'una vita comune. / Nel tempo avvenire l'abitudine
concilia l'
amore; / ciò che subisce colpi, per quanto lievi ma incessanti, /
a lungo
andare cede, e infine vacilla". Appare diverso, teneramente
malinconico, più
paterno ("E spesso alcuni [...] trovarono fuori [di casa]
una natura affine,
così da poter adornare di prole la loro vecchiaia", vv.
1254-6).
Personalità contrastata fra ratio e furor, L., come scrisse
Schwob,
"conoscendo esattamente la tristezza e l'amore e la morte, continuò
a
piangere e a desiderare l'amore e a temere la morte".
*Civiltà e peste.
Nel libro seguente il poeta descrive dettagliatamente la
formazione del mondo
e la nascita della civiltà: I re cominciarono a fondare
città e a stabilire
fortezze, per averne difesa e rifugio a sé stessi, e
divisero i campi e il
bestiame, assegnati a seconda della forza, dell'
ingegno e della bellezza di
ognuno (V, vv. 1008-1111), senza però cadere in
tentazioni positiviste: con
la nascita della civiltà nascono anche l'
ambizione e la cupidigia, contro
cui L. si scaglia con forza: Lascia dunque
che si affannino invano e sudino
sangue coloro che lottano sull'angusto
sentiero dell'ambizione, poiché sanno
per bocca d'altri e dirigono il loro
desiderio ascoltando la fama piuttosto
che il proprio sentire; né questo
accade e accadrà piú di quanto è accaduto
in passato (vv. 1131-1135).
Insomma, L. pone molta attenzione sul progresso
dell'uomo e ne delinea gli
effetti positivi e quelli negativi. Tra questi
ultimi ha molto rilievo il
fatto che il progresso ha portato con sé una grave
decadenza morale e il
sorgere di bisogni innaturali. Epicuro aveva infatti
prescritto di evitare i
desideri innaturali e non necessari, e di badare solo
al soddisfacimento di
quelli necessari: gli unici requisiti essenziali per
essere un uomo
veramente felice sono il non provare la fame, la sete e il
freddo. Bisogna
abbandonare gli sprechi inutili per indirizzarsi verso i
piaceri naturali.
Anche nel discusso finale dell'opera, la descrizione della
tremenda peste di
Atene, il poeta si distacca dalla pretesa leggerezza
dell'epicureismo, per
immergersi completamente nella malattia e nelle morti:
probabilmente l'opera
non doveva avere questo finale (è comunque appurato che
dovesse essere il
sesto l'ultimo libro e non moltissimi versi alla chiusura
del poema),
mancando la descrizione delle sedi degli dei e la spiegazione di
come l'
epicureismo possa aiutare ad affrontare persino i mali piú oscuri
come la
peste; il passo rimane comunque emblematico del tormentato animo
lucreziano,
che in questa descrizione è piú vicino al gusto dell'orrido di
stoici come
Seneca o Lucano che non al calmo filosofo del
Giardino.
CONSIDERAZIONI.
Prima del "De rerum natura" la letteratura
romana non aveva prodotto opere
di poesia didascalica di grande impegno;
d'altra parte, L. si differenzia
notevolmente rispetto ai poeti ellenistici
in quanto ha come unico scopo
quello di descrivere e spiegare ogni aspetto
importante della vita dell'uomo
e del mondo, di convincere il lettore della
validità della dottrina
epicurea. La tradizione ellenistica ricerca invece la
sua ispirazione negli
argomenti tecnici, quasi idealizzanti. La
consapevolezza dell'importanza
ella materia e delle informazioni date
determina un particolare tipo di
rapporto tra L. e il lettore discepolo:
questo viene continuamente esortato
e minacciato affinché segua con
rettitudine i precetti e il percorso di
felicità imposti
dall'epicureismo.
Un ulteriore differenza tra la poesia didascalica
ellenistica e quella di L.
sta nel fatto che quest'ultimo ricerca le cause
dei fenomeni, e propone al
lettore una verità, una ratio sulla quale è
obbligato ad esprimere un
giudizio, mentre la prima si limita a descrivere in
maniera empiristica tali
fenomeni. Per L. non vi è nulla di cui meravigliarsi
nell'osservazione di
questo o quel fenomeno poiché esso è connesso
necessariamente con una regola
oggettiva: non può trarne stupore chi abbia
capito il funzionamento di tale
regola. Alla retorica del mirabile egli
sostituisce la retorica del
necessario (necesse est è una formula molto usata
nel poema di L.).
I toni grandiosi e gli scenari sublimi del poema sono
pensati per spronare
il lettore a scegliere anch'egli un modello di vita
forte e alta: il lettore
di L. è chiamato a trasformarsi in eroe, a farsi
pronto e forte come la
poesia che egli legge. Il destinatario ideale di L. è
colui che sa adeguarsi
alla forza sublime di un'esperienza sconvolgente: in
questo modo la dottrina
degli atomi è descritta non solo in sé, ma anche
nelle reazioni di vertigine
che può provocare nel lettore. Il rapporto
docente allievo diventa nel "De
rerum natura" un centro di tensione e un tema
problematico; basta pensare
per contrasto a quanto fosse pacifica la
struttura didascalica dei poemi
ellenistici. Una delle caratteristiche
principali del poema è la rigorosa
struttura argomentativa. L. usa anche il
sillogismo.
Il libro che testimonia la perizia argomentativa di L. è il III,
dedicato
alla confutazione del timore della morte. Pur avendo
dimostrato
scientificamente la mortalità dell'anima, L. si rende conto che
ciò non
basta per distogliere l'uomo dalla paura di lasciare la propria vita.
Al
fine di convincerlo L., nella parte finale del libro, dà la parola
alla
Natura stessa, che si rivolge all'uomo: se la tua vita è stata bella e
piena
di gioie ti puoi allontanare da lei come un convitato sazio e felice
dopo un
banchetto; se invece è stata triste, che senso ha continuare a
vivere
un'esistenza infelice? In questo libro è evidente il contatto di L.
con la
letteratura diatribica (ossia l'accorgimento di far parlare dei
personaggi
fittizi di particolare interesse).
I critici sono molto confusi
riguardo al binomio autore e narratore: benché
siano la stessa persona non
devono essere sovrapposte meccanicamente. Come
visto, un'attenta lettura
dell'opera induce a constatare che la tensione
dell'autore è sempre rivolta a
conseguire il convincimento razionale del
lettore, a trasmettergli i precetti
di una dottrina di liberazione morale.
L. è fortemente contrario alle
insensatezze della passione amorosa poiché
questa non è certamente un bisogno
necessario e deve essere, di conseguenza,
esclusa dai piaceri da conseguire.
Probabilmente avranno agito anche stimoli
culturali diversi, quali la volontà
di contrapporsi all'ideologia erotica
dei neoteroi. La volontà di L. è
allora, come già detto, quella di ricercare
un indirizzo stilistico elevato
che accolga nella sua forma sublime gli
elementi della satira e della
diatriba.
STILE.
Se le teorie epicuree vedevano nella poesia un
passatempo per allietare l'
animo, L. la considera come il miele che,
cosparso sull'orlo del bicchiere,
aiuta il bambino a prendere la medicina
(nam veluti pueris abstinthia taetra
medentes / cum dare conantur, prius oras
pocula circum / contingunt mellis
dulci flavoque liquore - lib V vv. 11-13):
la sua poesia è scientifica,
chiara (obscura de re tam lucida pango /
carmina), in netta rottura coi
vatum terriloquis dictis di molti poeti che
l'hanno preceduto (anche se può
sembrare strano che la ricerca della
chiarezza si accompagni ad un frequente
uso di arcaismi e grecismi).
Il
commento di Cicerone riguardo il "De rerum natura" testimonia che
egli
ammirava in L. non solo l'acutezza del pensatore, ma anche le
grandi
capacità di elaborazione artistica. Anche lo stile, come
l'organizzazione
complessiva della materia da trattare, doveva piegarsi al
fine di persuadere
il lettore. Si spiegano sotto questa luce le frequenti
ripetizioni che, a
una prima vista, potevano sembrare delle semplici
imperfezioni stilistiche.
Anche l'invito all'attenzione del lettore è
ripetuto spesse volte. Non
bisogna trascurare inoltre che la lingua latina
mancava di alcuni vocaboli
tecnici e non era quindi in grado di esprimere
certi concetti della
filosofia greca, L. si trovò costretto così a dover
inventare nuove
perifrasi e nuovi vocaboli: il poeta sfrutta molti vocaboli
della poesia
arcaica e molti altri ne crea ex novo. Vi è inoltre un uso
abbastanza
frequente di allitterazioni, assonanze, costrutti arcaici,
infiniti passivi
in -ier , il prevalere della desinenza bisillabica -ai e
l'uso
dell'enjambement.
L. dimostra di avere una buona conoscenza della
letteratura greca, come
testimoniano le riprese da Omero e Platone e la
descrizione della peste di
Atene. Il registro del poema è quello
dell'entusiasmo poetico posto a
servizio della didattica: ne scaturisce uno
stile severo, capace di durezze
ed eleganze, pronto alla commozione ma anche
all'invettiva profetica:
comunque sempre grandioso.
Marco Terenzio
Varrone
(Reate, oggi Rieti, in Sabina, nel 116 - 27
a.C.)
VITA.
Studiò a Roma e ad Atene. Difensore della tradizione, si
schierò dalla parte
di Pompeo. Cesare gli perdonò e gli affidò la biblioteca
pubblica che
intendeva instaurare in Roma. Pare sia stato anche consigliere
di Augusto
per le questioni religiose.
OPERE.
Ancor più che come
poeta moralizzante, V. agì sul suo tempo come erudito. La
sua riflessione si
estese a tutti i campi che si presentavano agli
"antiquari" del suo secolo:
dal passato della lingua latina ("De lingua
latina") alla storia letteraria
di Roma (De poetis, De poematis, eccetera,
con particolare riguardo per i
problemi sollevati dal teatro di Plauto),
alla religione romana e alla
"vetustà" delle istituzioni e dei costumi
profani ("Antiquitates rerum
humanarum et divinarum"), fino al diritto (15
libri di diritto civile), alla
cronologia generale, alla genealogia delle
famiglie nobili, passando ancora
per la geografia, l'agricoltura ("De re
rustica"), la geometria,
l'aritmetica, per concludere infine con un quadro
dei differenti sistemi
filosofici.
Ecco i contenuti delle opere:
- "De rustica", in 3 libri: il I
tratta dell'agricoltura in generale; il II
dell'allevamento del bestiame; il
III degli animali da villa e da cortile.
Non destinata all'istruzione pratica
del fattore (se non nelle apparenze),
ma scritta piuttosto per alimentare e
compiacere l'ideologia del ricco
proprietario terriero - secondo il
presupposto del processo di
concentrazione delle terre - l'opera in qualche
modo "estetizza" la vita
agricola.
Sue caratteristiche: la profonda
conoscenza della materia, la formula
dialogica - spesso briosa ed arguta,
quando non è soffocata dall'
rudizione - e l'amore per la sana vita dei
campi.
- "Antiquitates rerum humanarum et divinarum" (41 libri): da S.
Agostino,
che ce ne ha conservato lo schema strutturale, apprendiamo che essa
si
divideva in due parti, dedicate la I alle antichità profane (libri 1-25),
la
II a quelle sacre (libri 26-41).
La storia - come è qui concepita - è
soprattutto storia di costumi, di
istituzioni, e anche di "mentalità"; è la
storia collettiva del popolo
romano, sentito come un organismo unitario in
evoluzione.
- "Imagines" o "Hebdomades" (15 libri), 700 ritratti di uomini
illustri,
latini e greci, accompagnato ognuno da un elogio in versi e da una
notizia
in prosa, disposti in 7 su un foglio e distribuiti in diverse
categorie:
capitani, politici, poeti, ecc.
- "De lingua latina". Primo
trattato sistematico di grammatica latina, era
diviso in 3 parti:
sull'etimologia (libri II-VII), la teoria delle
declinazioni (VIII-XIII) e la
sintassi (XIV-XXV).
Dei libri superstiti (V-X), i primi 3 parlano dunque di
etimologia, mentre
gli altri della flessione, e in particolare discutono la
questione, allora
in voga, dell' "anomalia" e dell' "analogia". V. propende
sostanzialmente
per l'ultima.
- "Logistorici" (76 libri), serie di
trattatelli: ad es. "Marius, de
fortuna", "Catus, de liberis educandi".
-
"Discipline" (9 libri), una vera e propria enciclopedia delle
arti
liberali;
- "Saturae Menippeae" (150 libri), in chiave
etico-didascalica ad emulazione
dei prosimetri di Menippeo di Gàdara,
filosofo cinico, severo fustigatore
dei corrotti costumi.
V. è uno dei
primi e, forse, il più completo degli enciclopedisti
romani.
CONSIDERAZIONI.
Il suo pensiero è chiaro, sebbene egli abbia
la tendenza a usare e ad
abusare di suddivisioni sistematiche non sempre
rispondenti alla realtà.
Dall'antichità in poi, ha costituito la fonte
inesauribile delle
informazioni cui hanno attinto tutti gli autori successivi
e in particolare
sant'Agostino, che da lui ha ricavato moltissimi elementi
relativi alla
religione romana. (morì, infatti, solo nel 27 a.C.). Virgilio,
da parte sua,
ha molto utilizzato il suo trattato sull'agricoltura (che è fra
le fonti
delle Georgiche).
V. fornisce perciò al proprio secolo
l'impalcatura delle conoscenze sulle
quali aspira ad appoggiarsi una
letteratura che si rivela sempre meno una
manifestazione di pensiero e sempre
più un fenomeno di "stile".
Marco Tullio Cicerone
(Arpino 106 -
Formia 43 a.C.)
VITA.
C. nasce da una famiglia agiata equestre: è
dunque un "uomo nuovo": egli
sarà il primo della sua famiglia ad accedere
alle magistrature: lo dovrà al
proprio talento, ma anche agli appoggi che,
sin dall'adolescenza, troverà
presso le famiglie nobili.
C. compie studi
di retorica e filosofia a Roma, discepolo del giurista Q.
Muzio Scevola e
ascoltatore assiduo di Marco Antonio e di Licinio Crasso, i
due oratori più
apprezzati nel senato e fra il popolo. Nella casa di
Scevola, venne a
contatto con l'aristocrazia intellettuale romana raccolta
intorno al "circolo
degli Scipioni" (Scevola era il genero di Lelio), al cui
interno erano difesi
e salvaguardati i valori della gravitas, della dignità
personale, ma anche il
gusto della cultura.
Queste impressioni giovanili s'imprimeranno
duraturamente nell'animo di C.:
verso la fine della sua vita, ogni volta che
vorrà animare, in un dialogo,
le sue idee più care, metterà in scena le
figure di quel mondo che sarà per
lui una specie di età aurea della
repubblica, un'età della quale egli aveva
conosciuto solo il crepuscolo. C.
vedeva anche, intorno a sé, il quadro
animato degli scrittori, dei poeti, dei
filosofi, dei grammatici venuti
dalla Grecia, che a nessuno sarebbe più
venuto in mente di bandire, e di cui
anzi i più nobili romani ricercavano la
compagnia: il poeta Archia, i
filosofi Diodoto e Fedro, stoico il primo,
epicureo il secondo, Filone di
Larissa, rappresentante della "Nuova
Accademia", che avrebbe avuto su di lui
una notevole influenza.
Questi
primi studi furono interrotti dalla Guerra sociale, alla quale C.
partecipò
nello Stato maggiore di Pompeo Strabone e poi in quello di Silla.
Non appena
concluso questo servizio militare, obbligatorio per chi volesse
avviarsi alla
carriera politica, C. cominciò a intervenire ai dibattiti nel
Foro: nell'81
debutta come avvocato e un anno dopo difende Sesto Roscio,
accusato di
parricidio, contro importanti esponenti del regime sillano.
Vinse la causa
del proprio cliente ma, probabilmente su consiglio di coloro
che avevano
utilizzato il suo giovane ingegno, partì per l'Oriente per farsi
dimenticare
e rimanere in attesa che Silla abbandonasse il potere.
Tra il 79 e il 77
compie, dunque, il viaggio in Grecia e in Asia, dove
studia filosofia e
retorica per migliorare il proprio linguaggio. Nel 75
diventa questore in
Sicilia e nel 70 gli verrà chiesto di sostenere l'accusa
di concussione dei
siciliani contro l'ex governatore Verre ("Verrine"): il
processo non era
limitatamente giudiziario, ma aveva implicazioni politiche,
da to che tramite
Verre veniva messo in discussione l'intero sistema del
regime oligarchico: C.
accettò, correndo il rischio di separarsi dai suoi
protettori. Ortensio
Ortalo, più anziano di C. e oratore rinomato per il suo
talento, assunse il
compito della difesa. C. portò avanti le cose in tal
modo, riunì
testimonianze così schiaccianti, che Verre non osò neppure
perorare la sua
causa e se ne andò in esilio dopo un solo giorno di
dibattimento.
Edile
nel 69, pretore nel 66, C. è eletto in ciascuna delle consultazioni a
cui gli
è consentito di partecipare come candidato, con una schiacciante
maggioranza
di voti. Per lui, sono ora schierate non tanto le famiglie
nobili ma, oltre
al popolo, che è sensibile alla sua parola, le famiglie
degli equiti,
l'ordine equestre del quale è egli stesso originario. Nel
periodo in cui è
pretore, C. pronuncia un discorso importante, il "Pro lege
Manilia", a favore
del progetto di conferire a Pompeo poteri straordinari in
Oriente, dove la
guerra contro Mitridate si prolunga da tempo. Gli
aristocratici erano ostili
a questa legge, per timore di queste insolite
procedure. Ma l'assemblea
popolare seguì il parere di C., e la legge fu
approvata.
Nel 63 diviene
finalmente console, e nel periodo della sua carica si schiera
con fermezza
contro un altro progetto che ledeva gli interessi
dell'aristocrazia, una
legge agraria appoggiata sottobanco da Cesare. Le
quattro orazioni sulla
legge agraria (De lege agraria), di cui possediamo
solo una parte, sbarrarono
la strada a questa mozione.
Lo stesso anno C. ebbe la responsabilità di
difendere l'ordine contro una
pericolosa congiura ordita da L. Sergio
Catilina ("Catilinarie") con l'aiuto
di alcuni altri nobili che speravano di
ripetere, a proprio vantaggio,
l'avventura di Silla. La situazione a Roma si
presentava estremamente
complessa. Catilina poteva contare sulla complicità
di numerose personalità,
alcune delle quali si sottrassero quando si
trovarono di fronte al pericolo.
Ma fu necessaria tutta l'energia del console
(il suo collega era sospetto di
simpatie a favore dei congiurati), per
evitare che Roma fosse incendiata e
le maggiori autorità dello Stato
assassinate.
C. ebbe dunque la meglio e, sostenuto da un senatoconsulto, fece
giustiziare
i congiurati che era stato possibile arrestare. Gli altri,
compreso
Catilina, perirono sul campo di battaglia ai primi dell'anno
successivo.
In quel momento, C. poteva dire di aver realizzato intorno a sé
l'unione di
tutte le "persone oneste", gli Optimates, ma il trionfo non fu di
lunga
durata. Dopo il consolato di Cesare (nel 59), le violenze del
partito
popolare condotto da P. Clodio Pulcro, allora tribuno, portarono alla
messa
sotto accusa dell'ex console, per aver fatto giustiziare, senza
processo,
dei cittadini. La coalizione degli Optimates non fu in grado di
resistere
alla volontà dei triumviri, Cesare, Pompeo e Crasso e, mentre
Cesare si
avviava verso la Gallia di cui s'iniziava la conquista, C. fu
costretto in
esilio in Grecia (marzo 58).
Torna tuttavia a Roma l'anno
seguente e cerca di allacciare rapporti con il
triumvirato. Fu questa, per
lui, l'occasione di un'intensa attività
oratoria: ringraziamenti ufficiali
(Oratio cum Senatui gratias egit, Oratio
cum populo), invettive al senato
contro coloro che l'avevano tradito (In
Pisonem, eccetera).
Ma in una
repubblica lacerata da ambizioni feroci, più che altro si dedica a
scrivere
le sue opere maggiori, non partecipando che marginalmente alla vita
politica:
nel 55 pubblica il "De oratore", nel 51 portò a termine il "De
rupubblica".
Nel 51 è governatore in Cilicia.
In seguito allo scoppio della guerra civile,
nel 49, dopo molte esitazioni
si unirà al partito del senato, capeggiato da
Pompeo. Quando quest'ultimo
viene sconfitto, C. ottiene facilmente il perdono
di Cesare. Nel frattempo,
divorzia dalla moglie Terenzia e sposa Publilia.
Nel 45 gli muore la figlia
Tullia; inizia la composizione di una lunga serie
di opere filosofiche. Nel
44, morto Cesare, rientra nella vita politica e
comincia la sua lotta contro
Antonio ("Filippiche"). Ma dopo il voltafaccia
di Ottaviano, che stringe il
II triumvirato, il suo nome viene inserito nelle
liste di proscrizione:
muore nel 43 sotto i colpi dei sicari di
Antonio.
CONSIDERAZIONI SUL PERSONAGGIO STORICO E SUL SUO
PENSIERO
POLITICO-FILOSOFICO.
*Degno testimone e protagonista del
tramonto della repubblica, C. fu
politicamente un conservatore "moderato":
l'idea che cercherà di difendere
nel corso della sua carriera sarà quella
dell'egemonia di un blocco sociale
("concordia ordinorum"), sostanzialmente
la classe possidente dei senatori e
dei cavalieri: C., grande avvocato e
manipolatore delle parole, rivela la
sua ars dicendi come una tecnica
sapiente e produttiva, funzionale al
dominio dell'uditorio e, quindi, ottimo
strumento politico. Il fine
dell'oratoria e della filosofia ciceroniane è
quello di dare una solida base
ideale, etica, politica a una classe dominante
il cui bisogno di ordinare
non si traduca in ottuse chiusure (ma rispettasse
gl'ideali dell'
"humanitas"), cui l'ossequio per la tradizione antica non
impedisca
l'assorbimento della cultura greca. Quindi l'intero operato di C.
si può
interpretare come la ricerca di una difficile situazione di equilibrio
fra
istanze di ammodernamento e necessità di conservazione delle
leggi
tradizionali. La stessa collaborazione con i triumviri fu una risposta
al
bisogno di un governo autorevole e anche in questo caso C. si preoccupò
di
mantenere saldo il potere del senato.
A C. mancarono le condizioni per
crearsi il seguito clientelare o militare
necessario a far trionfare la sua
linea politica; inoltre sottovalutò il
peso che gli eserciti personali
avrebbero avuto nella soluzione della crisi;
infine non tenne conto del fatto
che i ceti possidenti avrebbero potuto
ritenere che le loro esigenze fossero
meglio garantite dalla politica di
Cesare.
*Fedele alla tradizione come
visto, C. non può immaginare un mondo dove
l'impegno nella gestione della
cosa pubblica non sia il valore supremo. Ed è
forse qui che si situa il
centro e il fine ultimo di tutti i suoi pensieri.
Ciò, ad esempio, spiega le
sue opzioni filosofiche, la ripugnanza che prova
nei confronti
dell'epicureismo, non perché Epicuro facesse del piacere il
bene supremo, ma
perché giudicava la felicità incompatibile con la
partecipazione ai pubblici
affari. Allo stesso modo, le sue simpatie per lo
stoicismo si rivolgevano a
quegli aspetti della dottrina che mettevano in
luce l'importanza delle virtù
sociali, la giustizia, l'umanità, il coraggio
civico, la devozione alla
patria.
Durante il viaggio in Grecia, C. aveva seguito gli insegnamenti dei
filosofi
e, fedele alla sua prima vocazione, quello del nuovo capo
dell'Accademia,
Antioco di Ascalona, successore di Filone di Larissa. In
questo modo diede
inizio alla formazione di quella che possiamo definire la
sua dottrina
filosofica: un "probabilismo pragmatico" che subordinava la
conoscenza
teorica (giudicata, nella maggior parte dei casi, inaccessibile
nella sua
perfezione) all'efficacia e soprattutto al valore morale
dell'azione. Così
egli risolveva, a suo modo, il problema dell'eloquenza,
rispetto ai termini
della questione posti da Platone: non era più necessario
utilizzare tecniche
di persuasione troppo sofisticate per arrivare alla
verità; la verità
equivale a ciò che è onesto (ciò che
conviene).
Un'ulteriore elaborazione consentiva inoltre di risolvere lo
scetticismo
degli accademici, grazie alle soluzioni "medie" immaginate da
Panezio,
secondo il quale il bene perfetto del saggio stoico, situato troppo
al di
sopra della portata umana, era sostituito dal concetto di
azione
"appropriata" e di "dovere".
In seguito, nel suo "De Officiis", C.
esporrà questa dottrina di Panezio e
ne farà un testamento filosofico
dedicato al figlio Marco. E' evidente, in
tal modo, come possa essere
giustificato (e, in una certa misura, anche
criticato) l'epiteto di
"eclettico" affibbiato al C. filosofo, laddove però
questo eclettismo non era
fatto di elementi presi a destra e a manca, bensì
era una sintesi autonoma
operata in funzione di bisogni spirituali ben
definiti e soprattutto in
funzione della necessità di giustificare l'azione.
*In tutto questo, C. resta
romano, nonostante la sua immensa cultura greca.
Dopo il soggiorno ateniese,
recatosi a Rodi, ritrovò il rètore Molone, che
aveva frequentato già a Roma e
dal quale, facendo tesoro delle esperienze
oratorie già fatte, accettò, con
maggiore docilità e anche con più largo
profitto, alcune lezioni. La sua
eloquenza, appassionata e sensibile, era
naturalmente incline a una violenza
espressiva che l'avvicinava
all'asianesimo. A Rodi, e senza dubbio anche
sotto l'influenza del pensiero
stoico che Posidonio insegnava in quel periodo
nell'isola, essa si addolcì,
temperò la sua veemenza.
*Un ultima
notazione, sullo stile: in generale la prosa di C. risulta
sintatticamente
assai complessa e aritmicamente scandita, ma insieme limpida
ed attentissima
alle sfumature di significato. C., del resto, codifica
quello che sarà il
linguaggio della filosofia e in generale della
cultura
latina.
OPERE.
*Oratoria. L'attività oratoria di C. si
intreccia inevitabilmente con le
vicende politiche di Roma negli ultimi
cinquanta anni di repubblica. Queste,
grosso modo, le tappe:
- nell'81
egli debutta nel foro come avvocato;
- nell'80, durante la dittatura di Lucio
Silla, C. si espone accettando di
difendere Sesto Roscio, accusato di
parricidio da alcune potenti figure
amiche del dittatore. Il padre di Sesto
Roscio era stato ucciso su mandato
di due suoi parenti, in combutta con Lucio
Cornelio, liberto di Silla: gli
assassini, per avere le mani pulite, decisero
di sbarazzarsi del figlio
accusandolo di avere ucciso il padre. C. dovette
stare molto attento
nell'accusare personaggi vicini al potente dittatore e,
per non sembrare
sovversivo, copriva di lodi Silla: il bravo avvocato non era
ostile al buon
governo sillano ma, come molti, avrebbe preferito porre un
freno agli
arbitrî e alle proscrizioni. L'orazione "Pro Roscio Amerino" ebbe
successo e
Sesto Roscio fu ritenuto innocente.
- nel 70 i siciliani gli
proposero di sostenere l'accusa nel processo da
essi intentato contro l'ex
governatore Verre, che aveva sfruttato la
provincia pensando solo ai propri
interessi. C. raccolse le prove in tempo
brevissimo, il che permise di
anticipare i tempi del processo: al dibattito,
C. non fece in tempo a esibire
tutte le prove che aveva raccolto e
organizzato: dopo solo pochi giorni Verre
fuggì dall'Italia e venne
condannato in contumacia. Successivamente C.
pubblicò le "Verrinae" che si
rivelarono come un documento storica di grande
importanza per conoscere i
metodi di cui si serviva l'amministrazione romana
nelle province (diventare
governatore di una ricca provincia era un'occasione
dalla quale si potevano
trarre grandi profitti grazie allo sfruttamento). La
vittoria su Ortensio,
difensore di Verre, fu anche una vittoria in campo
letterario: lo stile
delle "Verrinae" è già completamente maturo, C. ha
eliminato alcune
esuberanze, il periodare è armonioso, architettonicamente
complesso, ma la
sintassi è estremamente duttile e, se l'occasione lo
richiede, C. non fugge
dall'uso di un fraseggio coinciso e martellante.
-
nel 66 C., pretore nel senato, parla a favore del progetto di
legge
presentato dal tribuno Manilio, che prevedeva la concessione a Pompeo
di
poteri straordinari su tutto l'Oriente, minacciato tra le altre cose
da
Mitridate, re del Ponto ("Pro lege Manilia"). Parlando di fronte al
popolo
in favore di tale legge, C. insisté sull'importanza dei tributi
che
affluivano dalle province d'Oriente; la popolazione di Roma sarebbe
stata
privata di tale beneficio se Mitridate avesse continuato la sua azione.
In
realtà, a essere minacciati dalla situazione che si veniva a creare
in
oriente erano soprattutto gli appartenenti al ceto finanziario
e
imprenditoriale, cui C. era legato. C. era completamente contrario
a
qualsiasi progetto di distribuzione delle terre pubbliche ai ceti
meno
abbienti; egli cominciava a vedere la via d'uscita dalla crisi
che
minacciava la repubblica nella concordia tra ceti abbienti, senatori
e
cavalieri (concordia ordinum).
- C. divenne console nel 63 e soffocò la
congiura di Catilina ai danni dello
stato: da allora in poi sarebbe stato il
teorizzatore di quella "concordia
ordinum" che lo aveva portato al potere. Le
più celebri orazioni consolari
di C. sono le 4 "Catilinarie", con le quali
egli svelò le trame sovversive
che il nobile decaduto aveva ordito una volta
vistosi sconfitto nella
competizione elettorale, lo costrinse a fuggire da
Roma e giustificò la sua
decisione di far giustiziare i suoi complici senza
processo. Nella I
Catilinaria C. fa uso di un artificio retorico chiamato
prosopopea
(personificazione) della patria, che è immaginata rivolgersi a
Catilina con
parole di biasimo.
- nel 62 C. compose la "Pro Archia poeta",
l'orazione pronunciata in difesa
del poeta Archia, venuto a Roma nel 102 e
accusato di usurpazione della
cittadinanza romana. Essa è celebre per
l'appassionata difesa della poesia
che contiene e per la rivendicazione della
nobiltà degli studi letterari.
- richiamato dall'esilio nel 57, trova Roma in
preda all'anarchia: si
fronteggiavano le opposte bande di Clodio e di Milone
(amico personale di
C.). Fu in tale clima che nel 56 C., trovandosi a
difendere Sestio ("Pro
Sestio"), un tribuno accusato da Clodio di atti di
violenza, espose una
nuova versione della propria teoria sulla concordia dei
ceti abbienti. La
concordia ordinum si era rivelata fallimentare: C. ne
dilata ora il concetto
in quello di consensus omnium bonorum, cioè la
concordia attiva di tutte le
persone agiate e possidenti, amanti dell'ordine
politico e sociale. I boni,
una categoria che attraversa verticalmente gli
strati sociali esistenti,
senza identificarsi con alcuno di essi in
particolare, saranno d'ora in poi
il principale destinatario della
predicazione etico politica di C.. Il
dovere dei boni è quello di non
rifugiarsi egoisticamente nel perseguimento
dei propri interessi privati, ma
di fornire sostegno attivo agli uomini
politici che rappresentano la loro
causa. L'esigenza di un governo più
autorevole spinge tuttavia C. a
desiderare che il senato e i boni si
affidino alla guida di personaggi
eminenti e illustri: questa teoria verrà
approfondita nel "De repubblica" ed
è la principale causa che portò C. ad
avvicinarsi al triumvirato. Il bravo C.
cerca di fare in modo che il potere
dei triumviri non prevarichi su quello
del senato ma si mantenga nei limiti
delle istituzioni repubblicane.
- tra
le orazioni anticlodiane occupa un ruolo particolare quella in difesa
di
Marco Celio Rufo ("Pro Celio Rufo"), un giovane brillante e amico di
C..
Celio era stato l'amante di Clodia e ora lo avevano condannato di
tentato
avvelenamento nei confronti di quest'ultima. Attaccando Clodia, in
cui
indicò l'unica regista di tutte le congiure contro Celio, C. ebbe modo
di
sfogare il suo rancore nei confronti del fratello di lei: la donna
è
descritta come una persona infima e viene accusata pure di
rapporti
incestuosi. Tramite la descrizione della vita di Celio, C. ha modo
di
dipingere uno spaccato della società romana del suo tempo, e si sforza
di
giustificare agli occhi della giuria i nuovi costumi che la gioventù
ha
assunto da tempo e che possono destare scandalo solo allo sguardo
di
moralisti troppo severi e attaccati al passato.
C. qui ci propone un
originale modello culturale, teso a ricondurre i nuovi
comportamenti
all'interno di una scala di valori che continui ad essere
dominata dalle
virtù della tradizione, spogliate tuttavia del loro eccesso
di rigore e rese
più flessibili alle esigenze di un mondo sentito
consapevolmente in
trasformazione.
- gli scontri tra le bande di Clodio e di Milone durarono
ancora a lungo e
nel 52 Clodio rimase ucciso. C. si assunse la difesa di
Milone, accusato di
avere ucciso il rivale. L'orazione composta da C. ("Pro
Milone") è
considerata uno dei suoi capolavori, per l'equilibrio delle parti
e
l'abilità delle argomentazioni, basate sulla tesi della legittima difesa
e
sulla esaltazione del tirannicidio. C. davanti ai giudici, però, fece
un
fiasco completo: gli cedettero i nervi a causa della situazione di
estrema
tensione in cui si trovava la città e così Milone dovette fuggire in
esilio.
- dopo la vittoria di Cesare, C. ne ottenne il perdono: nella
speranza di
rendere il regime meno autoritario cercò forme di collaborazione
e accettò
di perorare di fronte al dittatore le cause di alcuni pompeiani
pentiti. Le
"orazioni cesariane" ("Pro Marcello".) si collocano tra il 46 e
il 45 e sono
caratterizzate da un'abbondanza di elogi a Cesare la cui
completa sincerità
è piuttosto difficile ammettere.
- dopo la morte di
Cesare, per indurre il senato a dichiarare guerra ad
Antonio, C. pubblicò le
"Filippiche" (44), in numero forse di 18.
*Retorica. Abbiamo visto in quale
misura l'arte oratoria, in C., sia stata
legata all'azione; è chiaro, dunque,
che nessuno meglio di lui era in grado
di elaborare una teoria romana
dell'eloquenza, come mezzo di espressione e
come strumento politico. Le prime
riflessioni al riguardo risalgono alla sua
giovinezza; ma, in quell'epoca,
egli non ha ancora concepito il problema in
tutta la sua ampiezza.
-
Ancora troppo vicino ai suoi maestri greci, per i quali l'eloquenza era
una
"tecnica" fra le altre, aveva scritto un manuale scolastico, il
"De
inventione".
- Solo nel 55, quando le circostanze lo sollecitarono a
riflettere sulla
reale funzione dell'eloquenza all'interno della città,
compose il "De
oratore", un'opera in forma dialogica, "platonica" ma con
contenuti romani:
Crasso e Antonio sono i principali interlocutori. Il tema
non è l'eloquenza
in quanto tale né le regole per praticarla, ma la persona
stessa
dell'oratore, assunto come ideale civico e umano, uomo politico della
classe
dirigente, guidato dalla "probitas" e dalla "prudentia": egli dovrà
servirsi
della sua abilità non per scopi demagogici, ma per invogliare alla
volontà
dei "boni". Il vecchio problema di Catone è riproposto in termini
nuovi, ma
seguendo il medesimo spirito. Per C. l'oratore è un pensatore
universale,
che deve conoscere a fondo tutto ciò su cui si può trovare in
obbligo di
parlare (e in ciò C. si avvicina alle tesi di Platone), ma deve
superare
anche tutte le tecniche particolari, essere un artista della parola
per
persuadere con la grazia, e al tempo stesso essere un filosofo per
scoprire
ogni volta le ragioni profonde delle cose.
IL I libro tratta così
proprio della preparazione generale dell'oratore
(appunto soprattutto
filosofica, con predilezione per la filosofia morale);
il II dell'invenzione,
della disposizione, della memoria; il III della
elocuzione e dello
stile.
- La riflessione di C. sull'eloquenza trovò espressione, in seguito,
nel
"Brutus" (46), che è un quadro degli oratori romani dalle origini fino
allo
stesso C.. Vi si combattono gli "attivisti", ma forse più correttamente
si
prende una posizione intermedia tra quelli e gli "asiani", teorizzando,
per
così dire, la duttilità "situazionale" dell'oratore.
- L' "Orator"
(46), infine, è opera più tecnica, che affronta in modo tutto
particolare il
problema del ritmo e dello stile nella prosa.
*Politica. C., sin dalla sua
giovinezza, era stato attratto dalla filosofia.
Questa aveva nutrito la sua
eloquenza. Quando l'attenuarsi forzato della sua
attività politica gli
concesse qualche respiro, egli volle trasporre, nella
cornice della realtà
romana, i dibattiti del pensiero filosofico greco.
Partendo dalle cose più
urgenti, in una città in piena decomposizione
politica, scrisse
- il "De
republica" (tra il 54 e il 52), in 6 libri, un trattato sullo
Stato, il cui
proposito era ispirato dal celebre dialogo di Platone. Noi ne
conosciamo solo
una parte (buona parte dei primi 2 libri e frammenti degli
altri),
trasmessaci principalmente da un palinsesto scoperto nel 1822 da
Angelo
Mai.
L'opera è, più specificamente, costituita da 3 dialoghi, tenuti in 2
giorni,
a ognuno dei quali sono dedicati 2 libri.
Delle tre forme di
governo (monarchia, aristocrazia, democrazia) nessuna è
buona ed esaustiva
per se stessa: ideale è la Repubblica romana, in cui
queste tre forme trovano
giusto temperamento ed equa applicazione ("regime
misto") nella
"collaborazione" tra consolato, senato e comizi (tuttavia, in
verità, viene
preferita la repubblica aristocratica dell'età scipionica) [I
libro];
inoltre, la costituzione romana supera le altre perché non si deve
ad uno
solo, ma è opera di più generazioni e di molti uomini d'ingegno [II
libro].
Nel III libro si disputa del fondamento della costituzione: se,
cioè, essa
debba basarsi sulla giustizia o sull'utilità e sul diritto del
più forte.
Argomento dei libri IV e V sono invece le istituzioni morali e
politiche, la
scienza del governo e i doveri del "princeps" (ma il singolare
si riferisce
piuttosto al "tipo" dell'uomo politico eminente: C. sembra
pensare più ad
un'elite di personaggi eminenti che si ponga alla guida del
senato e dei
"boni"), visto - utopisticamente - come un "dominatore asceta".
Infine, nel
VI libro, si tratta della felicità riservata dopo la morte agli
uomini che
hanno ben meritato della patria ("Somnium Scipionis").
- "De legibus" (52-?).
Forse erano 6 libri, ma ce ne sono pervenuti 3, e per
giunta non
interi.
C. tratta del diritto razionale e naturale, e del concetto di
giustizia da
cui derivano le leggi. Esse hanno quindi in se stesse la ragione
che vincola
l'uomo al loro rispetto. Nella pratica, C. trova che le "dodici
tavole" sono
il plus non ultra (libro I). Negli altri 2 libri, è contenuta
una serie di
prescrizioni religiose e civili, scritte nel latino arcaico
della primitiva
legislazione romana.
Filosofia. Torna al sommario
-
"Accademica" (45). E' un'opera dialogica composta in due tempi. C.
compose
prima 2 dialoghi ("Catulus" e "Lucullus"), che rifuse, poi, in una II
ed.,
in 4 libri con altri personaggi, Attico e Marrone.
A noi è pervenuto
il II libro della I ed. ("Accademica priora") e il I -
incompleto - della II
ed. ("Accademica posteriora"); vi si tratta del
problema della conoscenza
secondo lo spirito della "nuova accademia": l'uomo
non può arrivare alla
conoscenza, ma deve accontentarsi della
"verosimiglianza".
- "De finibus
bonorum et malorum" (45). Dedicata a Bruto, è un'opera
dialogica in 5 libri,
in cui appunto si tratta dell'essenza del sommo bene e
del sommo male.
In
ordine a tale problema, è esposta nel I libro la teoria epicurea
(confutata
nel II): sommo bene è la voluttà con i piaceri dello spirito,
sommo male il
dolore; nel III è svolta la teoria stoica (confutata nel IV):
sommo bene è
l'onesta e la sapienza. Il V libro contiene il pensiero di C.,
ed è
un'esposizione delle dottrine accademiche e peripatetiche, secondo cui
il
sommo bene si consegue solo vivendo secondo la legge naturale, che esige
la
salvaguardia dell'animo mediante la virtù e quella del corpo mediante
la
soddisfazione degli appetiti naturali.
- "Tusculanae disputationes"
(45). Dedicato a Bruto, è un dialogo in 5
libri, uno per ogni giorno
ambientato nella villa di Tuscolo.
Si segue il metodo accademico peripatetico
di esame delle opinioni diverse,
dimostrandone la parziale falsità e
ricavandone ciò che v'è di più
verosimile. Il problema è quello della
felicità. Nei primi 4 libri si parla
di ciò che impedisce all'uomo di essere
felice: il timore della morte (ma la
morte è un bene, che l'anima sia
immortale o no, perché dà eterna
beatitudine); il dolore (il peggiore dei
mali: ma la ragione lo sconfigge
con la sopportazione ed il "buon senso"); la
tristezza ed i turbamenti dello
spirito (fondati su passioni e false
opinioni, che la ragione però rimuove).
Il V libro mostra come la virtù sola
basti alla vita felice, affrancando l'
uomo da timori, dolore e sofferenza;
chi la possiede è forte, magnanimo,
impassibile, invincibile.
- "De
officiis". Trattato dedicato al figlio Marco: i primi 2 libri
trattano
"dell'onesto e dell'utile" (Panezio), il III del loro conflitto
(Posidonio).
C. cerca, in definitiva, nella filosofia, i fondamenti di un
progetto di
vasto respiro, indirizzato alla formulazione di una morale della
vita
quotidiana che permette all'aristocrazia romana di riacquistare il
controllo
sulla società.
- I 3 dialoghi di argomento religioso e
teologico: "De natura deorum",
dedicato a Bruto, in 3 libri (nel I Velleio
espone la dottrina epicurea sull
'esistenza degli dei e la loro natura; nel
II L. Balbo espone la dottrina
stoica a riguardo: è il più interessante, in
particolare per la parte che
descrive l'ordine e le bellezze dell'universo,
concepito finalisticamente
come destinato al bene dell'uomo, secondo una
Provvidenza invisibile, ma
indubitabile; nel III A. Cotta - alterego di C. -
presenta una visione
scettico-razionalistica del problema: probabilismo
applicato alla teologia,
senza il dogmatismo ateo degli epicurei o quello
panteistico degli stoici);
"De divinatione", in 2 libri, sulla validità
dell'arte divinatoria, che C.
considera un'impostura; "De fato", dove si
esamina il problema del rapporto
tra fato e libero volere, e si espone una
tesi - peraltro non originale -
contraria al fatalismo stoico.
- "Cato
maior de senectute", dedicato ad Attico (44). Si finge che Catone il
censore,
giunto in venerabile età, esalti alla presenza di Lelio e di
Scipione
Emiliano, attraverso numerosi esempi, la saggezza e i beni
spirituali della
vecchiaia: l'operosità non interrotta, l'integrità delle
forze e dello
spirito, i godimenti spirituali non certo inferiori a quelli
dei sensi, la
contemplazione serena della morte.
- "Laelius de amicizia" (44). Dinanzi a C.
Fanno e M. Scevola, Lelio esalta
l'amicizia: il dialogo si immagina avvenuto
in occasione della morte di
Scipione Emiliano. Viene affermato il valore
morale dell'amicizia e si
sostiene che colui che intende l'amicizia in modo
utilitario concepirà in
modo utilitario anche la morale, cioè non
disinteressatamente (e questo in
polemica con gli
epicurei).
*Epistolario. Si compone, nella forma in cui ci è tramandato,
di 16 libri
"Ad familiares" (parenti e amici, dal 62 al 43 a.C.); 16 libri
"Ad Atticum"
(il migliore amico di C.:68-44 a.C.); 3 libri "Ad Quintum
fratrem" (dal 60
al 54) e 2 libri "Ad Marcum Brutum". Il tutto per un totale
di 900 lettera
circa, in cui la varietà dei contenuti, delle occasioni e dei
destinatari si
rispecchia fedelmente in quello dei toni. Si tratta - è bene
sottolinearlo -
di lettere "vere", che perciò ci mostrano un C. "privato, un
ufficiale",
nonché uno spaccato importantissimo (un documentario, quasi)
della Roma del
tempo.
Torna al sommario
*Poesia. Alcuni poemi: una
traduzione in versi dei "Fenomeni" (poema
astronomico, d'ispirazione stoica,
scritto dall'alessandrino Arato), un
poemetto epico dedicato alla vita e alle
gesta del suo nobile concittadino
C. Mario ("Marius") e un poemetto, ancora,
dedicato alla propria attività
nel periodo del consolato ("De consulatu
meo"). Sono generalmente opere di
poco valore artistico, se non per la più
mobile struttura dell'esametro.
Gaio Giulio Cesare
(Roma 100 ca. -
44 a.C.).
VITA.
Nacque da una famiglia di vetusta nobiltà; mostrò
presto simpatia per il
partito democratico, cui era legato anche da vincoli
familiari (ancora
giovanissimo sposò Cornelia, figlia di Cinna, luogotenente
di Mario), e
durante la dittatura di Silla lasciò Roma per il servizio
militare in Asia
Minore (81-78)..Quando tornò in patria, dovette sostenere le
accuse di
concussione mossegli contro. In questo episodio, mise in luce la
propria
grande arte oratoria, la freddezza e la compostezza. C. si adeguò
subito
alla vita politica di Roma.
Nel 68 cominciò il "cursus honorum" in
Spagna, come questore. Continuò poi
come edile, accattivandosi il favore del
popolo con grandi feste e
spettacoli. Due anni dopo fu eletto pontefice
massimo, la carica più alta
nel sistema religioso del periodo, molto legata
alla vita politica. In
questi anni, fu spesso coinvolto in tribunale, per via
della congiura di
Catilina, che proprio in quegli anni veniva sventata. Nel
62, ottenne la
carica di pretore; l'anno dopo, il governo della Spagna. In
questo periodo
ripudiò la seconda moglie, Pompea, perché coinvolta in
scandalo con Clodio.
Intelligentemente, trattò quest'ultimo con mitezza,
mirando all'appoggio
politico che poteva trarne dall'amicizia. Nel 60, chiese
al Senato la carica
di console, ma non gli fu accordata, per via del suo
irriducibile nemico
Catone.
C., comunque, arrivò lo stesso al potere
grazie a quella alleanza che in
seguito sarà definita come I triumvirato:
strinse cioè un accordo del tutto
privato con Pompeo Magno, e Marco Licinio
Crasso, personaggi potentissimi,
scontenti anche loro dell'atteggiamento del
Senato nei loro confronti.
C. sposava in terze nozze Calpurnia, e
contemporaneamente dava in isposa
Giulia, la proprio figlia, a
Pompeo.
L'accordo portò i suoi frutti, e nel 59 C. fu eletto console. Da
questo
momento in poi darà prova delle sue doti militari e
politiche,
distinguendosi e superando qualsiasi rivale.
Proconsole delle
Gallie nel 58, ne intraprese la conquista, terminata nel
51. Il conflitto col
senato e l'aristocrazia romana e lo scontro con Pompeo
sfociarono (49) in
guerra civile: vinti i pompeiani in Spagna e a Marsiglia,
C. raggiunse lo
stesso Pompeo in Grecia, sconfiggendolo a Farsàlo (48) e
soffocandone
definitivamente i focolai di resistenza.
Intanto, padrone assoluto di Roma,
C. ricoprì - talora contemporaneamente -
dittatura e consolato.
Il 15
marzo del 44 veniva tuttavia assassinato da un gruppo di aristocratici
di
salda fede repubblicana, preoccupati per le tendenze aristocratiche e
regali
che C. andava assumendo.
OPERE.
* "Commentarii de bello Gallico". Sono
7 libri, uno per ognuno dei 7 anni
della guerra gallica, e cioè dall'inizio
(58) alla presa di Alesia e alla
sconfitta di Vercingetòrige (52).
E'
opera scritta "di getto", probabilmente fra il 51 e il 50 (ma c'è anche
chi
pensa ad una scrittura graduale e contemporanea agli eventi), con
grande
equilibrio e straordinario senso della storia.
Con quest'opera, C.
intese evidentemente reagire alle critiche degli
avversari politici per i
grossi sacrifici di sangue e di denaro che la
guerra aveva imposto: egli
presentava così ai Romani la conquista della
Gallia come una necessità
storica volta ad evitare che i Germani, passato il
Reno, invadessero la
Gallia appunto. Completati dall' VIII libro, che copre
gli anni 52-51 ed è
solitamente trribuito al generale Irzio, furono seguiti
dai
* "Commentarii
de bello civili". Sono in 3 libri, e narrano i fatti degli
anni 49-48, dal
passaggio del Rubicone (genn. 49) al principio della guerra
alessandrina
(ott. 48).
Il tono, rispetto alla precedente opera, è più partecipe
(arrivando
addirittura a sfiorare il satirico), anche per l'intento
apologetico: C.,
difatti, vuole mostrarsi come colui che si è sempre
mantenuto nella
legalità, e che anzi l'ha sempre difesa; insiste, con ciò,
sulla propria
costante volontà di "pax"; mostra i propri esempi di
"clementia"; e così
via.
Manco a dirlo, il destinatario della sua
propaganda è lo strato "medio" e
"benpensante" dell'opinione
pubblica.
Insomma, da una parte C. e dall'altra una classe dirigente ormai
indegna di
governare: Questa contrapposizione tra il vecchio e il nuovo è il
fulcro
centrale di questa entusiasmante opera storico-narrativa, ed è anche
la sua
chiave d'accesso. E' lui, infatti, C., l'esecutore di un processo
storico
rivoluzionario, che senza alcun dubbio comporterà il superamento
dell'
oligarchia-senatoria a vantaggio del popolo romano.
Certamente,
essendo stata scritta da C. stesso, l'opera non può essere
imparziale,
tuttavia nessuno può mettere in dubbio la sua grandezza e la sua
sincerità.
Egli, infatti, è sincero quando condanna la guerra civile e ne
attribuisce la
colpa a Catone e agli ottimati, perché loro e non Pompeo
erano i veri
colpevoli. Loro avevano infangato la sua dignitas, loro con il
senatus
consultum ultimum avevano vietato ai tribuni il diritto ad esporre
il veto.
C. non voleva la guerra civile. Se così non fosse come si
spiegherebbe il suo
comportamento nei confronti degli avversari? Non c'è
stato un combattimento,
poiché il suo scopo era far arrendere l'avversario e
non distruggerlo, e ciò
avviene soprattutto nella guerra di Spagna contro
Afranio e Petreio e nei
primi anni della guerra contro l'esercito di Pompeo.
Come spiegare allora la
clemenza di C. nei confronti dei vinti? E come
possiamo spiegare la mancanza
nell'opera di frammenti e di riferimenti
riguardanti l'attraversamento del
Rubicone? Inoltre dalla lettura viene
fuori anche un grande amore di Cesare
per i suoi soldati, tanto grande non
fargli citare mai nell'opera
l'ammutinamento della nona legione a Piacenza.
Egli, poi, non parla mai di
hostes, ma di adversarii, perché gli hostes non
possono essere cittadini
romani Nella sua opera non c'è odio, né nei
confronti di Catone e degli
ottimati, né nei riguardi di Pompeo. Quest'
ultimo si rammaricava di non
essere cittadino romano ed era geloso dei
successi di C., che offuscavano il
suo nome. C. definiva Cnaeus Pompeius
Magnus, come un uomo che aveva
sbagliato i calcoli e che si era fatto troppo
entusiasmare dagli ottimati e
dal desiderio della dittatura, ma egli stesso
sapeva benissimo che era anche
il solo in grado di poterlo valutare e di
poter comprendere il suo vero
ideale politico. C. non commenta la morte di
Pompeo, la narra e nel suo
silenzio c'è angoscia. L'opera termina con l'
assassinio di Potino, ordinato
da C. per vendicare il grande Pompeo.
* Il già citato Irzio par essere autore
anche del "Bellum Alexandrinum"
(sull'omonima guerra, 48-47).
* Infine,
del "Corpus Caesarianum" fanno parte anche un "Bellum Africanum"
(in "sermo
vulgaris") e un "Bellum Hispaniense", in cui scrittori di molto
minore
levatura, forse essi stessi generali di C., narrano le guerre d'
Africa e di
Spagna (46), appunto.
* Altre opere (purtroppo perdute): l' "Antìcato", 2
libri in polemica con l'
elogio di Catone fatto da Cicerone; il "De
analògia", un'opera grammaticale
in 2 libri, che interveniva nella
controversia fra "analogisti" e
"anomalisti" sul problema della natura delle
lingue (queste, ci si chiedeva,
erano sottoposte a regole razionali - quelle
dell' "analogia" - o potevano
essere oggetto di creazioni arbitrarie, "senza
leggi" - anomale - secondo la
fantasia degli scrittori? C., da buon
atticista, propendeva per la stretta
disciplina e per la purezza della
lingua: per lui il linguaggio si
costruisce mediante una selezione
naturale-razionale-sistematica); l'
"Iter", poemetto a memoria del viaggio
fatto da Roma in Spagna; le celebri
"Epistulae"; le altrettanto note
"Orationes", in cui raggiunse - secondo i
contemporanei - un notevole grado
di maestria.
CONSIDERAZIONI.
Nei suoi "Commentarii", C. si propose di
fornire materiali agli storici per
stendere un'opera criticamente valida;
smentì, del resto, di voler fare un'
opera d'arte, limitandosi a descrivere
le vicende di cui fu protagonista e
testimone, e spiegando, senza mezzi
termini, le ragioni del suo
comportamento militare e politico. E' da dire,
comunque, che sotto questa
impassibilità, la critica recente ha tuttavia
ritenuto di scoprire
interpretazioni tendenziose e deformazioni quasi
"subliminali" degli
avvenimenti, a fine di propaganda.
Comunque, proprio
il suddetto presunto proposito di verità, nonché la
semplicità stilistica,
conferiscono a tali opere bellezza, dignità ed
eleganza, frutto anche di
lunga consuetudine di studio.
Lo stesso titolo di "Commentarii" può
significare che si tratta di un libro
di memorie o di appunti presi giorno
per giorno; il titolo quindi accentua
il significato di diario che riporta il
nudo tessuto degli avvenimenti.
Sulla traccia del greco Senofonte, poi, C.
racconta i fatti in terza
persona, al fine di attribuire il massimo di
oggettività agli avvenimenti
narrati e ai suoi comportamenti; da questo
scrupolo dell'oggettività è
derivato il rifiuto di inserire lunghi discorsi
in forma diretta, così cari
agli storici antichi.
Accanto al valore
storico non si può dimenticare, infine, il grande valore
artistico dei
Commentarii cesariani, che in tutti i tempi hanno costituito
un testo base
per lo studio della lingua latina. "Nudi sono - dice
Cicerone - schietti e
semplici questi Commentarii, che, pur essendo privi di
ogni ornamento, sono
pieni di grazia". Non minori sono gli elogi tributati
all'opera dagli
studiosi moderni. Il Marchesi afferma che nessuno degli
antichi seppe
scrivere un opera "dove siano adoperate meno parole per dire
tutto, dove
tutte le cose più complicate siano espresse con così sobria e
precisa
chiarezza da sembrare disegnate". La narrazione è condotta in
modo
personalissimo e sempre fresco e non viene mai appesantita
dall'
autocelebrazione.
Sul piano strutturale dell'intera opera, ogni
elemento linguistico punta
direttamente a mettere in mostra la figura dello
scrittore, che è insieme
demiurgo-ordinatore di ogni azione; autore-narratore
di ogni piano e di ogni
progetto; attore-protagonista di ogni scena ideata e
realizzata. Una
preziosa spia, in tal senso, è il fatto che il racconto è
sapientemente
riportato in terza persona e in essa il nome di Caesar oppure,
in sua vece,
is o ipse appare quasi in ogni capitolo. Prevale nella
narrazione spesso
anche la prima persona plurale (nostri, nostrum,
nostrorum): e ciò sia per
mettere sempre in prima linea la persona
dell'autore sia per coinvolgere,
per quanto su un piano inferiore a quello
del comandante, gli attori
secondari del racconto, che sono, poi, sempre "i
soldati di Cesare". Ad essi
si contrappongono, nella veste di soggetti
passivi, oggetto del racconto, i
nemici, che, nel De bello gallico sono i
barbari con i loro vari nomi, nel
De bello civili, invece, sono gli
oppositori politici dello scrittore,
anch'essi puntualmente
individuati.
Naturalmente, alcuni di questi nemici hanno una grande
personalità (ad
esempio, Vercingetorige nel De bello gallico e Pompeo nel De
bello civili),
tuttavia nessuno di essi sopravanza la statura del narratore,
che tutti è
riuscito a superare. In questo contesto ha molta importanza,
quindi, mettere
in evidenza i termini del linguaggio che esprimono le azioni
continue e
turbinose della guerra, quali siano soprattutto i verbi:
attraverso i loro
significati è facile cogliere l'intima ansia dello
scrittore, che pone su un
versante i predestinati, i privilegiati, i
vincitori, ossia quelli della sua
parte; sul versante opposto, invece, egli
colloca i nemici, tutti destinati
alla sconfitta. Gli scenari delle battaglie
vengono concepiti sempre come
degli immensi palcoscenici, in cui le azioni
del regista-attore vengono
scandite appunto dall'uso dei tempi del verbo, in
cui prevale il presente
storico, che consente allo scrittore, da un parte, di
vivacizzare il
racconto, suscitando l'attenzione del lettore, dall'altra,
di
"rappresentare" gli eventi narrati. Non mancano il perfetto e
1'imperfetto,
ma ciò avviene con minore frequenza e il loro uso è subordinato
alla volontà
del narratore di frapporre una netta separazione tra se stesso e
la
narrazione.
Sul piano stilistico a C. vengono concordemente
riconosciute dalla critica
le seguenti qualità: la chiarezza (=perspicàitas),
ossia un procedimento
lineare e terso, alieno da ogni pensiero contorto e
involuto; la brevità (=
brevitas), che mira all'essenzialità e alla rapidità;
l'assenza di ornamenti
superflui, come bene intuì Cicerone, quando definì
nudi i Commentarii
cesariani; l'eleganza del dettato (= urbanitas), al punto
che pochi sono gli
scrittori dell'intera latinità che possano gareggiare con
1ui in purezza e
proprietà di linguaggio; sotto questo punto di vista, egli
incarnò quel puri
sermonis amator, che, in uno scritto minore, aveva vista
realizzato nel
poeta comico Terenzio; infine, l'armonia e simmetria dei
costrutti, che gli
antichi (con Cicerone che ne fu il massimo maestro)
chiamavano concinnitas.
Sul piano lessicale, inoltre, C. lascia da parte la
tendenza all'arcaismo e
compie determinate scelte sui vocaboli, senza
preoccuparsi se poi ciò
causerà molte ripetizioni. Infine, sul piano
sintattico, egli predilige la
paratassi all'ipotassi, soprattutto per motivi
di chiarezza, e riesce a
costruire sempre dei periodari lineari e
lucidi.
Cornelio Nepote
(Gallia Cisalpina 99 ca - ? 24 ca
a.C.)
*N. è autore della più antica raccolta di biografie latine
giuntaci: il "De
viris illustribus" (34 a.C.), almeno 16 libri di vite di
generali, storici,
poeti e oratori latini e stranieri (raggruppati secondo le
"categorie
professionali"), con una trattazione parallela derivata forse
dalle
"Imagines" di Marrone e ripresa, in seguito, nelle "Vite" di
Plutarco.
Dell'opera ci restano numerosi frammenti: 2 vite (Catone il Vecchio
e
Attico) del "De historicis latinis" e l'intera sezione "De
excellentibus
ducibus exterarium gentium" (22 biografie).
E' chiaro
l'intento dell'autore di fare del genere letterario della
biografia il
veicolo di un confronto sistematico fra civiltà greca e romana,
evidentemente
senza adombramenti nazionalistici (si tratta di un caso di
"relativismo
culturale"?)
*Altre opere (perdute): "Cronica", storia universale in 3 libri,
forse in
prosa, in cui già affiorava l'esigenza di un confronto tra la
civiltà romana
con le altre; "Exempla", aneddoti e curiosità storiche e
geografiche in 5
libri; "Vite" più ampie di Catone e di Cicerone.
*N. è un
improvvisatore, e cita le sue fonti spesso senza averne conoscenza
diretta e
senza controllarne il valore: le sue biografie appaiono piuttosto
panegirici
moraleggianti che ricerche critiche, e ci danno informazioni
preziose solo
nelle descrizioni d'ambiente.
G. Sallustio Crispo
(Amiterno,
Sabina, 85 - Roma 35 o 36 a.C.)
VITA.
S. nacque da famiglia pebea.
Compì i suoi studi a Roma, venendo a contatto
con lo studio neopitagorico di
Nigidio Figulo. Partecipò anche alla vita
mondana della capitale.
Politicamente si affiancò a Cesare. Per questo suo
impegno ottenne la carica
di questor nel 54. Questo fu un anno molto
turbolento per la politica romana:
vi fu l'uccisione di Clodio, un demagogo
del popolo, ad opera di Milone. S.
si schierò decisamente contro
quest'ultimo e anche contro Cicerone, suo
difensore. Nel 50 fu espulso dal
senato per immoralità (aveva infatti una
relazione con Fausta, figlia di
Silla e moglie in seconde nozze con Milone).
Durante le guerre di quel
periodo fu fedele a Cesare, aiutandolo anche alle
operazioni militari in
cui, però, non risultò sempre vincitore.
Nel 48
riottenne la questura, la dignità senatoria. Alla fine del 47 seguì
seguì
Cesare in Africa, e portò a compimento una operazione militare,
conquistando
l'isola di Cercina. A seguito di questo successo, Cesare gli
affidò il
compito di governatore della cosiddetta Africa Nuova, costituita
dal vecchio
regno numidico di Iuba. Nei mesi di governo potè accumulare
notevoli
ricchezze che gli permisero, dopo la morte di Cesare ed il suo
ritiro dalla
vita pubblica, nei celebri "Horti Sallustiani", di vivere in
ricchezza
componendo le sue opere.
OPERE.
Di S. abbiamo:
*due
monografie:
- "De coniuratione Catilinae" (42?): con essa, lo storico
interrompe la
tradizione annalistica e si occupa di un episodio di storia
contemporanea -
appunto la congiura e il moto del 63-62 - facendovi precedere
un'analisi
della condotta cesariana del 66-63, vista come unica valida
alternativa al
corrotto "regime dei partiti", con riflesso sulle sue scelte
politiche.
Tutta la prima parte dell'opera è, praticamente, un'analisi e
un'esegesi
dell'inquietante fenomeno rivoluzionario, alla luce di categorie
storiche,
morali e psicologiche. Ne risulta perciò un quadro fosco, ma
estremamente
vivace, di una società profondamente corrotta, su cui campeggia
come figura
dominante Catilina, intelligente, coraggioso e malvagio. Accanto
a lui,
altri personaggi "studiati" con eguale interesse: i congiurati,
Sempronia,
Cicerone (per quanto ridimensionato) e soprattutto Cesare e Catone
(visti
come entrambi positivi - direi "complementari" - per Roma: uno con la
sua
liberalità, munificenza e misericordia; l'altro con la sua
integritas,
severitas, innocentia.)
Come si vede, il metodo adottato
nell'analisi è moralistico: S. ritiene che
l'antica grandezza della
repubblica fosse garantita dall'integrità e dalla
virtù dei cittadini, e vede
nel successo, nella ricchezza e nel lusso le
cause della decadenza e la
possibilità di tentativi come quello di Catilina.
- "Bellum Iugurthinum" (40
ca): narra, in 114 capitoli, la guerra combattuta
dai romani (111-105 a. C.)
contro appunto Giugurta, re di Numidia.
Ma anche qui il taglio è politico: se
infatti, da una parte, S. si dimostra
capace di forti sintesi storiche,
dall'altra rivela vigore polemico nel
denunciare l'incompetenza della
nobilitas nella conduzione della guerra, e
la sua corruzione generale; nel
valorizzare le ragioni espansionistiche
della classe mercantile;
nell'auspicare la nascita di una nuova
aristocrazia, fondata sulla "virus" (a
tal proposito, si ricordi il
riportato discorso di Mario).
*le "Historie"
di cui abbiamo un numero abbastanza cospicuo di frammenti di
5 libri e alcuni
discorsi. Esse riprendono e sviluppano le Historiae di
Sisenna, andando dalla
morte di Silla (78) alla guerra di Pompeo contro i
pirati (67). Dai
frammenti, si evince che S. era ritornato all'annalistica e
che il suo
pessimismo si era, se possibile, acuito.
*Oggi non conosciamo più la sua
traduzione dei poemi di Empedocle (ammesso
che l' "Empedoclea" di cui parla
Cicerone in una lettera, sia davvero opera
sua). A lui si attribuiscono anche
2 epistole politiche a Cesare su un nuovo
ordinamento dello stato; quasi
sicuramente spuria è invece un'invettiva
contro Cicerone, di scuola
retorica.
CONSIDERAZIONI.
*S., dunque, scelse i temi delle sue due
"monografie" con intenti ben
precisi: mostrare in che modo un regime
aristocratico, quale quello
instaurato dopo la sconfitta dei Gracchi, fosse
andato progressivamente in
rovina. La prima delle cause era da ricercare
negli scandali che avevano
accompagnato la guerra contro il re numida
Giugurta, e che avevano messo in
luce i compromessi e la corruzione di quegli
stessi uomini che, nel senato,
erano i responsabili della politica romana: la
stessa personalità
universalmente rispettata di Metello, cui si era finito
per dare il carico
della guerra, non bastò a impedire l'ascesa di C. Mario,
al quale il popolo
affidò l'incarico di porre termine a una guerra quasi
conclusa da Metello,
raccogliendone i frutti della gloria. Questo episodio
aveva segnato, in
effetti, l'inizio delle guerre civili, che dovevano
provocare le smisurate
ambizioni dello stesso Mario. La "Congiura di
Catilina", mettendo in luce i
crimini di cui erano stati complici un pugno di
aristocratici, esaminava, a
sua volta, le cause morali di tale decadenza:
gusto del piacere, corruzione
dei costumi, sfrenata avidità di
denaro.
Dunque, S. considerò la storiografia - ritenuta comunque inferiore
alla
politica - non solo come cronaca di fatti, ma anche come "archeologia",
cioè
come ricerca delle loro cause: essa quindi tende a configurarsi
come
indagine sulla crisi, e l'impostazione monografica (una novità
quasi
assoluta) ben si prestava alla messa a fuoco di un periodo o
problema
storico (analizzato da S. a partire comunque e sempre da un
moralismo di
fondo).
Il quadro che lo storico dipinge è già quasi degno di
Tacito. S. scrive
queste pagine dopo la rivoluzione guidata da Cesare (senza
dubbio dopo la
morte dello stesso Cesare), e dopo che il mondo da lui evocato
si è già
definitivamente dissolto sul campo di battaglia di Farsàlo.
S.
non è un "democratico" che rivendica al popolo una parte di potere. Come
i
suoi predecessori, da Catone a Cicerone, è l'avvocato dei valori
morali
essenziali, un adepto di quel "conservatorismo intelligente" che è il
solo a
poter salvare Roma. E' il programma che Augusto riprenderà alcuni anni
dopo.
*Un'altra caratteristica dell'opera di S. è la consapevole originalità
del
suo stile, nel quale si giustappongono ricercati arcaismi e
ardite
innovazioni ("arcaismo innovatore"), termini presi dal linguaggio
familiare
ed ellenismi. Egli vuole, innanzitutto, dare un'impressione di
vita, in
virtù di un periodo serrato e vibrante, di scorci rapidi e di
giri
sintattici "atemporali" (è la famosa "inconcinnitas" sallustiana),
come
l'impiego ripetuto di ellissi, dell'infinito narrativo o lo
sviluppo
sistematico di proposizioni participiali che costituiva, tra
l'altro, uno
dei tratti caratteristici e di maggior rilievo dello stile
narrativo dei
greci. Questa lingua composita suscita oggi l'impressione di
una certa
artificiosità.
Rimane lontana da quella "naturalezza"
ciceroniana che ci è familiare, da
quello sviluppo logico del pensiero in
periodi analitici, dove l'idea è
situata al centro del suo contesto di cause
e di circostanze, e dove il
ritmo accompagna e prelude ogni volta il
precipitare della frase. Non
dobbiamo credere, tuttavia, che il periodo
ciceroniano fosse più vicino alla
lingua parlata e la frase di S., invece, la
libera creazione di un artista.
La lingua quotidiana si collocava, in realtà,
alla medesima distanza sia
dall'uno che dall'altra. Per sua natura, non era
né periodizzata né ritmata.
Ma neppure disponeva delle molteplici risorse che
S. mette insieme.
Continua>
|
|
|
|
|
|
 | |