 |
|
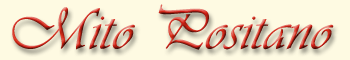 |
|
LETTERATURA
LATINA
|
|
|
|
LETTERATURA LATINA -
TERZA PAGINA |
Pagina precedente
Publio Virgilio Marone
(Andes, 15 ott. 70 - Brindisi, 22 sett. 19
a.C.)
VITA.
*Le scuole. V. nacque in un piccolo villaggio nei pressi
di Mantova, da una
oscura famiglia di coltivatori, appartenente alla piccola
borghesia locale,
romanizzata piuttosto di recente. La sua figura è
profondamente
contrassegnata dall'infanzia trascorsa in quel paesaggio fresco
e pacifico
situato sulle rive dei Mincio, dove l'allevamento del bestiame e
la
coltivazione dei campi erano le risorse dominanti, e dove la sua
famiglia
possedeva una tenuta.
La sua formazione ebbe inizio a Cremona,
dove frequentò la scuola di
grammatica, e dove, a quindici anni, prese la
toga virile.
Da Cremona si trasferì a Milano e poi nuovamente a Roma, alla
scuola del
retore Epidio, esponente dell'indirizzo asiano, così chiamato
perchè di moda
in Grecia, uno stile oratorio ricco e brillante, in netto
contrasto con lo
stile semplice degli oratori classici. Epidio, inoltre,
annoverava tra i
suoi discepoli i giovani che sarebbero diventati gli
elementi di spicco
della futura classe dirigente di Roma, fra cui Marco
Antonio e Ottaviano.
V., tuttavia, schivo per natura, non aveva talento
oratorio, nè intendeva
perseguire la carriera forense. Abbandonò così la
retorica per dedicarsi
agli studi filosofici, e in particolare
all'Epicureismo, che approfondì a
Napoli alla scuola di Sirone. Qui divenne
intimo amico di Vario Rufo e
Plozio Tucca, che saranno poi i curatori della
prima edizione dell'Eneide.
Il periodo della sua formazione è dominato, sul
piano letterario, dalle
personalità di Catullo e di Elvio Cinna (del quale
scriverà un elogio
discreto nella IX Egloga), e dall'astro nascente di C.
Gallo, della sua
stessa età. Sedotto e affascinato da questo ambiente, V.,
quasi certamente,
scrive in questo periodo almeno alcune delle composizioni
che entreranno a
far parte della raccolta oggi conosciuta col nome di
"Appendix Vergiliana"
(letteralmente: "Aggiunta a V."), nella quale poemi
autentici convivono con
pastiches di origine incerta.
*La perdita delle
terre. Dopo la morte di Cesare, fra il 44 ed i primi mesi
del 43, V. fece
ritorno ad Andes, dove ritrovò l'amico della sua giovinezza,
Asinio Pollione,
che ricopriva l'incarico di distribuire le terre ai
veterani.
Grazie a
lui, uomo sensibile alle arti ed alla cultura, il poeta potè in un
primo
tempo sottrarre le sue terre all'esproprio: tuttavia, un anno più
tardi,
mentre era impegnato nella composizione delle "Bucoliche", i suoi
campi di
Mantova furono assegnati ai soldati di Ottaviano, per i quali si
era rivelato
insufficiente il territorio di Cremona. V. non dimenticò mai il
dolore
causato dalla perdita della sua terra, per la quale sentì sempre una
viva
nostalgia.
*Il trasferimento a Roma. Perdute le sue terre nel mantovano, V.
si trasferì
a Roma, dove pubblicò le "Bucoliche", composte dal 42 al 39
a.C..
L'anno successivo entrò a far parte del circolo letterario di
Mecenate.
Catullo e Lucrezio erano morti da poco e soltanto la poesia
alessandrina,
coltivata da Cornelio Gallo, conservava ancora un certo
splendore, mentre
Orazio, che V. stesso presentò a Mecenate, iniziava allora
a scrivere le
satire. Mecenate ed Ottaviano, il suo referente politico,
offrirono a V. una
casa a Roma, nel quartiere dell'Esquilino, ma il poeta
spesso preferiva
ritirarsi a sud verso il mare ed il sole, mentre si dedicava
alla
composizione delle "Georgiche", compiuta in sette anni, durante un
soggiorno
a Napoli, fra il 37 ed il 30.
Le "Georgiche" diedero a V. la
fama e suscitarono l'ammirazione di Mecenate,
che gli era stato
particolarmente vicino nelle varie fasi della
composizione.
Si presume, in
realtà, che V. fosse istintivamente un "cesariano". D'altro
canto,
l'epicureismo invitava i suoi adepti a non occuparsi di politica, ma
ad
accettare, a cuor contento, un padrone che assicurasse la pace.
*L' "Eneide".
Nell'estate del 29 Ottaviano, tornato dall'Asia dopo la
vittoria conseguita
ad Azio su Antonio e Cleopatra, si era fermato ad Atella
per riprendersi da
un mal di gola. Là V. gli lesse per quattro giorni di
seguito i libri
compiuti delle "Georgiche", aiutato da Mecenate, che lo
sostituiva nella
lettura quando era stanco.
Dopo questo episodio, certo non senza un
suggerimento da parte dello stesso
Augusto, V. fu scelto quale cantore del
nuovo impero e del nuovo principe.
Da questo momento fino alla fine della
vita V. attese all' "Eneide", un
poema epico sulle origini di Roma. V. aveva
nella tradizione letteraria
latina predecessori illustri nell'ambito di
questo genere letterario, ma l'
"Eneide" si richiamava più da vicino al
modello omerico. Il poema era stato
inizialmente concepito come una
narrazione allegorica delle imprese di
Ottaviano, ma il poeta cambiò idea ed
il poema storico venne sostituito dal
poema epico sulle vicende di Enea,
progenitore dei Romani.
Ancora tre anni dopo l'inizio della stesura
dell'"Eneide", V. scriveva ad
Augusto che il poema era solo "incominciato" e
ci vollero ancora tre anni
perchè la prima redazione dell' "Eneide" fosse
terminata. Nel 22 V. lesse
all'imperatore alcuni canti del poema, ma non si
trattava ancora della
stesura definitiva.
*Il viaggio in Asia. Nel 19 a.C.
V. partì per un lungo viaggio attraverso la
Grecia e l'Asia allo scopo di
arricchire la propria cultura e, nello stesso
tempo, verificare la topografia
dei luoghi descritti nel poema. Ad Atene il
poeta incontrò Augusto, di
ritorno dalle province orientali. Questi, notate
le sue precarie condizioni
di salute, lo persuase a tornare in Italia. V.,
che aveva appena visitato
Megara sotto un sole cocente, era estenuato ed il
suo stato si aggravò
durante la traversata verso le coste italiane. Sbarcato
a Brindisi, il poeta
era in fin di vita, ma prima di morire chiese il
manoscritto dell' "Eneide",
ancora incompiuta, per bruciarlo. Gli amici non
gli ubbidirono.
Il corpo
di V. fu trasferito a Napoli e sepolto sulla via di Pozzuoli. Suoi
eredi
furono Augusto e Mecenate, che diede incarico a Vario e Tucca di
pubblicare
l'Eneide.
OPERE.
Le "Bucoliche".
*Le "Bucoliche" sono un'opera
d'ispirazione alessandrina, composta da X
egloghe (cioè "poesie scelte"), in
esametri, di cui alcune sono
lirico-narrative, altre in forma dialogica,
distribuite non nella
successione cronologica della loro stesura, ma con un
ordine d'intento
letterario (numerosi i rimandi, i parallelismi, le
simmetrie). Questo il
contenuto:
*Ecloga I: d'intonazione forse
autobiografica. Il dialogo tra i due pastori
Titiro (V.?) e Melibeo avviene
nella cornice della campagna mantovana.
Melibeo è triste perché ha perduto i
suoi beni; Titiro è invece sereno,
perché un giovane a Roma (Ottaviano?) gli
ha concesso la libertà personale e
il possesso della sua terra.
Ecloga II:
è il lamentevole soliloquio di Coridone innamorato di Alessi.
Ecloga III: Da
meta e Menalca si sfidano in una gara d'abilità nel canto.
Ecloga IV: è del
tutto singolare e non ha nulla di bucolico. Scritta nel 40,
quasi profetizza
la palingenesi del mondo e il ritorno all' "età dell'oro",
che inizierà con
la nascita di un bambino, sotto il consolato di A. Pollione
(e ricordiamo la
strumentalizzazione ideologica che di questi passi ha fatto
il Cristianesimo,
ritenendo addirittura d'individuare in V. il profeta dell'
avvento
messianico).
Ecloga V: due pastori, il cantore Menalca e il suonatore di
zampogna Mopso,
uno dopo l'altro, cantano in onore di Dafni, ucciso
crudelmente. Mopso ne
canta la morte, l'altro l'apoteosi.
Ecloga VI: è
trattata l'origine del mondo secondo la dottrina di Epicureo.
Il cantore è il
vecchio Sileno che due giovani hanno sorpreso ubriaco e
hanno
legato.
Ecloga VII: Melibeo, trattenuto da Dafni, assiste ad una gara poetica
tra
Coridone e Tirsi.
Ecloga VIII: presenta il canto mattutino di due
pastori, ed è imitata quasi
interamente da un modello di Teocrito. E'
dedicata a Pollione, che ritorna
vittorioso dalla Dalmazia.
Ecloga IX:
d'intonazione forse autobiografica. Menalca (V.?) è stato
cacciato dai suoi
beni e anulla sono valsi, né varranno, i suoi canti.
Ecloga X: è dedicata a
C. Gallo, confortato perché l'infedele Licoride l'ha
lasciato.
*V.
riprende il genere reso illustre da Teocrito (III a.C.), che a Roma non
aveva
ancora trovato dei continuatori, ma lo rifonde in una trama di
rapporti
talmente complessa che la nuova opera sta alla pari col modello. I
temi
riconducono ad un ambiente pastorale, che manca tuttavia di ogni
connotazione
realistica, e appare come un'elaborata e stilizzata
costruzione: a cantare
sono gli stessi personaggi, pastori, mandriani,
butteri. Ma sullo sfondo si
intuisce tutto un complesso di allegorie e di
significati riposti, che
ripetute volte si è tentato di penetrare,
probabilmente invano. Non è forse
Cesare il Daphnis di cui la V Egloga canta
la divinizzazione? E' verosimile,
ma in nessun modo dimostrabile. E il
Sileno della VI, che fa pensare a
Lucrezio, ma anche ad altri poeti
contemporanei, e persino a Sirone, l'amato
maestro, chi nasconde sotto il
suo travestimento? Un personaggio definito
oppure un aspetto, un volto della
poesia?
Ma forse, gli avvenimenti e i
personaggi non devono essere considerati, fino
in fondo, allegorie di fatti
storici e/o autobiografici e di persone reali,
bensì piuttosto simboli della
condizione umana in essi rappresentata: la
tensione poetica deriva, infatti,
dallo scontro fra l'arcadica perfezione di
quel mondo e la realtà effettiva,
che in vari modi - e spesso
gratuitamente - tenta d'insidiarlo, dandosi essa
sotto il dolore e gli
sconvolgimenti provocati dall'esilio, dalla morte,
dalla passione.
*La raccolta fu pubblicata quasi certamente negli ultimi mesi
dell'anno 39,
momento in cui tutto sembrava sorridere ai triumviri, dopo la
firma della
pace con Sesto Pompeo che aveva fino ad allora affamato Roma con
le sue
flotte. Le "Bucoliche" respirano perciò, in genere, un'atmosfera
serena, e
rendono omaggio a quel "giovane dio", simile all'Apollo onorato dai
pastori,
nel quale è facile riconoscere Ottaviano.
Le
"Georgiche".
*Il poema delle "Georgiche", composto tra il 37 e il 30 a.C., in
2183
esametri, si riallaccia alla poesia della natura che è nelle
"Bucoliche", ed
è inoltre preludio al canto delle virtù umane, che sarà nell'
"Eneide".
Si dice che V. lo scrivesse su invito di Mecenate, che si faceva
interprete
del programma di risanamento morale di pace e di lavoro formulato
da
Augusto, cui realmente stava a cuore la ripresa dell'agricoltura. Ma ciò
che
più conta è che l'opera risponde alle vere aspirazioni del
poeta.
*Scegliendo questa tematica, affrontata in altri tempi da Esiodo nel
poema
"Opere e giorni", V. rimaneva nell'ambito dello spirito alessandrino,
che
considerava Esiodo uno dei poeti più alti, forse superiore allo
stesso
Omero. Per di più, V. vedeva nel suo progetto (com'egli
stesso
orgogliosamente affermerà) la possibilità di annettere una nuova
regione
poetica alle lettere latine. Le sue convinzioni epicuree, infine
(forse già
un po' scosse, ma delle quali sarebbe impossibile dubitare), lo
portano a
emulare Lucrezio in un'epopea consacrata allo spettacolo del mondo
e alle
attività umane.
Il mondo dell'Arcadia, che era fittizio, e che
escludeva, a dispetto delle
apparenze, l'urgenza del mondo della realtà,
lascia il posto ad un mondo
soltanto o prevalentemente reale: mondo di cose
comuni, di uomini vivi di
lavoro aspro, di attività creativa che le
immaginate favole del mito e le
invenzioni letterarie anche qui inserite a
trapuntare il tessuto narrativo e
didascalico non solo non annullano, ma anzi
rilevano.
*Nelle "Georgiche" si registra però il miracolo del superamento dei
modelli
grazie al dolore che connota l'intero poema. Qui il dolore non si
mostra
come generato dall'ingiustizia sofferta quale destino ineluttabile,
superato
o stemperato in dolce malinconia per mezzo dell'evasione in Arcadia;
ma è
dolore esistenziale intuito e scoperto nel quotidiano vivere dell'uomo
nel
suo contrasto con le avversità atmosferiche, che rovinano i seminati.
Tale
condizione esistenziale non consente evasioni; anzi resta come il
segno
vistoso della risoluzione in senso drammatico del sogno idillico
delle
Bucoliche.
V. "vede l'uomo nella sua funzione di trasformatore"
(Ferrero). L'uomo è
capace di vincere le avversità, di correggere gli errori
di trovare rimedio
ai mali grazie al suo impegno costante nel lavoro: il
lavoro procura lo
sviluppo civile, sorregge i legami della società, le
istituzioni, i costumi.
I Romani, abituati a concepire la fatica dei campi
nei termini del loro
caratteristico utilitarismo, con il poema virgiliano
scoprono gli aspetti
autenticamente morali dell'agricoltura. Per tutte queste
ed altre ragioni l'
intento didascalico dell'opera, che voleva rispondere
all'invito di
Mecenate, il committente affabile ma esigente, non risulta
affatto
fondamentale, tant'è che non è difficile scoprire che i consigli e
gli
ammaestramenti dati dal poeta ai contadini non sono tutti o in
tutto
realizzabili né tutti opportuni o logici in senso strettamente
pratico.
*Il destinatario delle "Georgiche" dal punto di vista del contenuto
tecnico
è il contadino; ma badando al livello artistico e alla perfezione
formale,
che è frutto di eccezionale cultura e porta i segni di una
faticosa
elaborazione, per la quale lo stile medio del poema didascalico si
eleva al
piano dello stile sublime dell'epica, il pubblico di lettori ideali
a cui il
poema si rivolge è il pubblico urbano al quale si adatta il
contenuto etico
generale, ispirato al programma augusteo volto al recupero
dei sani costumi
e alla stabilità delle condizioni di pace.
Ma invero, nel
suo poema V. cerca di dimostrare una verità che non rientra
nell'ordine della
politica. Mette a confronto l'uomo e la natura, e dimostra
che quest'ultima
è, per eccellenza, l'ambiente fisico e morale suscettibile
di condurre l'uomo
a una felicità abbastanza prossima a quella predicata
dagli epicurei.
Tuttavia, a poco a poco, V. è trascinato a rompere gli
schemi un po' angusti
dell'epicureismo, quasi che lo spettacolo e la
meditazione dei grandi momenti
della "Natura" gli rivelassero, in essa, la
presenza degli dèi. Lo fa
dapprima attraverso un mito, che mostra come Giove
abbia in realtà
"dissimulato" negli oggetti ciò che l'uomo deve cercarvi: il
fuoco nelle vene
silicee o nel legno dei rami, il ferro nelle viscere delle
montagne,
imponendo così la legge, moralmente salutare, del lavoro. Se in
Venere,
simbolo della "voluttà", Lucrezio aveva visto, in modo analogo, il
motore del
mondo, in V. il mito s'ingrandisce fino a dominare. La divinità
si trasforma
nell'aspetto "oggettivato" della sensibilità del poeta stesso,
che si
compiace nell'evocare le realtà religiose dell'esistenza rurale.
Il
calendario del rituale romano riprende il suo primitivo valore a
contatto
con la realtà fondamentale della terra.
*V., superate le
strutture stilistiche delle "Bucoliche", ha modellato le
nuove forme,
apprestandosi a foggiare quelle, più complesse e più varie, se
non ugualmente
sempre perfette, dell' "Eneide". Ma forse soltanto nella
tristezza che ispira
le conclusioni di tutti e 4 i libri può rintracciarsi
la prova del preciso
disegno architettonico dell'opera.
Certo è che ognuno dei libri ha una sua
tematica distinta, una sua autonomia
che si rivela anche per mezzo del
particolare proemio che lo introduce:
Libro I: Dopo il proemio generale, la
dedica a Mecenate e l'invocazione alle
divinità protettrici, prende in esame
la natura, la semina e le sue cure
specifiche, l'osservazione degli astri, i
pronostici. Si conclude con una
ulteriore invocazione agli dei perché diano
soccorso al mondo, sconvolto
dalla guerre.
Libro II: Tratta della cultura
delle piante, in particolare della vite e
dell'olivo, che nell'economia
italiana di quel tempo, dove vino e olio
costituivano i prodotti principali
delle grandi tenute e la prima fonte
d'esportazione verso le province
occidentali, occupavano evidentemente un
posto fondamentale. Qui si inserisce
la famosa apostrofe elogiativa all'
Italia. C'è, in questo elogio, non tanto
la solennità di un encomio
patriottico e di una testimonianza di fede nel
destino d'Italia, quanto l'
emozione di chi si incanta al miracolo di una
realtà di pace che fino a ieri
era solo un'aspirazione.
Libro III:
Dedicato all'allevamento del grosso e del piccolo bestiame e ai
sistemi di
sfruttamento dei terreni, italiani e no (Africa, Spagna,
Illiria), che non si
prestavano alla coltivazione della vite o dell'olivo;
contiene un'altra
invocazione, a Pale e ad Apollo, le divinità della
pastorizia.
Libro IV:
Riguardante le api, tratta dell'ubicazione e della costruzione
dell'alveare,
delle abitudini delle api e delle riproduzioni degli sciami
(il miele aveva
unposto di rilievo in un'alimentazione interamente priva di
altre fonti
zuccherine). Parlando della necessità di disporre di un giardino
con piante e
fiori profumati, V. introduce la breve storia del vecchio di
Corico, che
riuscì grazie alla sua tenacia a sentirsi ricco e beato come
un
re.
Ciascun canto presenta una "digressione": nel I il racconto dei
prodigi che
accompagnarono la morte di Cesare; nel II l'elogio dell'Italia;
nel III la
peste (epizootica) che infierì nel Norico (le Alpi tirolesi); nel
IV,
infine, a coronamento di tutto, la leggenda di Aristeo, il
primo
"apicultore", nella quale si inserisce il mito di Orfeo e di
Euridice.
*Architettura perfetta, dunque, ma della quale rimangono misteriosi
i motivi
profondi: forse per V. si trattava solo di colmare, in questo finale
del IV
libro, il vuoto lasciato dalla soppressione dell'elogio di Gallo
(che
appunto inizialmente ne era la conclusione), il quale - divenuto
prefetto
dell'Egitto - aveva offeso Augusto e si era suicidato.
L'
"Eneide".
*l' "Eneide" si inserisce pienamente nel genere epico di ascendenza
greca,
riuscendo a farsi nel contempo interprete dei valori della romanità e
dello
spirito di restaurazione morale augusteo, tanto da divenire il
poema
nazionale di Roma. Essa mantiene quella compresenza di mitologia e
storia
che caratterizzava l'epica latina arcaica, differenziandosi però per
l'
argomento: il mito assume un posto centrale e diventa nucleo primario
della
vicenda tanto che il protagonista non è Augusto, ma Enea. In virtù di
questa
impostazione V. evita un coinvolgimento troppo diretto con gli
eventi
contemporanei e può, in questo modo, ampliare la prospettiva e
il
significato della propria poesia. Oltre ad Omero, sicuramente
modello
principale - altri elementi ci riportano ai poeti del ciclo epico,
agli
alessandrini, e in particolare ad Apollonio Rodio, ai tragici greci
e
romani, agli orfici, a Nevio e a Ennio. Né bisogna dimenticare che il
mito
di Enea aveva assunto per i Latini un valore nazionale e che per lo più
ne
veniva ammessa financo la storicità.
*Eppure, l' "Eneide" risulta
un'opera originale, nella sua straordinaria
densità e complessità, grazie
all'enorme quantità di materiali culturali:
storici, letterari, antiquari e
filosofici. Il modello principale - come
detto - è Omero, di cui V. ha
ripreso entrambi i poemi, capovolgendone la
successione originale e
riducendoli in uno solo. La prima metà, chiamata
parte "odissiaca", ha quindi
come tema principale il viaggio, la seconda,
detta "iliadica", invece ha la
guerra (spartiacque è il libro VI, quello
della discesa di Enea negli
Inferi). La presenza di Omero è massiccia oltre
che nell'intreccio, nella
ripresa di molti episodi. V. segue Omero anche in
ciò che riguarda l'apparato
mitologico, con alcune differenze fondamentali
come il rinnovamento dei
materiali poetici di cui si serve, che organizza e
orienta in modo diverso in
funzione del significato complessivo dell'opera.
Il punto d'arrivo a cui
tende la storia universale è Ottaviano Augusto che
viene unificato così alla
celebrazione di Roma su di un piano ideologico.
*All'interno di questa
struttura, l'azione si sviluppa abbastanza lineare,
procedendo senza
divagazioni verso la grande scena finale: infatti, l'
interesse del poeta è
tutto concentrato sul destino del protagonista, che
attraverso molteplici
avventure si avvicina sempre più alla meta fissata dal
Fato: il nascere e la
futura gloria di Roma. I vari episodi del poema non ne
sono quindi altro che
le necessarie tappe, secondo una curvatura decisamente
teleologica.
E'
tale meta, dunque, che illumina, dà senso e giustifica le fatiche,
le
angosce, la morte che incombono e colpiscono inesorabilmente i
personaggi:
il mondo dell' "Eneide", infatti, a differenza di quello omerico,
non
conosce tanto esuberanze giovanili ed esaltazione eroica, ma appare
invece
dolente e meditativo, strettamente affine all'universo delle
precedenti
opere: postulato fondamentale è l'obbedienza al Fato, e anche in
ciò
personaggio emblematico è ovviamente il "pius" Enea.
*Al poema, V.
lavorava dettando un gran numero di versi, e poi
rielaborandoli per tutta la
giornata. Seguiva uno schema di prosa che si
preparava e che poi portava in
versi. Eccone la sintesi:
Libro I: Una tempesta causata da Giunone, irata
contro i Troiani, fa
approdare Enea lungo le coste presso Cartagine. Con
l'aiuto della madre
Venere, Enea viene bene accolto dalla regina Didone, alla
quale racconta la
fine di Troia.
Libro II: Racconto di Enea: durante la
distruzione della città, Enea riesce
a scappare con il padre Anchise e il
figlio.
Libro III: Racconto di Enea: partiti da Troia, Enea si rende conto
che una
nuova patria lo attende in Occidente.
Libro IV: Dopo la partenza
di Enea da Cartagine Didone si uccide
profetizzando l'eterno odio tra
Cartagine e i discendenti dei Troiani.
Libro V: I Troiani giungono in Sicilia
dove svolgono dei giochi in onore di
Anchise.
Libro VI: Enea arriva in
Campania dove consulta la Sibilla ed entra nel
mondo dei morti. Qui incontra:
Deifobo caduto a Troia, Didone, Palinuro, il
timoniere, e il padre che gli
mostra la sua eroica discendenza.
Libro VII: Enea arriva alla foce del Tevere
e riconosce in essa la terra
promessagli dal padre. Qui stringe un patto con
il re Latino, ma interviene
Giunone che fa scagliare contro di loro il
principe Rutolo, Turno. Enea non
può più sposare la principessa
Lavinia.
Libro VIII: Enea è costretto a risalire il Tevere dove trova degli
alleati
in Evandro, re di un piccolo gruppo di Arcadi, e in una coalizione
di
Etruschi.
Libro IX: Con Enea assente il campo troiano è in una
situazione critica.
Libro X: Enea irrompe nella scena e uccide l'alleato di
Turno, Mezenzio, che
a sua volta uccide Pallante protetto di Enea.
Libro
XI: Dopo la sua vittoria Enea piange l'amico morto. Le sue offerte di
pace
non hanno successo.
Libro XII: Turno accetta di sfidare Enea a duello, ma un
intervento di
Giunone fa riprendere la guerra. Enea sconfigge Turno e lo
uccide nel nome
di Pallante.
*Si compie così il primo atto del destino di
Roma. L'evoluzione religiosa
del poeta fa dunque sì che egli approdi, dal suo
epicureismo primitivo, a un
platonismo mistico (o, se si preferisce, a un
"neo-pitagorismo"), che
ammette l'esistenza di anime sopravvissute al corpo e
discerne nel mondo un
disegno della Provvidenza. V. si avvicina, per questa
strada, alle idee
professate dagli storici intrisi di stoicismo, epigoni di
Polibio. Si
realizza in tal modo la sintesi delle principali correnti
spirituali di
Roma, che consente all' "Eneide" di farsi immagine di
quest'ultima e
giustificazione del suo straordinario valore storico.
*I
protagonisti. Enea: il divino figlio di Anchise è lo strumento
obbediente
della divinità, nella prima parte come profugo errabondo, nella
seconda come
guerriero: tuttavia egli, a differenza degli eroi di Omero,
presenta una sua
intimità, una sua umanità che lo avrebbe trattenuto ben
volentieri fra le
rovine di Troia (rimane nel fondo del suo animo
un'indistinta nostalgia del
ritorno) o fra le braccia di Didone. Insomma, la
sua "humanitas" spesso non
va d'accordo con la sua "pietas", ma lo rende
altresì più umano e più vero.
Turno: come eroe è un personaggio meglio
caratterizzato di Enea, anche se è,
per così dire, la copia virgiliana dell'
Ettore omerico.
Didone: è il personaggio, tragico e appassionato, meglio
riuscito del poema,
che supera abbondantemente i modelli cui potè ispirarsi,
la Medea di A.
Rodio e l'Arianna di Catullo.
Camilla: è un altro
personaggio ben riuscito: la sua forza e il suo coraggio
di guerriera nulla
tolgono alla sua femminile bellezza e alla sua palese e
fatale
vanità.
Figure minori, ma non meno valide, sono: Latino, Evandro, Eurialo e
Niso,
Lauso e Mesenzio.
L' "Appendix Vergiliana". Torna al sommario
Il
termine "Appendix Vergiliana" è moderno (risale, come evidentemente
la
silloge, all'età umanistica) e indica un gruppo di poemetti
pseudovirgiliani
(salvo forse un paio di poemetti dei "Catalepton"),
inseribili nel quadro
della poesia minore del I sec. D.C. (conclusivo è stato
l'esame stilistico).
I componimenti (6 poemetti, 14 epigrammi e 3 carmi
priapei) non sono
comunque databili tutti allo stesso periodo e sono
sicuramente di mani
diverse: inoltre, non si può dire con certezza se siano
stati concepiti
intenzionalmente come falsi. I componimenti principali
sono:
1 una serie di epigrammi raccolti sotto il titolo di
"Catalepton"
("componimenti leggeri"), che contengono preziose informazioni
biografiche;
2 un'epopea ingenua intitolata "La zanzara" ("Culex", 48 a.C.),
un epillio
di 414 esametri (di gusto neoterico). Un pastore, svegliato da una
zanzara
che uccide, riesce a salvarsi da un serpente. Nella notte la zanzara
gli
appare, gli fa una lunga descrizione dell'oltretomba, e chiede
sepoltura.
3 un racconto leggendario, l' "Airone bianco" ("Ciris"), di 541
esametri,
che prelude alle "Metamorfosi" di Ovidio e che trova collegamenti
con la
poesia erudita alessandrina, che si compiaceva di leggende
bizzarre:
descrive infatti la trasformazione di Scilla in un uccello marino
appunto.
4 "Dirae", carme di 183 esametri (attribuibile forse a Valerio
Catone), che
fonde insieme un canto di maledizione (contro l'attuale
proprietario del
podere di cui è stato spogliato) e un canto d'amore (il
destino lo priva
dell'amore di Lydia lontana).
5 "Aetna", poema di 646
esametri (che Seneca attribuisce al "suo" Lucilio),
di intonazione epicurea,
in cui l'autore vuole spiegare i fenomeni naturali
in modo scientifico per
sfatare le credenze popolari e le interpretazioni
dei poeti.
6 "Copa"
("l'ostessa"), ch'è la descrizione vivida di una bella ragazza d'
osteria,
che domina tutto il breve idillio di 19 distici; sulla soglia dell'
osteria,
canta e danza, invitando i passanti ad entrare.
7 "Moretum" ("la torta
campagnola"): poemetto di poco più di 100 esametri,
che descrive minutamente
la scena di un contadino il quale deve prepararsi
il cibo (la focaccia
piccante) per consumarlo al ritorno dal lavoro.
Quinto Orazio
Flacco
(Venosa 65 a.C. - Roma 8 a.C.)
VITA.
Figlio di uno schiavo
liberato (liberto), ch'era riuscito a racimolare un
piccolo patrimonio, fu
portato a studiare proprio dal padre (quello ch'egli
stesso definirà "il
migliore dei padri") nelle migliori scuole di grammatica
e retorica di Roma
(fu allievo, tra gli altri, del grammatico Orbilio),
andando a perfezionarsi
persino ad Atene versi i 20 anni. Lì O. aderì all'
ideologia repubblicana dei
giovani patrizi romani che vi studiavano anche
perché suggestionato dai temi
delle scuole di retorica: fu coinvolto, così,
dalla guerra di Bruto e Cassio,
ai cui comandi si arruolò come "tribuno dei
soldati", combattendo nella
storica battaglia di Filippi (42). Si salvò
miracolosamente, e riuscì a
tornare a Roma durante un armistizio (41),
profittando del condono politico
di Ottaviano, ma senza protezioni
politiche. Le sostanze lasciategli dal
padre erano state confiscate: per
vivere s'impiegò come contabile
nell'amministrazione statale.
In seguito frequentò a Napoli la scuola
epicurea di Sirone in compagnia di
Virgilio. Iniziata l'attività poetica con
gli "Epodi" e le "Satire", nel 39
fu presentato proprio da Virgilio a
Mecenate, che lo legò a sé come amico e
gli donò (33?) un podere nella
Sabina.
Augusto gli offrì un posto di segretario, ma O. declinò
l'invito,
assecondando tuttavia il programma del princeps sia sul piano
politico sia
su quello letterario: un intellettuale, dunque, sostanzialmente
"allineato".
Nel 17 fu incaricato di scrivere il "Carmen speculare" in onore
di Apollo e
Diana, da cantare durante i ludi saeculares. Nel 20 iniziò a
pubblicare le
Epistole il secondo libro delle quali comprende tre lunghi
componimenti di
argomento estetico fra cui l'Ars poetica. Nell'8 a.C. scrisse
quattro libri
di Odi, fra le quali si distinguono le c.d. Odi romane. Nel
settembre dell'8
a.C. morì Mecenate. O. si sentì perduto, e anche lui si
spense il novembre
del medesimo anno a causa di una emorraggia cerebrale o
paralisi. Fu sepolto
accanto alla tomba di Mecenate, "la metà dell'anima
sua".
OPERE.
*"Epòdi" (41-30 a.C.). Sono 17 componimenti (O. li chiama
"iambi"), ordinati
metricamente.
O. emula i giambografi greci, soprattutto
Archiloco (ma ne mutua più che
altro i metri e l'ispirazione aggressiva, non
già i contenuti), anche se il
suo furore è, in verità, talvolta alquanto
letterario. Tuttavia, gli
"Epòdi", malgrado una certa ridondanza stilistica,
sono fondamentalmente più
violenti delle "Satire", e più amari: vi deplorava
le disgrazie della patria
e affermava la propria indignazione per alcuni
scandali derivati dalle
guerre civili.
Ora, quindi, sono appunto le ansie
per il pericolo della guerra civile
(epòdi VII e XVI); ora invettiva contro
un abietto tribuno militare (IV),
contro un ringhioso codardo (VI), contro un
poetastro (X), contro una
vecchia libidinosa (VIII e XII), contro una strega
(V e XVII). Ma anche qui
affiora la mitezza di O.: timidamente in I e IX,
indirizzati a Mecenate al
tempo di Azio e oscillanti tra ansia e fiduciosa
serenità, più decisamente
nei rimanenti, e soprattutto nel II, dove malgrado
l'ironia finale c'è un
forte gusto per la vita agreste, mentre infine nel
XIII compare un altro
tema caratteristica: quello della fugacità della
vita.
*"Satire" ( dette dal poeta stesso "Sermones"). Scritte in esametri,
sono
divise in 2 libri: il I (35-33 a.C.) ne comprende 10, il II (30 a.C.)
8.
Difficile ne è la cronologia interna.
Abbandonate le inquietudini e il
disadattamento degli "Epòdi", attraverso
certo i temi della predicazione
filosofica (ma non quella più rigida e
moralistica) e la lettura di poeti
quali Lucilio (di cui vuol essere la
versione moderna: I4 e I10), O. cerca di
elaborare in forma piana e
discorsiva (si tratta di componimenti misurati,
caso mai vivaci, ma come
detto non sfoghi moralistici) un suo ideale di
misura che lo salvi dalle
tensioni interne e non gli precluda il godimento
della vita ("autàrkeia" e
"metriòtes").
Il poeta insomma ricerca una
morale di autosufficienza e di libertà
interiore, valendosi di uno
straordinario senso critico e autocritico, oltre
che del suo tatto e della
sua conoscenza del mondo: il ragionamento si
mantiene sul piano
psicologico-umano, e la polemica non è tanto contro i
vizi in sé, quanto
contro la loro vera radice, ovvero l'eccesso.
Inoltre, nelle prime "Satire",
O. si sforza di dimostrare che la morale
epicurea non è in disaccordo con i
valori tradizionali di Roma: moderazione,
saggezza, rispetto dei costumi,
eccetera. Insiste anche sulla semplicità
dell'esistenza rurale quale
condizione della felicità, parlando, in questo
senso, un linguaggio simile a
quello di Virgilio e precisamente nello stesso
periodo, all'incirca, in cui
questi componeva le sue Georgiche. Affinità vi
sono anche col linguaggio di
Tibullo. Inoltre, l'amicizia da lui spesso
elogiata non è scambio di favori,
e ancor meno schiavitù (come spesso
avveniva a Roma quando gli amici erano di
condizioni ineguali), ma una
comunione profondamente spirituale o, anche,
ideale.
Altra satira programmatica è la II1, dove O. risponde alle
critiche
rivoltegli. Spunti autobiografici, invece, si trovano nelle satire:
I4 (sul
padre); I6 (sulla presentazione a Mecenate); I5 (sul viaggio a
Brindisi al
seguito di Ottaviano); II6 (in cui esprime la gioia per la villa
donatagli).
Satire più propriamente etico-filosofiche sono invece: I2
(sull'adulterio;
vigorosa); II3 (sulla pazzia degli uomini, eccetto il
filosofo; briosa); II6
(con l'apologo del topos campagnolo e del topos
urbano).
*"Odi" (secondo i grammatici), "Carmina" per O.. I primi 3 libri (88
odi),
dedicati a Mecenate, furono pubblicati nel 23 a.C., il IV (15 odi:
quindi,
in tutto 103 odi) nel 14-13 a.C. O. aggiunse il IV libro dopo molti
anni, su
richiesta di Augusto per "cantare" la vittoria di Druso e Tiberio su
Reti e
Vindelici.
Il criterio d'organizzazione del libro sembra essere
quello della
"variatio": sia dal punto di vista metrico-formale (ben 13 sono
i metri
usati), sia per tono e contenuti (alternanza di temi politici e
temi
privati, di stile alto e stile leggero).
L'ispirazione oraziana qui
si modifica e purifica in composizioni
raffinatissime, chiuse nel giro di
strofe perfette (il modello è nei poeti
classici greci: Alceo, Saffo, ma
anche Anacreonte, Bacchilide, Pindaro.): le
"Odi" si caratterizzano come un
riuscito tentativo di trasferire a Roma i
ritmi della poesia eolica.
Lo
stile diventa esteriormente asciutto, la forma è rigorosa, quasi fredda;
il
tutto, insomma, caratterizzato da un lato dalla sapienza tecnica (la
"callida
iunctura", cioè l'accorta disposizione delle parole e
l'accurata
articolazione del periodo) e dall'altro dal controllo di
impressioni e
sentimenti: O. si presenta come discepolo dei "poeti nuovi",
alla ricerca
anch'egli della perfezione formale e delle soddisfazioni
derivanti dal
superamento delle difficoltà.
Se O. nei "Sermones" era
apparso, così, poeta e narratore, nelle "Odi" si
rivela nelle vesti di un
sublime "moralista": non perchè vada predicando una
morale, ma perchè eccelle
nel cogliere e nell'esprimere in un ritmo, in un
accostamento di parole,
nella suggestione di un'immagine, un'"esperienza"
privilegiata che illumina
l'anima e la rivela a se stessa.
La causticità polemica è allora qui
abbandonata come giovanile intemperanza
(I16): è invece insistente l'idea
della "misura" ("aurea mediocritas",
II10). Essa assume una dimensione nuova:
da una parte viene ancorata
saldamente al concetto di felicità con motivi
tradizionali e stilizzazioni
(modestia, parsimonia, campagna contro città,
etc.: ad es., I18,
II2-3-15-18, III1 e 16), ma con l'aggiunta del motivo -
riflesso
autobiografico - della felicità di chi, oltre che saggio, è anche
poeta
(II16,III14.); dall'altra, sul piano della meditazione, è associata
all'idea
della morte, che tutto rilivella (II3 e 8, III1 e 24): il senso
della
fugacità della vita acquista rilievo e ispira tra le "odi" più
celebrate:
I11 (v'è il motivo del "carpe diem"), I24 (in morte del poeta Q.
Varo), I28
(sulla tomba del pitagoreo Archita), II14 (a Postumo),
ecc.
Attinto alle correnti filosofiche dell'epoca (in special modo,
l'
epicureismo), ma filtrato dalla sensibilità dei lirici greci (ad
es.,
Mimnermo), dato senso di fugacità aleggia come malinconia leggera su
questa
poesia, che è pure sostanzialmente limpida e serena. Di nuovo,
dappertutto
traspare la bonaria umanità, che si esprime soprattutto in un
trepido senso
dell'amicizia, nel gusto della compagnia (le cosiddette "odi
conviviali"),
nel controllo stesso delle passioni nelle non poche odi
dedicate a donne i
cui modi (Lidia, Làlaga, Cloe, Mirtale.) celano quasi
certamente persone (e
forse financo vicende) reali (O. aveva già manifestato
a Mecenate la
necessità di una poesia che cantasse l'amore: chiede infatti
proprio
all'amico di porlo tra i poeti lirici (1 I 35)).
Una delle
intuizioni fondamentali dell'epicureismo era il valore proprio di
ogni
istante. O. se ne impadronisce e ne fa uno dei temi del suo lirismo.
Il
"carpe diem", nel quale si è pensato di poter riassumere la sua
"saggezza"
(riducendola, in questo modo, ad una formula angusta e anche un
po'
volgare), è innanzitutto il nucleo di una poetica. Non è tanto la
ricerca,
fine a se stessa, del piacere, ma il tentativo di scoprirlo nel puro
e
semplice fatto di vivere. In questa prospettiva, O. canta il "tempo
libero"
(otium), che è anche quiete dell'intelletto e dell'anima, libertà
interiore:
il carmen prolunga la strada imboccata col sermo, trasfigurando
ciò ch'era
stato consiglio obiettivo in scoperta dell'anima. Il pensiero
stesso della
morte, anziché rivelarsi amaro, dà tutto il suo valore alla
rinnovata
presenza della vita.
Forse anche il vistoso apparato mitologico
va inteso, al di là del richiamo
alessandrino o degli agganci alla religione
della Roma augustea, come un
elemento di voluta fissità, oltre che di
pindarica sublimazione della
poesia; epicureo, O. non crede davvero
all'intervento degli dèi nel mondo:
egli ne fa un gioco, allargando la sua
sensibilità di poeta alla creazione
tutta intera, senza voler scoprire in
essa il segno di una trascendenza
divina. Ma, in fondo, non è un problema che
lo interessi molto. Egli onora
le divinità campestri della sua tenuta come
presenze familiari che
prolungano il suo personale universo interiore, non
per manifestare ad esse
la propria "adorazione".
Quasi sicuramente,
infine, nessun latino ha avuto più di O. la coscienza di
essere poeta: non
per nulla, accettò di divenire uno dei vati ufficiali del
regime di Augusto:
ne fa fede l'importante filone etico-politico che
riscontriamo nelle "Odi"
(ovvero i 6 componimenti (detti "odi romane",
appunto) con cui si apre il III
libro), nonché il "carmen saeculare".
*Il "Carmen Saeculare". Augusto nel 17
a.C. indìce i ludi Saeculares, nel
momento più adatto, scelto con grande
abilità, per celebrare i ludi,
testimonianza di un'epoca di guerre e di lotte
civili che si chiude e di
un'era di pace che si apre.
Morto Virgilio nel
19, nessun altro poeta poteva ricevere l'incarico di
comporre l'inno per i
ludi, perché nessuno più di O. aveva dimostrato,
specialmente con le odi
romane, di saper interpretare l'essenza della
grandezza di Roma. O. accettò
l'incarico, che significava per lui
riconoscimento del suo ruolo di poeta
nazionale e, più ancora, consacrazione
della sua attività lirica, che appunto
dalla composizione del "Carmen"
trasse nuova linfa e riprese
sostanza.
Così, il poeta affida al canto di due cori di giovani, l'uno
maschile e l'
altro femminile, il compito di invocare la protezione degli dèi
su Roma.
Il "Carmen" presenta, ovviamente, i difetti propri delle
composizioni
eseguite su commissione, ma, se non è sorretto da altissima
ispirazione, è
tuttavia opera di altissima dignità artistica e, soprattutto,
di profonda
sincerità. Inoltre, in tutti quei luoghi in cui il poeta può
liberarsi dagli
obblighi impostigli dalle circostanze o dalla liturgia e
dispiegare
liberamente la sua fantasia, egli raggiunge "l'intensità poetica
delle sue
liriche più felici, interpretando con severità e serietà il mito
storico di
Roma e di Ilio, ma soprattutto esprimendo un ideale quasi ieratico
di
potenza e di predominio" (Turolla).
*"Epistole". In esametri e in 2
libri: il I (di 20 componimenti) dedicato a
Mecenate, uscì nel 20 a.C.; delle
2 del II libro, quella ad Augusto è del 14
o 13, quella a Floro è del 18
ca.
L'epistola in esametri è probabilmente una sperimentazione originale: O.
non
si richiama, del resto, ad un inventore del genere. Con essa (di cui
si
discute il carattere "reale" o meramente "letterario"), il poeta -
oramai
maturo - cerca un dialogo più intimo e raccolto con sé stesso: c'è
un
bisogno di calma e di tolleranza, in cui si annida tanta esperienza
umana,
interiorizzata in una sorta di ascesi laica (e il tutto presuppone
lo
spostamento verso una periferia agreste, che risuona di memorie
filosofiche:
un "angulus", insomma): è il frutto della migliore lezione del
suo
epicureismo (non vi è dunque "svolta" in senso stoico).
*Infine, al II
libro è aggiunta l'epistola ai Pisoni, nota come "Ars
poetica" (17 o 13
a.C.), in esametri: ricca di riferimenti a Neottolemo di
Pario e ancor più ad
Aristotele, è impostata sul problema dell'unità dell'
opera d'arte e del
rapporto tra contenuto e forma, esaminato prendendo come
principale punto di
riferimento il dramma. Due tesi, in particolare, sono
celebri: la necessità
di fondere la spontaneità e immediatezza dell'
ispirazione con lo studio
metodico e il paziente lavoro di lima; e il noto
principio dell' "utile
dulci", della fusione cioè fra utile e dilettevole.
Torna al
sommario
Breve profilo introduttivo della letteratura d'amore in
Roma.
La poesia d'amore nasce tardi nella letteratura latina e si afferma
solo nel
II sec. a.C., quando i Romani, concluse vittoriosamente le guerre in
Oriente
e in Grecia, allentano le preoccupazioni per l'interesse dello
stato,
trovando il tempo e l'animo per dedicarsi anche alla vita
anteriore.
I tempi nuovi, meno condizionati dagli obblighi e dalle campagne
militari,
permettono di coltivare, oltre ai modi della scrittura adatti
alla
riflessione sul bene comune (come la storiografia, l'oratoria, il
teatro, la
satira, il poema epico e la tragedia stessa), generi nuovi da
dedicare
all'effusione dei sentimenti o alla ricerca dell'io.
Intorno a
tali tematiche si raccolgono gli intellettuali del circolo
letterario di
Lutazio Càtulo (ca. 150-87 a.C.), che dà vita a una produzione
di sapore
individualistico, particolarmente elaborata nello stile. I poeti
appartenenti
a tale corrente sviluppano argomenti e forme della poesia
ellenistica,
rifacendosi soprattutto a Callimaco, come appare evidente da
alcuni brevi
componimenti dello stesso Lutazio Càtulo.
Se n'è fuggito il mio cuore: se ne
sarà andato, al solito, da Teotimo.
Sicuramente è quello il suo rifugio. Ma
come? Non gli avevo forse imposto di
non accogliere il fuggitivo, e di
scacciarlo piuttosto? Andremo a cercarlo.
Ma temo di essere trattenuto io
stesso. Che fare? Consigliami, o Venere.
(Epigramma 1 Morel; trad. di V.
Sirago)
Valerio Edituo invece riprende una famosa ode si Saffo, il frammento
31 LP,
che ispirerà anche il più celebre carme 51 di Catullo.
Quando mi
sforzo di dirti, o Pànfila, la pena del mio cuore, e che cosa
desidero da te,
le parole mi mancano sulle labbra; nel petto in una vampa
trascorre
improvviso il sudore; così tacito, avvampante, mentre mi
vergogno,
muoio.
(Epigramma 1 Morel; trad. V. Sirago)
Il circolo
intorno a Lutazio Càtulo, non a caso detto "preneoteorico", ha il
merito di
anticipare e preparare l'importante circolo dei poeti novi, o -
alla greca -
neoteroi, scrittori colti, consapevolmente indirizzati a
riprodurre nei metri
e nei temi i grandi modelli della poesia alessandrina e
dei lirici
greci.
Se l'epigramma di Valerio Edituo brilla sotto il profilo
compositivo
soprattutto per la sua chiusa sorprendente, dove il "vergognarsi"
(pudeo) è
contrapposto al "morire" (pereo), tocca al carme 51 di Catullo il
compito di
istituire un topos della poesia d'amore, legando la lirica latina
al mondo
dei sensi e della passione e quindi avviando il filone della
"malattia
amorosa" e della "servitù d'amore".
Già Lucrezio aveva proposto,
nei duecento versi del finale del IV libro, il
tema dello sconvolgimento
psicofisico che accompagna il furor degli amanti,
restando però all'interno
di un contesto filosofico, che neppure il vigoroso
movimento delle immagini
riesce a distaccare dai parametri epicurei della
lontananza da ogni
passione.
In Catullo, pur in assenza dell'effigie femminile, l'effetto di
concretezza
del rapporto risulta rafforzato a causa del realismo con cui sono
presentati
i sintomi dell'amore/malattia, che il poeta soffre sul proprio
corpo con la
perdita della voce, della vista e persino dell'udito, fino al
deliquio
(carme 51, vv. 7-12).
Il sapore del "vissuto" e della
"quotidianità" dell'amore, talora felice
(carmi 5 e 7), più spesso infelice
(carmi 8, 58 e 70) trova efficacia
particolare grazie alle scelte
linguistiche in cui si intrecciano linguaggi
diversi, da quello parlato
(carme 5: basia, "i baci") a quello
finanziario-contabile (carme 5, v. 3:
"consideriamolo un soldo bucato") a
quello dotto di derivazione
ellenistico-callimachea (carme 7, vv. 3-6:
"Cirene...Batto").
La
complessità linguistica e formale e la varietà dei modelli ai quali
Catullo
si è ispirato non tolgono nulla alla forza del canto, in cui si
intrecciano
poesia e vita, letteratura e autobiografia. Il poeta stesso è
implicato nella
storia che narra e le sue parole hanno il sapore
dell'esperienza. Il
canzoniere di Catullo, pur nell'esercizio continuo della
doctrina e della
raffinatezza formale, effonde un senso profondo di umanità
per la "mondanità"
dei fatti e delle emozioni. Quando è ormai chiaro che
Lesbia tradisce il suo
Catullo, il dolore del poeta si manifesta
nell'incalzare di mille reazioni,
dall'autoesortazione all'oblio (carme 8)
unita all'accorato fluire dei
ricordi - la rievocazione dei luminosi giorni
passati con Lesbia -, alla
denuncia lucida e incredula dell'odi et amo, voce
semplicissima e fortissima,
oggi emblema del contrasto sempre lacerante fra
amore e odio (carme
85).
La donna ormai lontana continua a occupare i pensiero del poeta fino
quasi a
condurlo con l'assolutezza della sua presenza alla follia. Catullo
cerca
allora di superare il tormento rielaborando in modi diversi il rapporto
con
Lesbia: senza mai abiurare al suo amore, prospetta un legame insolito per
la
cultura romana che sarà destinato a orientare la letteratura d'amore fino
al
Medioevo e oltre. Nobilita cioè l'intensità totalizzante e assoluta
della
passione con il rigore di un "patto" che vincola i due amanti anche
senza il
matrimonio (carme 87).
E Catullo, sia pure con toni che
variamente riproducono l'ossessiva presenza
di Lesbia anche dopo il
tradimento di lei, non cessa di approfondire, quasi
stupito per le sue stesse
scoperte, la psicologia amorosa. Riprende così
l'antitesi "odio/amore" nel
carme 92 dove l'immediatezza espressiva appare
inferiore a quella del carme
85, mentre è maggiore la raffinatezza
psicologica che induce Catullo, fra
straniamento e perdita della lucidità,
ad attribuire alla donna, per una
sorta di transfert, sentimenti affini ai
suoi.
Lesbia va continuamente
sparlando di me, e non sta zitta, quando si parla di
me: mi venga un
accidente se Lesbia non mi ama. "Da che cosa l'arguisci?".
Perché sono gli
stessi indizi miei: continuo a detestarla, ma mi venga un
accidente se non la
amo!
(trad. F. Della Corte)
La varietà dei metri e delle forme nel libro
catulliano ben rappresenta la
mutevolezza dell'animo femminile e la
complessità esistenziale del rapporto
d'amore.
Catullo, nell'intreccio fra
vicenda umana e iper poetico, dà l'avvio a un
modello di linguaggio amoroso e
a un genere letterario, nel quale stringe un
legame intellettuale importante,
anche se implicito, con tutti i fedeli - e
i malati - d'amore. Lesbia, ora
innamorata dolce-ingenua, ora amante della
passione dirompente, ora
ingannatrice, infine vera e propria traditrice di
ogni patto sancito, donna
di strada nutrita d'intrighi, è figura dominante e
concreta che mette l'amore
al primo posto, a costo di contrapporlo alle
consuetudini sociali del tempo o
alla vita morale del poeta.
Non si può infatti dimenticare che nel I sec.
a.C. l'epica, la tragedia e i
generi filosofico-didascalici disapprovavano
chiunque presentasse amori
diversi da quelli improntati al nobile sentire. È
Catullo il primo scrittore
che toglie la poesia erotica dal clima leggero del
gioco mercenario e mette
al centro la donna reale, con il suo carico di
contraddizione e di
infelicità.
Nel secolo di Augusto, Orazio continuerà a
cantare d'amore, imitando le
fonti greche, come Alceo (carme I, 9), Semonide
di Amorgo (carme I, 5 "Quale
giovane a-gile ti chiama/tra molte rose e puri
aromi, Pirra/nella grotta
felice...) o gli ellenistici, e offrirà una sua
visione leggera e
malinconica dell'amore, tributando a Catullo solo il debito
di qualche
"citazione" colta.
Ma Catullo "sarà maestro per la generazione
degli elegiaci, che da lui
trarranno la concezione dell'amore come continua
sofferenza e come
consapevole scelta di vita" (P. Fedeli). Con la
suggestione, la novità e la
raffinatezza dei suoi versi diviene modello di
altri poeti e in particolare
di P..
L'amore, presentato sempre più
esplicitamente come motivo di vita, si fa
materia privilegiata per il canto e
per l'effusione dei sentimenti.
Anche P. prende spunto dalla sua vicenda
amorosa, ma non si ferma
all'esperienza. Sapendo fin dall'inizio (grazie alla
frequentazione del
libro catulliano) che la sua storia non sarà solo ricca di
gioia, cerca di
delineare una teoria dell'amore: chi vive come "fedele
d'amore", anche se
infelice, compie una scelta difficile, ma superiore a
quella di chi
intraprende la carriera politica o militare. È dunque meglio
rinunciare agli
onori delle cariche o alle ricchezze e lasciarsi soggiogare
dalla tirannia
dell'amata. La sua Cinzia esercita un duro dominio
costringendo il poeta a
una pesante "schiavitù".
Dalle Elegie di P.
traspare un nuovo legame fra arte e vita: nella vita il
poeta si dedica alla
donna trascurando gli impegni pubblici; nell'arte
ricerca moduli adatti a
cantare il suo sentimento totalizzante e assoluto.
Il rapporto sentimentale,
che già in Catullo aveva trovato importanza e
significato oltre il semplice
gioco e-rotico o mondano, diventa ricerca di
valori etici e letterari.
Non
compare tuttavia alcuna idealizzazione dell'amore. Anzi P., nell'elegia
(I,
6) in cui dichiara di rinunciare - per amore - a seguire l'amico Tullo
in
Oriente, riconosce con semplicità di cedere all'"estrema
debolezza"
(nequitia, v. 26), obbedendo alle parole di Cinzia, che dolente e
adirata
gli ingiunge di rimanere in patria:
"questa è la milizia a cui mi
costringe il fato" (v. 30).
Il canzoniere properziano mantiene e rafforza
l'importanza della donna e
dell'amore nella poesia e nella vita, continuando,
nonostante gli inviti di
Augusto a comporre versi impegnati, a riproporre la
sua appartenenza ai
"fedeli d'amore".
L'elegia: la sua nascita e
la sua fortuna a Roma
Nella sua storia, l'elegia ha conosciuto toni e
contenuti molto diversi, pur
nell'unità della struttura metrica, che è quella
del distico detto, appunto,
'elegiaco' (un esametro e un pentametro dattilico
in coppia). Nata in
ambiente ionico nel VII sec., fu guerresca con Callino e
con Tirteo; con
Solone divenne politica e sociale; con Mimnermo cantò la
fugacità
malinconica della giovinezza e dell'amore; fu pessimistica e
moraleggiante
con l'aristocratico Teognide, filosofica con Senofane. Nella II
metà del V
sec., significativa fu l'opera di Antimaco di Colofone, che
raccolse una
serie di elegie che narravano vicende mitiche d'amore sotto il
nome di Lide,
la sua donna (come Mimnermo aveva fatto per la flautista
Nannò), costituendo
un importante tramite per l'elegia erotica e narrativa di
età ellenistica.
Abbiamo così, in età alessandrina, la Leonzio di
Ermesianatte, Gli amori di
Fanocle, forse la Battide di Filita, l'Apollo di
Alessandro Etolo, la grande
elegia eziologica di Callimaco. L'elegia
alessandrina fu sopra tutto
l'elegia dell'eros tormentato e doloroso, delle
passioni del mito meno
conosciute: fu elegia raffinata che ricercò ogni
recondita dottrina; in essa
il poeta, molto più che parlare di sé, doveva
esporre gli antichi, mitici
casi d'amore.
Agli elegiaci alessandrini (come
Callimaco e Filita) i Latini si rifecero
come a maestri. Purtroppo della
produzione ellenistica quasi nulla a noi è
pervenuto, e non possiamo dunque
dire se anche negli elegiaci alessandrini
fosse presente, magari in piccola
parte, quel carattere personale e
soggettivo che è tipico, invece, dei
latini.
Certo, Quintiliano con la sua celebre affermazione (10, 1, 93
elegia...
Graecos provocamus: "nell'elegia gareggiamo coi Greci") doveva
avvertire
concretamente i caratteri in parve innovatori dell'elegia romana.
Di sicuro
noi possiamo sottolineare l'importanza di Catullo e del suo mondo
poetico
per la formazione dell'elegia latina: nelle forme e nelle
tecniche
alessandrine egli aveva immesso l'intensità passionale del suo
temperamento,
gli odi e gli amori, Il dolore e l'idealizzazione mitica di una
donna,
l'esperienza drammatica della vita vissuta.
Riduttiva appare la
tesi di F. Jacoby, secondo la quale l'elegia latina
deriverebbe non
direttamente dall'elegia ellenistica (F. Leo), ma da un
ampliamento
dell'epigramma greco, il genere letterario al quale i poeti
d'Alessandria
avevano affidato l'espressione diretta del sentimento
personale. Spunti
epigrammatici non mancano, certo, presso gli elegiaci
latini. Ma la
momentanea effusione del poeta ellenistico, che quasi sempre
s'esaurisce in
un respiro troppo breve e termina spesso con una conclusione
convenzionale,
viene, dagli elegiaci latini, inserita in un componimento che
è già
strutturalmente diverso, più ampio e impegnativo. Neanche sono assenti
punti
di contatto tra elegia latina e commedia nuova. Ma sia per
l'epigramma, sia
per la commedia, quanta parte doveva avere, anche per i
poeti elegiaci,
l'insegnamento della scuola, in particolare la retorica, col
ricco suo
campionario di temi e situazioni che, desunti dalle fonti più
disparate,
offriva alle esercitazioni degli allievi?
L'immediato precedente dell'elegia
latina resta l'elegia erotica
alessandrina che, quasi del tutto perduta per
noi, con buona probabilità non
doveva ignorare, accanto la narrazione mitica,
anche il diretto riferimento
del poeta alla sfera del suo personale
sentimento, pur se per i Latini,
posta l'esperienza fondamentale della
lezione catulliana, il discorso
soggettivo e intimistico si amplierà e si
approfondirà. Per non parlare
dell'elegia a sfondo più spiccatamente
eziologico: gli Aitia callimachei
costituiscono l'indubbio punto di
riferimento per le "Elegie romane" di P. e
per i Fasti ovidiani.
Al centro
dell'elegia latina è la figura femminile, una donna dai netti
connotati
spirituali e dalla presenza fisica talora assai corposa, e
ossessiva. Accanto
a lei, un poeta che la canta, perchè oltre tutto e'
proprio lei ad esserne
l'ingenium, l'ispirazione esclusiva, e che la adora,
pur fra tradimenti, liti
e riappacificazioni, in un vagheggiamento che la
traspone in una dimensione
mitica. Essenziale, nel corteggiamento, è lo
stesso esercizio poetico, che
prospetta all'amata una fama imperitura.
Immancabilmente bellissima, la donna
è vita del poeta, ed è idealizzata sin
nel nome (Lesbia, Delia, Cynthia...).
E' l'amica o, meglio, la domina alla
quale sottomettersi in un servitium, non
senza un dolce arrovellarsi nella
sofferenza, perchè traditrice è la donna, e
volubile. E' comunque amore che
vuole durare eterno, e non passione
intensissima ma labile, come quella di
un epigrammista greco. E' eros che va
oltre la morte e che talora il poeta
canta come nenia funebre (flebilis è,
tradizionalmente, il componimento
elegiaco).
Il poeta elegiaco s'abbandona
a un intreccio di immagini ove la fantasia
vale almeno quanto la realtà, e in
cui l'ebbrezza scatenata dei sensi non
esclude l'esigenza di rinvenire un
corrispettivo della propria passione nel
mondo sublime, ma estremamente
ambiguo, del mito.
Gaio Cornelio Gallo
(Forum Julii, odierna
Fréjus, 69 - 26 a.C.)
VITA.
Imbevuto di cultura ellenistica, G.
costituisce l'anello di congiunzione tra
la poesia neoterica e l'elegia
augustea.
Nacque nella Gallia Narbonese. Cornbattè con Ottaviano contro
Antonio in
Egitto e, nel 30, divenne il primo praefectus Aegypti. Alcuni
suoi
atteggiamenti, congiunti alla tendenza a tributare onori divini
ai
governanti, tipici di quella regione, lo misero in cattiva luce
presso
Ottaviano, che lo fece condannare all'esilio e alla confisca dei beni.
G. si
uccise. La damnatio memoriae che il princeps volle del suo prefetto
indusse,
come sembra, Virgilio, che pure era stato legato a G. da intensa
amicizia, a
sostituire il finale del IV libro delle Georgiche, che si
chiudevano con le
sue lodi, con l'episodio di Aristeo, ma non impedì che P.
lo celebrasse come
insigne poeta d'amore e Ovidio vedesse in lui l'iniziatore
dell'elegia
latina.
Determinante per la sua formazione fu l'amicizia con
Partenio di Nicea, il
poeta greco che molto contribuì alla diffusione
dell'alessandrinismo presso
i neoteroi. A lui Partenio dedicò la sua raccolta
in prosa di dolorose
vicende d'amore (Erotika pathemata) come repertorio di
casi e di citazioni
da utilizzare per la composizione dei suoi
versi.
Accanto a quella di Partenio, rilevante fu pure l'influenza
della
'difficile' poesia, di carattere mitico e astrusamente erudito, del
greco
Euforione di Calcide (III secolo).
G. amò, sotto lo pseudonimo di
Licoride, una donna seducente quanto
spregiudicata. Da schiava, 'Licoride'
era riuscita a diventare mima,
idoleggiata attricetta, col nome di Citeride
(ma si chiamava solo
Volumnia...). Amante di Bruto e di Antonio, dovè fare
irresistibile presa
sull'animo sognante - cosi ce lo descrive Virgilio nella
X ecloga - di G.,
che tuttavia abbandonò nel più profondo sconforto per
seguire un ufficiale
tra le nevi delle Alpi e i freddi del Reno. Capricciosa
e leggera, la
pulchra Lycoris fu tuttavia 1'ingenium di G. (cosi Marziale in
8, 73, 6) ed
ebbe gli onori della poesia nei 4 libri di elegie che il poeta
compose e
riunì forse col nome di Amores (o proprio col suo nome,
Lycoris?).
OPERE.
Sino a pochi anni fa, di G., posto da Quintiliano
(10,1, 93) tra i massimi
poeti elegiaci, avevamo soltanto un pentametro,
contenente una nota erudita,
secondo la migliore tradizione alessandrina, su
un fiume della Scizia. Tutto
ciò ci rimaneva del corpus attestato invece
dalla tradizione: 4 libri di
elegie, "Amores" ed epilli. Nel 1979 un papiro
egiziano ci ha restituito una
decina di versi, nel primo dei quali è presente
il nome di Licoride. Se
questi versi sono effettivamente autentici, resta
confermata l'importanza
che gli antichi assegnavano all'esperienza poetica di
G.: vi son contenute
le note soggettive tipiche dell'elegia latina, Ia
dedizione d'amore intesa
come servitium nei confronti della domina, l'accenno
alla nequitia, alla
dissolutezza, un concetto caratteristico del mondo
elegiaco.
Probabilmente nella poesia di G. dovevano essere presenti i motivi
e la
struttura compositiva della grande elegia augustea. In particolare, le
note
mitiche ed erudite dovevano fondersi con la diretta esperienza
sentimentale
del poeta amante.
Albio Tibullo
(Gabii 55/48 - 19
o 18 a.C.)
VITA.
Abbiamo poche e incerte notizie sulla vita di T., il
poeta elegiaco che
Orazio (nell'epistola 1, 4) ritrae, pur bello e dotato di
ogni bene, mentre
s'aggira nella campagna di Pedum (nei pressi di Tivoli)
troppo immerso in
penosi pensieri, ridotto come un "corpo senz'anima".
Di
ceto equestre, T. nacque in territorio laziale, anche se è molto
improbabile
l'identificazione del luogo di nascita nel villaggio di Gabii,
come da
qualcuno è stato proposto.
Fece parte, a Roma, del circolo di Messalla
Corvino, e con Messalla, cui fu
sempre legato da intensa amicizia, partecipò
a due spedizioni militari, una
in Oriente, nel corso della quale dove
fermarsi, ammalato, a Corcira
(Corfu); l'altra in Aquitania, ove si distinse
per meriti militari (cantò il
trionfo di Messalla - celebrato nel 27 -
nell'elegia 1,7 nella quale è anche
un passo sul dio Osiride, interessante
documento della sua religiosità).
OPERE E CONSIDERAZIONI.
*Il "Corpus
Tibullianum". I codici ci hanno trasmesso 3 libri di elegie. I
primi due sono
sicuramente di T.. Il I fu composto tra il 30 e il 25, e
consta di 10 elegie.
Vi si canta sopra tutto l'amore per una donna, Delia,
che Apuleio, nella sua
Apologia (10), dice chiamarsi Plania (T. avrebbe
ellenizzato il suo nome:
planus = delos). Il II comprende 6 elegie, in tre
delle quali è cantata un
altra donna, chiamata con uno pseudonimo, Nemesi:
come una 'Vendetta' per i
tradimenti di Delia. Di un altro nome di donna fa
cenno Orazio nell'ode 1,
33: una certa Glicera, una Glicera crudele ch'è
venuta meno al patto d'amore
col poeta.
C'è poi il III libro, che gli umanisti italiani divisero in due
parti. La I
contiene una raccolta di 6 elegie che l'autore, un poeta di nome
Ligdamo,
dedica alla sua Neera. La II consta di un anonimo Panegyricus
Messallae, di
undici elegie che cantano l'amore di Sulpicia e Cerinto, per
concludersi con
due componimenti, verisimilmente attribuibili a T. giovane:
un'elegia per
una ragazza innominata (la Glicera di cui parla Orazio?) e un
epigramma.
Molto probabile è che l'intero Corpus sia frutto di poeti del
circolo
letterario di Messalla Corvino: vi si nota come una ispirazione
comune,
quasi monocorde, comunque lontana dall'estrema ricchezza e varietà di
toni
dei poeti della cerchia di Mecenate.
*I due libri di T.. Il mondo
poetico di T. si configura come un nostalgico
vagheggiamento dell'amore e
dell'ombra. I temi fondamentali della sua poesia
sono la campagna e l'amore,
molto spesso intrecciati. Il poeta ama vedere la
sua donna, Delia, sullo
sfondo della campagna, e contemplarla con tenerezza,
talora appena tinta di
un indefinito dolore. Il suo è amore fatto sopra
tutto di malinconica
dolcezza, oscillante tra il desiderio di star vicino
alla sua donna e certe
fantasie di morire. Nel II libro i toni divengono
forse più sofferti e crudi
per la venale Nemesi, il nuovo amore che avrebbe
dovuto sostituire l'infedele
Delia, e che invece ha imposto al poeta una
umiliante schiavitù, un triste
servitium. Le note di fondo permangono,
tuttavia, sostanzialmente identiche.
Le avventure con Delia, con Nemesi o,
ancora, col giovinetto Marato (cui T.
dedica ben tre elegie nel I libro)
sembrano spesso svaghi di fantasia più che
reali, effettive esperienze.
L'amore del poeta non è quello, travolgente e
passionale, di Catullo per
Lesbia. E' tenerezza, languore intriso di
nostalgia e, molto spesso,
espressione di vicende intraviste, sognate, molto
più che vissute.
A ciò contribuisce la tecnica compositiva di T., che ama
disporre come a
onde i vari motivi che si sviluppano nell'elegia. Un tema si
innesta su un
altro, per poi venire abbandonato e poi ripreso, in un gioco
sinuoso di
volute entro cui ogni realtà sembra perdere i suoi connotati. Non
sono - si
badi - le digressioni che con dotta arte gli alessandrini
inserivano nel
discorso poetico. In T. la trama poetica, pur unitaria, si
risolve in una
variazione di temi che quasi si inseguono intorno a quello di
fondo, come in
una composizione musicale. Le vane note della poesia
tibulliana, la
deprecazione della guerra, l'esaltazione della pace dei campi,
le fantasie
d'amore e di morte, gli stessi luoghi comuni dell'erotica
alessandrina (il
lamento davanti alla porta chiusa dell'amata, Cupido armato
di frecce, i
riti magici per conquistare la donna) si fondono, spesso senza
scorie che
sappiano di stilizzazione, di 'maniera', in una struttura tanto
sottile
quanto organica. L'assenza di erudizione mitologica rende ancora più
nitido
il disegno dell'elegia tibulliana che, anche per questo,
occupa
nell'antichità un posto tutto particolare, straordinariamente
moderno.
L'andamento vago, ondeggiante del testo poetico di T. si combina -
ed è qui
forse il suo fascino precipuo - con un linguaggio chiaro, elegante
nella sua
sobrietà, in apparenza semplice, ma in realtà risultato di
un
sorvegliatissimo, dotto studio, espressione consumata di quel senso
della
misura caratteristico del classicismo augusteo. Quintiliano
acutamente
definì T. tersus atque elegans (10,1,93). Armonioso e musicale è
il suo
distico; forse solo un po' monotono.
Un esempio tipico della
composizione tibulliana per associazione di idee può
essere fornito da un
rapido esame della III elegia del I libro, che
costituisce quasi una sintesi
del suo mondo poetico. E' in essa un divagare
continuo, ma non tale da non
permettere di intravedere le linee della
struttura poetica, organizzata con
rara sagacia.
Il poeta è ammalato, a Corfù, e teme di morire lontano dai
suoi, lontano da
Delia. Eppure l'amata, prima della partenza, ha interrogato
gli oracoli e ha
supplicato Iside. Se riuscirà a salvarsi, il poeta celebrerà
piuttosto i
Penati e i Lari. Il ricordo di queste primitive divinità gli
suggerisce la
rievocazione dell'età dell'oro, l'epoca di Saturno e della
felicità, ignara
di viaggi per mare e di guerre. Ora è invece il regno di
Giove, ricco di
stragi e di morte. Eppure Giove dovrà salvarlo. Se dovrà
invece morire, sarà
condotto nei Campi Elisi da Venere, in un regno di
innamorati fatto di danze
e di canti, dove i giovani giocano misti alle
tenere fanciulle. Ma
nell'oltretomba non ci son solo gli Elisi: c'è pure il
luogo di dannazione,
destinato a chi abbia violato l'amore del poeta e a chi
gli abbia augurato
lunga la campagna militare. Ma Delia resti casta: a lei,
raccolta
nell'intimità della casa, mentre la vecchia nutrice le racconta una
favola e
l'ancella che fila la lana s'abbandona al sonno, il poeta
apparirà
improvviso e la sorprenderà; a piedi nudi Delia correrà verso di
lui, coi
lunghi capelli scomposti.
L'immagine di Delia che corre incontro
al poeta è tra le più fini della
poesia tibulliana; ma non solo per se
stessa, per il suo intimo fascino,
quanto sopra tutto perchè non è mai
avvenuta, frutto, soltanto, di un vago
fantasticare. Qui e' l'incanto
particolare delle immagini di T.: nel sognare
e realizzare nel sogno ciò che
potrebbe accadere, ma che non è mai avvenuto
e forse mai sarà.
Nelle
elegie del II libro compare qualche tratto più realistico (solo
qualche
tratto, perchè l'attenzione di T. non ama soffermarsi su ciò che è
attuale e
presente, ma dilatarsi nella speranza, nel desiderio, o nella
rievocazione
del passato). In un caso il poeta raggiunge un'intensissima
suggestione: in
2, 6, 29-43 prega Nemesi di aver pietà di lui, in nome della
sorella morta
anzi tempo. Per convincerla, le prospetta la possibilità che
la sorella le
appaia nel sonno, presso il letto, insanguinata come quando
cadde a
precipizio dall'alta finestra e raggiunse i laghi infernali. E' una
minaccia
che T. fa balenare agli occhi della sua dura puella, ma quella
pozza di
sangue nella strada è troppo cruda per non essere stata anche vera.
La
campagna di T. non è solo quella di Delia e delle tenerezze d'amore. E'
anche
la campagna che, con la sua idillica pace, si contrappone agli avidi
guadagni
e al fragore delle armi. E', ancora, la campagna delle feste
contadine,
quella che conserva i riti antichi del mondo rurale (la I elegia
del II libro
è dedicata agli Ambarvalia, al rito della purificazione dei
campi). Il poeta
è rimasto legato alla fede della sua infanzia, agli dèi
della campagna e del
focolare: nelle sue elegie compaiono i Lari (ai cui
piedi T. correva, da
bambino: cfr. 1, 10, 15 5.) e Silvano e Priapo e Bacco,
e poi Cerere e Pale.
La campagna coi suoi riti è per lui l'approdo sicuro,
ove più genuini si
manifestano gli affetti domestici e i sacri vincoli della
famiglia. Anche
l'esaltazione di Roma, presente nell'elegia 2, 5 (dedicata a
Messalino) si
risolve nella rievocazione, densa di ricordi virgiliani, della
religiosità
agreste del Lazio primitivo.
*Ligdamo. L'attuale III libro consta di 6 elegie
attribuite a un certo
Ligdamo (è cosi che il poeta si nomina in 2, 29) che
canta il suo amore per
una donna, Neera. Si tratta con ogni probabilità di
uno pseudonimo. Solo uno
schiavo, infatti, avrebbe potuto avere un nome
greco, mentre il poeta, come
risulta dalle elegie, si rivela di condizione
libera. Ardua è però
l'identificazione di Ligdamo. L'ipotesi più plausibile è
che sia uno poeti
che fecero parte del circolo di Messalla Corvino (taluni lo
identificano con
lo stesso T., talaltri con Ovidio giovane).
Quel che si
può con sufficiente certezza affermare è che Ligdamo ha letto, e
imitato, sia
T. sia Ovidio, mutuandone immagini ed espressioni per dare vita
al suo ancor
tenue, giovanile mondo poetico. E' innamorato di Neera, con una
dilezione
tenera e casta, e accarezza il sogno di una vita matrimoniale con
lei. Ma
Neera è incostante e infedele, e l'abbandona, lasciandolo affranto
dal
dolore. E nel dolore s'arrovella, certo più di T., e pensa alla morte,
a
Neera che, coi capelli scomposti, e accompagnata dalla madre,
s'avvicinerà
al suo rogo (2, 9-13).
*Il Panegirico di Messala. Il
"Panegyricus Messallae", un elogio di Messalla
composto forse nel 31 a.C.,
anno del suo consolato, apre l'attuale IV libro
del Corpus. E' stato
attribuito a T. giovane, ma sembra troppo lontano dalla
sua arte (con ben
altro fermento fantastico T. ha celebrato Messalla
nell'elegia 1,7). Il
caratteristico divagare tibulliano qui scade in una
retorica, adulatrice
esaltazione di Messalla, oratore (nella I parte) e
condottiero (nella II),
con l'aggiunta di pedanti digressioni sull'Odissea e
sulle cinque zone
climatiche.
*Il ciclo di Sulpicia e Cerinto. Seguono, nel IV libro, 13
componimenti. Gli
ultimi 2 sono verisimilmente tibulliani. Il ciclo di
Sulpicia e Cerinto
occupa dunque 11 elegie (2-12). Le prime 5 narrano le
vicende d'amore di
Sulpicia, nipote di Messalla, col giovane Cerinto. Sono
state attribuite,
con buona probabilità, a T. (ma come suona strano questo T.
che narra amori
altrui!). Gli altri 6 componimenti sono brevissimi biglietti
d'amore
composti, per il suo diletto, forse dalla stessa Sulpicia. In essi
Sulpicia
confessa il suo amore, che è passione di sensi, con
sorprendente
immediatezza espressiva. Brama rivelare il suo amore, e non
tenerlo
nascosto, perchè dolce le è l'aver peccato (7); se ha un pentimento è
per un
mancato incontro d'amore: per aver lasciato solo il suo Cerinto
durante una
notte, troppo preoccupata di nascondergli tutto il suo ardore
(12).
Sesto Properzio
(Assisi? 50 ca a.C. - Roma, dopo il 15
a.C.)
VITA.
P. nacque da agiata famiglia di rango equestre che però,
dopo la guerra
perugina del 41, perse buona parte dei suoi averi. Morto il
padre, fu dalla
madre condotto a Roma, ove fu avviato alla carriera forense.
Ma P. rivelò
molto per tempo le sue attitudini per la poesia. Al 28 a.C.
risale la
pubblicazione del suo I libro di elegie, il cosiddetto monobiblos
("libro
unico"), intitolato dal nome della donna amata (Cynthia), secondo
la
tradizione dei poeti alessandrini.
Hostia era il vero nome della donna,
come ci riferisce Apuleio: il nome
Cinzia sembra collegarsi con Apollo e
Diana, che nacquero a Delo, sul monte
Cinto (si ricordi la Delia di Tibullo).
Cinzia, una fascinosissima donna,
forse più grande di P., dagli occhi neri e
dai capelli fulvi, colta e
mondana, elegante, amante della danza, della
poesia, ma anche di facili
avventure d'amore (e dunque costituzionalmente
infedele) dominò
incontrastata nell'animo del poeta, nonostante il tormento
continuato di un
rapporto reso difficile dalla stessa eccessiva intensità
della passione.
Si amarono, talora nevroticamente, per quasi cinque anni.
Cinzia morì
intorno al 20 a.C., ma, dopo la sua scomparsa, la presenza e il
desideno di
lei si fecero ancora più acuti nella mente del poeta. P. la seguì
nella
morte intorno al 16 a.C. Una vera e definitiva rottura con Cinzia non
ci fu
mai: nonostante le due ultime elegie del III libro, quelle che
vorrebbero
segnare il discidium, la separazione definitiva; nonostante la
morte di lei.
OPERE.
P. compose 4 libri di "elegie". Come monobiblos
fu pubblicato nel 28 il I
libro (22 elegie). Sempre pronto nell'individuare i
migliori talenti,
Mecenate apprezzò le qualità poetiche di P., che fu subito
ammesso nel
celebre 'circolo'.
P. conobbe i più importanti poeti
dell'epoca: da Virgilio a Ovidio, al quale
era solito recitare i propri
roventi versi. Difficili, invece, i rapporti
con Orazio, evidentemente a
causa dei molto diversi ideali poetici. Tibullo
e P. sembrano poi del tutto
ignorarsi: gelosia reciproca?
Tra il 28 e il 25 compose il II libro (34
elegie), che si apre con una
recusatio, un rifiuto da parte del poeta di
coltivare la poesia
epico-celebrativa cui Mecenate pur lo sollecitava.
Pubblicò il II libro
forse insieme col III (25 elegie) nel 22. Il IV libro
(11 elegie), che
contiene le 5 elegie 'romane', volte a cantare leggende e
riti
dell'antichità romana (P. accolse finalmente, anche se con tutta misura
le
richieste di Mecenate), fu probabilmente pubblicato nel 16 a.C., data a
cui
risalgono gli eventi cui vi si fa riferimento.
CONTENUTI E
CONSIDERAZIONI.
Poesia e amore sono due elementi inscindibili in P.. Il poeta
si sente
vittima d'amore, e proclama il suo servitium Amoris, la sua
dedizione totale
alla passione. E' una precisa scelta di vita, lontana dalle
tradizionali
ambizioni del foro e della politica, una vita di nequitia di cui
il poeta è
consapevole; ed è pure una scelta di poesia e di poetica
(illuminante, al
riguardo, è particolarmente la I elegia del I libro): di una
poesia che
esprima una vita dedita all'amore, e che dunque sia idonea a far
innamorare
la donna, e una poetica, quella callimachea, che con sua brevitas
e
l'impiego del mito meglio si presti agli intenti del poeta elegiaco.
A
differenza di Tibullo, che sembra quasi smarrirsi nelle sue fantasie, P.
ha
un'immaginazione corposa, che ama le tinte intense, i bruschi
trapassi.
L'amore è al centro del suo canto, ma un amore fatto sopra tutto di
passione
e di tormento, assoluto e coinvolgente, che si proietta oltre il
reale,
oltre la vita stessa, sino a superare le barriere della morte.
*Di
Cinzia il poeta, già all'inizio del I libro, sottolinea la
prepotente
bellezza fisica (1, 2). E' questa splendida presenza fatta di
carne che
ossessiona il ricordo e alimenta la gelosia di P.. In 1, 11 Cinzia
è a Baia,
allora mondanissimo luogo di villeggiatura, e il poeta la segue con
la mente
sino al momento in cui si delinea, atroce, il sospetto che la donna
possa
abbandonarsi a un'avventura, quella donna che da sola costituiva la
casa, i
genitori, ogni possibilità di gioia per la sua vita (vv. 23
s.):
tu mihi sola domus, tu, Cynthia, sola parentes,
omnia tu nostrae
tempora laetitiae.
E' la totalità radicale di questo amore, è Cinzia che col
suo corpo assilla
la fantasia del poeta. In 2,15 P. descrive una intensa
notte d'amore,
ritratta con un'audacia singolare, che a momenti può ricordare
la lucreziana
follia degli amanti, ma che in effetti vuole esprimere un
bisogno acutissimo
di eternità, il desiderio che quell'amore, quel contatto
fisico possa
durare, ripetuto, all'infinito, in una catena indissolubile:
perchè la vita
è fugace e tutto può, d'un tratto, dileguarsi. La morte
incombe, ma proprio
per questo Cinzia è tanto più bella e amabile, e la
stessa morte è meno da
temere se P. può contare sul costante amore di lei (1,
19). Molto spesso,
nel suo 'Canzoniere', il poeta s'abbandona a fantasie di
morte in connubio
singolare con un prepotente senso dell'eros: è l'amore che
vuole protendersi
oltre la vita e disporsi in una dimensione
definitiva.
P. si compiace di immaginare Cinzia in situazioni difficili,
disperate, come
in 2, 26, ove la donna è ritratta vittima di un naufragio,
già trasportata,
fatta pesante, dalle onde. Fantasie di poeta, che si
sviluppano però non
secondo le morbide volute tibulliane. Piuttosto, si
accaniscono con
straordinaria intensità attorno ad alcuni punti focali
secondo una logica
poetica talora strana, anomala nei suoi trapassi, forse
non sempre del tutto
coerente, ma probabilmente proprio per questo più
accattivante. Nella stessa
elegia in cui si compiace di vedere Cinzia
sbattuta dalle onde, il poeta si
lascia andare a un impossibile sogno
d'amore, proiettato al di là delle
distese marine: se la sua donna vorrà
avventurarsi per l'ampio mare, egli la
seguirà; si addormenteranno sullo
stesso lido, uno stesso albero sarà il
loro tetto, alla stessa sorgente
entrambi berranno (vv. 29 ss.).
P. ama contemplare Cinzia, fissarla in alcuni
momenti di seduzione: nel
giorno del suo compleanno la invita a farsi più
bella che mai, e a indossare
l'abito con cui a lui era apparsa la prima volta
(3, 10); si sofferma a
mirarla dormente in un sonno quasi mitico, in
un'atmosfera satura del
respiro e della presenza dell'amata (1, 3), o, in 2,
29, la contempla appena
sveglia, sola nel suo letto, bella da incantare (vv.
25 s.), prima di una
memorabile scenata d'ira della donna.
Le furie di
Cinzia attirano spesso, con toni intensi e strani, la fantasia
del poeta.
Dolce gli è ricordare le imprecazioni e le coppe colme di vino
che Cinzia,
come una pazza, gli ha lanciato contro (3, 8): sono, per lui,
segni di vera
passione, come i morsi sul collo e le lividure, tanto più che
nell'amore egli
vuole soffrire o sentire che la donna soffre (v. 23).
Singolarissima è la
temperie di 4, 8, ove a una scena ritratta con vivace
realismo subentra
un'atmosfera come di incubo: Cinzia appare all'improvviso,
pur bella nel suo
furore, e interrompe una boccaccesca avventura del poeta
sfogando la sua ira
sulle sue due amichette e, con schiaffi e morsi, sul
poeta stesso.
La
Cinzia di 4, 8 appare prepotentemente viva, nel suo furore, nella
gelosia,
nella passione che attraversa le sue membra. E' questa presenza,
assillante,
del corpo della donna che si pone al centro dell'immaginazione
del poeta e
sollecita le più vane e strane fantasie. Nell'elegia che
immediatamente
precede (4, 7), Cinzia è vista, dopo la sua morte, da poco
sepolta, apparire
di notte a P.. E' l'apparizione di una defunta; eppure c'è
ancora il senso
della carne, di quel corpo che continua ad essere
l'ossessione del poeta:
Cinzia sembra quasi che s'appoggi col suo peso sul
letto di P., dopo le sue
esequie, le esequie di un amore, con gli stessi
occhi, gli stessi capelli che
aveva al momento del funerale, con la veste
bruciata al fianco e le labbra
scolorite. Cinzia parla a P., e gli rammenta
le gioie furtive d'amore nella
Suburra, il davanzale della sua finestra
logorato dalle segrete fughe
notturne e gli abbracci sul trivio e la strada
che, attraverso i mantelli
distesi, avvertiva il calore dei loro corpi
avvinti. Ora, la casa un tempo
piena della sua presenza, è dominata da
un'altra. Ma non s'illuda P.: per il
momento lo possiedano pure altre donne,
chè presto lei sola lo terrà, e
sfregherà, mescolandole, le proprie ossa
contro le sue (vv. 93
s.).
L'elegia segna il culmine dell'esperienza poetica di P.: l'amore che
va
oltre la vita, ma - e questo è il suo carattere precipuo - con un
senso
quasi oppressivo della presenza carnale di Cinzia.
*Il mito e le
"Elegie romane". Pure per altra via la presenza di Cinzia
diviene, nel poeta,
memoria grandiosa. P. eredita dalla poetica
alessandrina, di cui è stato a
Roma finissimo interprete, l'impiego del
mito, ma non di un mito inteso
puramente come brillante e talora divertito
sfoggio di erudizione. In P. la
realtà stessa viene rivissuta alla luce del
mito: sopra ogni cosa, Cinzia.
L'intero suo mondo degli affetti viene
trasfigurato e, per così dire,
eternato dall'atmosfera incantata del mito.
L'esperienza d'amore del poeta
viene così sublimata da una luce ideale e Cin
zia, la creatura di sangue e di
passione, viene intravista in una dimensione
mitica. Persino il ricordo di
Licinna, la schiava di Cinzia che al poeta
giovane aveva rivelato i segreti
dell'amore, ed era stata fatta oggetto
delle ire gelose della padrona,
persino l'umile Licinna, vittima di ingiuste
vessazioni, suggerisce a P. la
rievocazione di un mito di dolore, quello di
Antiope, forse il suo mito più
patetico e intenso (3, 15).
Effettivamente, la trasfigurazione mitica è, per
P., il mezzo ideale per
sublimare la realtà, e resterà costante nell'intera
sua produzione poetica.
In altri termini, non è da ravvisare una frattura
spirituale e artistica tra
il P. cantore d'amore e il P. che canta antichi
miti romani e italici. Dopo
la pubblicazione del I libro, abbiamo visto, egli
viene accolto nel circolo
di Mecenate, che cerca, in sintonia con la politica
culturale, etica e
religiosa del regime augusteo, di indirizzarlo verso un
tipo di poesia più
elevata, atta a celebrare le glorie romane. Più volte, con
amabili
recusationes, P. si schermisce: la sua Musa è troppo tenue per poter
cantare
argomenti di tanto impegno. Egli si appella a quelli che considera i
suoi
maestri, come Filita e ancor più Callimaco, che aveva disdegnato la
poesia
epica e celebrativa a favore del componimento breve e ricercato (P. è
anche
attentissimo lettore di epigrammi ellenistici i cui motivi trasfonde
sovente
nelle sue elegie). Alla fine, pur dopo vane e non sempre
chiare
oscillazioni, P. cede alle sollecitazioni di Mecenate e si decide a
comporre
alcune elegie relative alle origini di antiche tradizioni di Roma,
collegate
con culti o luoghi particolari. Alla base, ancora una volta, è
Callimaco coi
suoi Aitia, il poema sulle origini di antichi riti e
istituzioni (come
"Callimaco romano" P. si presenta nell'elegia proemiale del
IV libro). Le
"Elegie romane" (la II, IV, VI, IX, X del quarto libro)
introducono nella
letteratura latina l'elegia di tipo eziologico, che Ovidio
riprenderà e
svilupperà nei suoi Fasti.
P. rivive dunque le origini di
storie e leggende dell'antica Roma
collegandosi alla lezione di Callimaco, ma
con una visione finale del mito
che certamente supera gli angusti ambiti
entro cui il poeta di Cirene lo
aveva costretto. Al 'mito' di Cinzia subentra
(o, meglio, s'alterna nella
singolare compagine del IV libro) quello di Roma
con un atteggiamento
poetico sostanzialmente coerente. Perchè mito è per P.
elevare la realtà
attuale in un passato esemplare che la renda in certo modo
eterna. E' il
continuo trasferire la contingenza del reale in una dimensione
ideale ad
assicurare la continuità di ispirazione nella pur tanto complessa
produzione
poetica properziana. Nelle elegie romane P., come Virgilio
nell'VIII libro
dell'Eneide, vagheggia l'età primitiva di Roma e canta
vicende remote,
circonfuse di un'aura leggendaria, come le origini del culto
di Giove
Feretno (10), Ercole e Caco (9), ma sopra tutto la leggenda di
Tarpea (4),
la fanciulla che per amore, almeno nella versione properziana,
tradisce la
sua patria, e che, al solo vederlo, s'innamora di Tito Tazio, il
re nemico
di cui amerebbe divenir prigioniera. E poi c'è la gustosissima
elegia che
canta Vertumno (2), una strana divinità capace di trasformarsi in
ogni cosa
e di rivestire ogni forma: un'elegia che traduce il tema eziologico
in un
vivace gioco fantastico.
Nel contesto del IV libro particolare
rilievo assumono ancora due elegie,
nelle quali il cantore appassionato di
Cinzia esalta il casto amore
coniugale. La III elegia è una lettera che
Aretusa invia al marito Licota
impegnato in una spedizione militare, una
lettera densa di trepidazione,
desiderio, gelosia della donna per il marito
lontano. Con ogni probabilità
Ovidio tenne presente questa epistola in forma
di elegia per la composizione
delle sue Heroides. L'ultima elegia del IV
libro (11), che la tradizione
suole denominare regina elegiarum, si risolve
in una celebrazione delle
antiche virtù delle matrone romane. L'esaltazione
dei valori tradizionali e
il tema dell'amore si fondono nelle nobili parole
che, dopo la morte,
Cornelia rivolge al marito Emilio Paolo. Traspare in
esse, con una spoglia
essenzialità, rara in P., la dedizione totale di una
donna alla sua
famiglia, la sua intemerata fedeltà, uno spirito di
abnegazione che ricorda
l'Alcesti euripidea, il delicatissimo amore nei
confronti dei figli col
desiderio, sottile, di continuare a esser presente
nella casa che una volta
fu sua.
LA LINGUA E LO
STILE.
All'intensità sentimentale dell'elegia properziana corrisponde una
temperie
stilistica densa, fatta di scorci, di trapassi arditi, in una
concentrazione
talora estrema, che costringe il lettore a indugiare di
continuo per
cogliere la pregnanza spesso oscura di un'espressione. A termini
dotti e
ricercati s'alternano, nei contesti più realistici, espressioni
del
linguaggio quotidiano, in una tensione stilistica ricca di ambiguità.
E'
arduo talora cogliere a pieno l'intera valenza connotativa
di
un'espressione, come è difficile, almeno all'inizio,
individuare,
nell'intreccio delle sue articolazioni, la struttura di
un'elegia
properziana: è una tecnica eminentemente composita, nella quale
sembra
tradursi l'animo stesso, appassionato e contorto, del poeta. Di qui
gli
inizi improvvisi, assai suggestivi, delle sue elegie; di qui i
passaggi
sintattici e concettuali repentini e, almeno in apparenza, lontani
da ogni
coerenza logica. Le sue espressioni hanno la concentrazione incisiva
delle
epigrafi, una densità che sembra di fiamma (ignes definì Ovidio i versi
di
P.), ma anche, all'occasione, una certa patina di leggera ironia, che
sembra
svelare, in alcuni momenti, il gioco del poeta,
ondeggiante tra
fantasia e realtà, la sua capacità di distaccarsi
dall'oggetto della sua
passione, e di ragionare, un po' divertito, sulla
passione stessa. Il tutto
con un linguaggio poetico elevato, informato a una
dotta eleganza.
Nelle
elegie s'avverte un incalzare di immagini che s'addensano come in
blocchi,
fervidi di idee e di allusività. Una tecnica che è lontana dalle
ampie volute
tibulliane come dalle 'emozioni' catulliane. Rispetto al
Veronese, che dà
risalto al particolare sia esso di gioia, d'amore o di
dolore, in P. c'è
un'atmosfera mitica che pone ogni cosa in una prospettiva
ideale, appena
temperata da un trasparente velo di ironia.
Publio Ovidio
Nasone
(Sulmona, Abruzzo 43 a.C. - Tomi, Mar Nero 17-18
d.C.)
VITA.
O. nacque da antica e agiata famiglia equestre
(nell'elegia 4, 10 dei
Tristia è il poeta stesso a trasmetterci notizie sulla
sua vita). A Roma,
ove si recò col fratello, studiò grammatica e retorica
presso insigni
maestri come Arellio Fusco e Porcio Latrone. Destinato alla
carriera forense
e politica, O. avvertì invece imperiosa l'inclinazione verso
la poesia, al
punto che tutto ciò che tentava di dire era già in versi (et
quod temptabam
dicere versus erat). Dopo il rituale viaggio di
perfezionamento ad Atene, O.
rientrò a Roma, ove esercitò solo qualche
magistratura minore. Ad alimentare
la sua vocazione poetica fu Valerio
Messalla Corvino; ma O. fu vicino pure a
Mecenate, e conobbe i maggiori poeti
dell'epoca, come Orazio, Properzio,
Gallo (solo per poco vide Virgilio). Ebbe
tre mogli: dopo due matrimoni
sfortunati (ma ebbe una figlia, forse dalla
seconda moglie), sposò una
giovane fanciulla della gens Fabia che amò
teneramente sino alla fine. Il
legame coniugale non gli impedì di essere il
poeta galante, cantore di una
Roma ormai dimentica delle guerre civili,
vogliosa soltanto di vivere e di
godere.
Nell'8 d.c., quando ogni cosa
sembrava sorridergli, il poeta fu colpito da
un ordine di Augusto (revocato
neanche dal successore Tiberio), che lo
relegava a Tomi, l'attuale Costanza,
sulle coste del Ponto (il Mar Nero). Si
trattò, e' vero, di una relegatio
che, a differenza dell'exilium, non
prevedeva la perdita dei diritti di
cittadino e la confisca dei beni. E
tuttavia, di fatto, O. fu costretto a
rimanere isolato in una terra
selvaggia e inospitale, nella più cupa
tristezza, sino alla morte, che lo
colse nel 17 (o 18) d.c.
Ignoti restano
i motivi del severo provvedimento di Augusto, anche se O.
parla,
enigmaticamente, di due colpe che l'avrebbero perduto (trist. 2, 1,
207):
carmen et error. Nel carmen deve essere allusione all' Ars amatoria,
il suo
trattato sull'amore libertino che, contemporaneamente alla condanna,
venne
ritirato dalle biblioteche pubbliche. Riguardo l'error, l'ipotesi
più
verisimile è che O. sia stato coinvolto in uno scandalo di corte: fatto
è
che nello stesso anno, pure Giulia minore, nipote di Augusto, fu
relegata
nelle isole Tremiti, accusata di adulterio col giovane patrizio
Decimo
Silano.
OPERE E CONSIDERAZIONI.
Possiamo dividere la
multiforme attività poetica di O. in tre momenti che
corrispondono ad
altrettante fasi della sua vita.
Al primo periodo appartengono le poesie
erotiche, che cantano l'amore nella
galante cornice della vita di Roma: gli
"Amores", un canzoniere d'amore, le
"Heroides", lettere di eroine ai loro
infedeli amanti, l' "Ars amatoria",
una precettistica dell'arte d'amare, i
"Medicamina faciei femineae", un
trattato di cosmetica, i "Remedia amoris",
composti per aiutare a guarire
dalle pene d'amore.
Al secondo periodo
appartengono le opere mitologico-narrative, di più ampio
respiro, composte a
partire dal 3 d.C., e in varia misura collegate con la
celebrazione del
principato: sono le "Metamorfosi", il poema delle
trasformazioni e i "Fasti",
un poema che doveva illustrare il calendario
romano, ma che fu interrotto
dalla relegazione del poeta a Tomi.
II terzo periodo e' quello dell'esilio e
comprende la composizione dei
"Tristia" e delle "Epistulae ex Ponto", i canti
della solitudine e della
nostalgia, della noia e della disperazione.
*Gli
Amores. Gli Amores, in 3 libri (una I ed. era però in 5 libri),
furono
composti tra il 23 e il 14 a.C.: O. ne iniziò la composizione,
dunque,
intorno ai vent'anni.
Sono elegie di carattere amoroso nelle quali
è cantata una donna, Corinna.
Ma Corinna è uno pseudonimo (è il nome di una
poetessa greca)forse di un
personaggio puramente letterario. Quel che si può
con certezza affermare è
che Corinna è lontanissima dalle donne intensamente
vagheggiate dagli altri
poeti d'amore latini. Ella sembra sintetizzare tutti
quanti gli 'amori' di
un poeta che, per indole, non poteva cantare un'unica
passione. Corinna è
donna, almeno nella fantasia poetica e al contempo, è un
insieme di donne,
la somma di esperienze erotiche o semplicemente galanti che
il poeta vive in
una Roma splendida. in una società smaliziata e
gaudente.
Amore come avventura, dunque, con tutto ciò che ogni avventura
comporta:
corteggiamento, attese, vezzose ritrosie, conquiste mai definitive,
ma
legate al momento, a un cenno di compiacenza, a un assenso
finalmente
ottenuto ma pronto a dissolversi alle prime nuove brezze. Arguto è
O. in
questo gioco dei sentimenti, d'una arguzia gradevolmente ironica,
che
costituisce una delle note più gustose di questo suo disincantato
mondo
poetico. E' una sequela di quadri, di scene di vita, che s'alternano
a
precetti d'amore, a casistiche varie, alle infinite situazioni
che
l'incontro di una donna può destare. Il tutto con un distico
elegiaco
estremamente musicale che segue con rara aderenza la materia
trattata.
Ad alimentare la fantasia ovidiana è la precedente produzione
elegiaca, e'
una serie di "luoghi comuni" (come il lamento davanti alla porta
dell'amata,
il servizio d'amore inteso come milizia...); è l'epigramma
ellenistico
d'amore, invece, che gli suggerisce variazioni su tema pressochè
infinite;
ma è anche una Roma brillante e festosa, che viene ad essere
eternata nei
lievi, cantabili distici ovidiani. Sorprendente, sin d'ora, è
l'attitudine
del poeta a scavare entro le pieghe riposte della psicologia
femminile (la
composizione delle Heroides, vero capolavoro in questo senso, è
forse
contemporanea a quella degli Amores). Un'attenzione per la donna e il
suo
mondo che resterà costante nella poesia del Sulmonese.
Quella degli
Amores e' una poesia di una superficialità che incanta, che
dell'amore sembra
preferire i soli 'esterni' in una società che tutta pare
ridursi a vivere in
un perenne gioco galante. Arte della variazione spinta
al massimo, e non solo
dal punto di vista letterario. O. non può, diremmo
costituzionalmente,
riconoscere un unico oggetto d'amore: tutte gli
piacciono le belle romane, e
a nessuna si sente di opporre resistenza. Non
una bellezza definita suscita
in lui l'amore: ogni donna ha una sua
attrattiva, a volte particolarissima,
che in maniera irresistibile, riesce a
sedurlo (2, 4). Sono amori che
iniziano e finiscono spesso Lì dove sono
nati, che sembrano, nonostante le
promesse, esaurirsi in un'amabile corte
(come in quella, impareggiabile, che
il poeta rivolge a una gran bella
donna, tutta gambe e sorrisi, che, accanto
a lui, assiste alle corse dei
carri nel Circo (3, 2).
*Le Heroides. Le
Heroides (il nome in origine dové però essere quello di
Epistulae heroidum)
sono 21 lettere d'amore in metro elegiaco, indirizzate
da donne, in genere
del mondo del mito, ai loro amanti. In particolare, 14
sono lettere di eroine
mitiche (come di Penelope a Ulisse, Fedra a Ippolito,
Didone a Enea, Medea a
Giasone...), una è della poetessa Saffo a Faone; le
ultime 6, disposte a
coppie, e composte da O. forse successivamente, sono
lettere di eroi alle
loro amate, seguite dalla risposta di queste. Domina,
nelle epistole, la
forma retorica della suasoria, del discorso cioè che
tende a convincere
qualcuno a compiere una determinata azione: in questo
caso a ricambiare un
amore. O. può vantarsi (ars 3, 346) di avere, con le
Heroides, introdotto un
genere nuovo nella letteratura antica, cioè
l'epistola erotica in versi,
anche se indubbio precedente era l'epistola
properziana (4, 3) di Aretusa a
Licota (due pseudonimi che cela\'ano
personaggi reali, a differenza di O. che
attinge dalla sfera del mito).
Il mito e la donna: e' questo il fulcro
poetico delle Heroides ovidiane.
Certo, non nel senso properziano
dell'idealizzazione mitica della figura
femminile. Piuttosto, O. umanizza le
antiche eroine. Le solenni vicende del
mito rivivono col palpito delle
passioni e dei turbamenti delle donne della
Roma di O., delle donne di
sempre. Alla base è il motivo dell'amore
infelice, quale fu cantato dalla
poesia alessandrina, in particolare quello
della donna abbandonata. Accanto a
questa fondamentale fonte di ispirazione
s'affiancano numerose altre
suggestioni letterarie: Omero e i tragici greci,
e poi Catullo, Virgilio,
Orazio.
Ad animare l'ampio materiale proveniente dalla letteratura
precedente, è
l'eccezionale capacità di O., erede, in questo, di Euripide, di
penetrare
negli intimi recessi dell'animo femminile, a sondarne i sentimenti
pur
attraverso ripetizioni, riprese, frasi dette e poi smentite, in un
vortice
di immagini ricche di sfaccettature e di risvolti insospettati. O.,
allievo
delle scuole di retorica, Si rivela maestro in quest'arte di andare a
fondo
di una situazione spirituale, di esaminarne, uno per uno, i possibili
(e
talora impossibili) esiti. Rischio di tale operazione poteva essere
quello
di ridurre ogni afflato sentimentale a una serie di giochi
d'intelletto, di
battute a freddo, in lunghi, sempre uguali monologhi di
anime affrante. In
effetti, la preparazione retorica ha offerto al poeta uno
strumento
eccellente per sviscerare a fondo la complessità dell'animo
femminile; è
divenuta essa stessa mezzo mirabile per l'espressione di un
contorto mondo
spirituale, di idee e immagini ripetute talora in maniera
ossessiva.
Al centro, è la donna del mito, ma resa umana, quasi ridotta in
frammenti di
impulsi e di sensazioni. E' la donna eterna che trionfa
sull'idealizzazione
mitica, la donna di sempre con le sue emozioni, le sue
solitudini, la
tormentosa sensibilità. E proprio quest'arte di frantumazione
del mondo
sentimentale che consente a O. di gettare un fascio di luce su
passioni
anche scabrose, su segreti inconfessabili, su certi chiaroscuri che
verranno
ripresi e sviluppati dalla successiva letteratura imperiale. Le
Heroides
sono forse l'opera più 'moderna' di O., in cui l'animo femminile si
rivela
con inedita verità. Torna al sommario
Molto varie sono le
vibrazioni sentimentali delle Heroides: la penetrante,
straordinariamente
'soffice' seduzione che Fedra vuole a tutti i costi
esercitare su Ippolito,
l'amato figliastro (4); la vanità, tanto intensa
quanto puritana, di Elena
che non vuol cedere, ma cede, a Paride (17);
l'atmosfera 'romantica' e le
incantate sospensioni, paesistiche e
sentimentali, che fanno da sfondo
all'impossibile storia di Ero e Leandro
(18). Impossibile e scellerata la
passione di Canace per il fratello Macareo
(11): la lettera che Canace scrive
prima di uccidersi è densa di cupo
pathos, storia di un amore che si risolve
in tragici preparativi di morte.
Atmosfera di morte e di tristezza
inconsolabile anche nella lettera di
Laodamia a Protesilao, nella sua
trepidazione, nei presagi di lutto, in
quella stessa immagine di cera che
riproduce le fattezze del marito, e che
Laodamia troppo morbosamente conserva
e accarezza (13, 151 ss.).
*L'Ars amatoria. L'Ars amatoria (il titolo deriva
dal primo verso
dell'opera), composti tra l'1 a.C. e l''l d.C., consta di 3
libri in distici
elegiaci. I primi due libri sono indirizzati agli uomini, ai
quali O.
insegna come incontrare, conquistare (1), conservare (II) l'amore di
una
donna; nel III, composto in un secondo momento, il poeta rivolge gli
stessi
consigli alle donne. Torna al sommario
Anche l'Ars amatoria
costituisce un genere nuovo. Si presenta, nella
struttura, come un'opera
didascalica (del tipo delle Georgiche virgiliane),
ma coi contenuti
caratteristici del più smaliziato mondo poetico ovidiano.
L'opera vuole
essere un trattato sui comportamenti d'amore, vera summa - e
culmine - di
tutta l'elegia latina precedente, una precettistica di
galanteria erotica,
condita di arguzie e piacevolezze, ma nella struttura
del poema didascalico.
Di qui un contrasto sottile, che offre al poeta
l'occasione per istituire un
suo gioco, intellettualistico e ironico, su
quell'eterno gioco che è l'amore
(egli è lascivi... praeceptor Amoris: 2,
497). L'Ars amatoria (che già nel
titolo riecheggia da un lato le coeve
artes oratoriae, dall'altro le "arti
d'amare" dei filosofi greci) dispone in
maniera organica quei precetti che
più di una volta, anche se in forma
isolata, erano gia apparsi negli Amores
(qualche spunto 'precettistico' era
anche in Tibullo e in Properzio); ma e'
una precettistica molto poco
austera, chè ogni situazione d'amore resta solo
frivola avventura,
arricchita da digressioni, gustosi riferimenti al mondo
del mito o alla
storia o alla leggenda (in alcuni 'affreschi' mitici è gia
prefigurato
quello che sarà il mondo delle Metamorfosi). Al di sopra di
tutto, al di
sopra dei luoghi comuni, dei consigli d'amore, delle scene di
vita come
degli squarci di mito è la sorridente arguzia del poeta, che con
arte
suprema e impeccabile impegno formale ha creato un mondo in cui tutto
sembra
accordarsi, anche gli inganni, gli spergiuri e le astute simulazioni,
in una
superiore armonia. Sullo sfondo, ancora la Roma degli Amores, una
Roma
fissata in un'atmosfera di magica luminosità. Una Roma nelle cui
vie
affollate unica dominatrice sembra essere la donna, con l'incanto delle
sue
apparizioni, con la gioia e il senso di vita che riesce a infondere.
Questo
ovidiano è sopra tutto un mondo di grazia e di eleganza, ove ognuno
trova la
propria dimensione in un impegno d'amore che è, sì, coinvolgente, ma
che mai
assorbe troppo sul serio.
Anche gli dèi e gli eroi sembrano far
parte di questo mondo ove tutto si
riduce a levità, gioco superficiale ma
terribilmente ammaliante. Si pensi a
Ulisse e Calipso che discutono sulla
spiaggia: Ulisse è arso dal desiderio
di rivedere la patria; Calipso,
tristemente consapevole di un abbandono che
vede imminente, ancora vuole
riascoltare dalle labbra dell'amato le sue
eroiche vicende, quando
all'improvviso un'onda cancella i tratti coi quali,
sull'arena, Ulisse aveva
disegnato e Troia e il Simoenta e i grandi
accampamenti (2, 123-142). Il mito
si è come dissolto in tocco leggero, un
piacevole conversare, in segni
tracciati su un lido che un'onda può in un
attimo cancellare. Si pensi,
ancora, all'atmosfera di magica attesa in cui
si risolve la tragica storia di
Procri, invano gelosa dell'amato Cefalo (3,
687-746) o alla festevole
leggerezza con cui si conclude quella vicenda di
Bacco e Arianna (1, 525-~61)
che con intenso pathos Catullo aveva cantato
neT c. 64.
*Opera a suo modo
precettistica è pure il De medicamine faciei ('L'arte del
trucco'), un
trattatello di cosmetica di circa cento versi in metro elegiaco
con cui O.
indica alle donne come rendere più attraente la loro bellezza.
Torna al
sommario
*I Remedia amoris, sempre in distici elegiaci (per Un totale di
circa
ottocento versi), vogliono invece insegnare i mezzi con cui si curano
gli
effetti nefasti dell'amore. In particolare deg1i amori sfortunati. Con
fine
ironia, che vuole ripetere quella dell'Ars, il poeta invita
1'amante
infelice a considerare i difetti dell'amata, a fuggire la solitudine
e,
insomma, a 'distrarsi'. Importante è poi ostacolare la mala passione
quand'è
all'inizio, prima che col tempo abbia modo di prender forza . Amabile
gioco,
questo di O., che mostra di ritrattare, ma con infinito garbo,
gli
insegnamenti dell'Ars.
*Le Metamorfosi. Le Metamorfosi (Metamorphoseon
libri XV), il 'poema delle
trasformazioni', che O. iniziò a comporre intorno
al 3 d.C., sono in 15
libri di esametri, contenenti circa 250 miti uniti tra
loro dal tema della
trasformazione: uomini o creature del mito si mutano in
parti della natura,
animata e inanimata, in rocce, piante, animali... Torna
al sommario
Opera in apparenza disorganica, le Metamorfosi rivelano la loro
unita nella
concezione di una natura animata, fatta di miti divenuti materia
vivente,
partecipe di un tutto che si trasforma: una natura intesa come
archivio
fremente di storie trascorse, ove è possibile avvertire la presenza
di una
creatura mitica in un albero, in una fonte, in un sasso.
Numerose
possono essere considerate le 'fonti' ovidiane. Raccolte di miti
circolavano
in repertori che O. deve aver certamente conosciuto. Il tema
della
trasformazione era poi caro alla letteratura alessandrina: basti
pensare a
Callimaco e a Eratostene, e poi alle "Trasformazioni" di Nicandro
di Colofone
e di Partenio di Nicea; ma era stato trattato pure nel mondo
latino
nell'Orniithogonia di Emilio Macro e, occasionalmente, pure dai
neoteroi, da
Catullo e da Virgilio (nella poesia omerica era il modello di
ogni
trasformazione: quella, operata dalla maga Circe, dei compagni di
Ulisse in
porci). O., insomma, aveva alle spalle un enorme patrimonio
mitologico e
letterario, che indubbiamente traspare dalla lettura della sua
opera. E
tuttavia nuovo è il risultato dell'operazione ovidiana, che si
sviluppa
all'insegna della più fervida e colorita fantasia, con uno stile e
un metro
(un esametro insuperabile per musicalità) che con la Toro
sapientissima
"facilità" sembrano mirabilmente accompagnare la perpetua
vicenda delle
mutazioni e l'illusorietà delle forme, soggette a continui
cangiamenti, in
una continuità quasi organica che lega l'uomo alla natura.
Le Metamorfosi
iniziano dalla più antica trasformazione, quella del Chaos
primitivo nel
cosmo, sino a pervenire alla trasformazione in astro (=
catasterismo) di
Cesare divinizzato e alla celebrazione di Augusto. E' cosi
che O. intende
ripercorrere tutte le fasi del mito e della storia. Il motivo
conduttore è
dunque quello della mutazione continua: dalle remote origini
del cosmo sino
alla glorificazione della dinastia giulia.
II poeta si dichiara convinto, già
nei primi versi dell'opera di comporre un
carmen continuum, un'opera, cioè,
profondamente unitaria, anche dal punto di
vista 'cronologico' (dalle origini
all'attuale gloria di Roma).
Significativo, ai fini degli intenti unitari del
poeta, è il discorso che,
nel XV libro, O. pone sulle labbra di Pitagora, e
che contiene una
particolare concezione dell'universo, inteso come luogo di
eterna
trasformazione.
Al di là di questa intelaiatura di indole
filosofica, al di là delle
dichiarazioni stesse del poeta, le Metamorfosi,
nonostante apparenti
disuguaglianze strutturali, restano un poema unitario e
di superiore
armonia. II poeta salda, con rara sapienza alessandrina, un
episodio
all'altro con legami talora sottili, ma efficaci: ora un mito è
richiamato
per analogia, ora per identità di contenuto, ora per incastro in
altro mito
che fa da cornice, ora è esposto da un personaggio di altra
vicenda. Un
racconto scaturisce dall'altro in una dimensione che pare
dilatarsi
all'infinito.
Dominano nelle Metamorfosi la gioia di narrare,
una gioia morbida,
perennemente variata ed elegante; una fantasia ora lieve e
sfuggente come un
sogno, ora corposa e sensuale, che insiste su scenari
contemplati nel loro
sontuoso rigoglìo o invece immersi in un'atmosfera di
fiaba; un'arte
plastica che indugia nel ritrarre la spettacolare storia delle
mutazioni che
il poeta stesso contempla stupefatto, incantato o addolorato
per la
sofferenza di creature che cambiano, coscienti, il loro aspetto. Il
tutto
con un acuto senso della provvisorietà, della mutevolezza di ciò che
appare
ai sensi e che a un tratto si scompone per diventare altro da
sè.
Della trasformazione, O. mette in risalto ora il carattere repentino
ora,
ancor più, la lentezza graduale, il persistere talora sofferto
dell'antica
natura nella nuova. Dell'uomo che si trasforma in essere arboreo
o inanimato
il poeta avverte l'intimo dolore, la coscienza di divenire altro
in una
trasmutazione che sembra investire le radici stesse
dell'universo.
La natura ovidiana appare percorsa dai fremiti arcani delle
tante creature
d'amore e di dolore che essa cela nel suo grembo. E' qui che
il mondo di O.,
così in apparenza legato alle forme e alle superfici, ai
suoni e ai colori,
rivela dimensioni insospettate. Sì, certo, in O. il mito,
oltre che
umanizzarsi, si atteggia a splendida favola, ad affresco fastoso
(gli dèi e
gli eroi, scomparsa ogni motivazione religiosa del mito, servono
solo ad
alimentare la sfarzosa immaginazione del poeta); e tuttavia, specie
in
alcuni casi, il brillante gioco delle superfici s'accompagna, in
singolare
simbiosi, a una sensibilità inquieta di creature tormentate, che
trovano nel
trasformarsi l'unica via d'uscita a una situazione impossibile, a
una
passione assurda. Nel divenire finalmente altra cosa rispetto a una
realtà
divenuta umanamente intollerabile, esse ritrovano il loro
riscatto.
Cosi è di Biblide, consumata da folle amore per il fratello Cauno:
a lei non
resta alla fine, perduta di mente, che andare errando, per poi
accasciarsi a
terra e piangere e sciogliersi nelle lacrime e tramutarsi in
fonte (9,
630-665). Sensualita' esasperata e insana, come quella di Mirra,
pazza del
padre Cinira, che al termine di una sciagurata vicenda chiede agli
dèi di
venir trasformata, per non contaminare con la sua presenza il mondo
dei vivi
nè con la sua morte quello dei defunti. Ed eccola tramutarsi in
pianta,
gradualmente, e mentre sempre più viene avvolta dal tronco nascente,
quasi
smaniosa di por fine all'insostenibile sua vergogna, Mirra immerge il
volto
nella corteccia per affrettare la mutazione; ma pur continua a
piangere:
lacrime usciranno da quel tronco, e saranno mirra (10,
476-502).
Accanto al mito, l'amore è dunque 1'altro grande tema delle
Metamorfosi, ma
non l'amore, fatto di corteggiamenti e galanterie, cantato
negli Amores e
nell'Ars, bensi l'amore del mito (come già nelle Heroides), un
amore che
conosce un'ampia gamma di modulazioni, dalla passione
malata,
all'incantamento, alla dedizione generosa, alla fedeltà coniugale.
Una
soffusa mestizia permea la vicenda di due sposi infelici, Alcione e
Ceice,
che solo grazie alla loro trasformazione in uccelli potranno
perpetuare per
sempre i1 loro amore coniugale (11, 573-748). Così come solo
la
trasformazione in alberi unirà in un vincolo eterno Filemone e Bauci,
che
ricevono lo straordinario onore di accogliere nella loro umile capanna
(che
diverrà un tempio) nientemeno che due divinità. In albero si trasforma
pure
Dafne, la ninfa che Apollo continuerà ad amare pur quando sarà
divenuta
corteccia e fronde di un meraviglioso alloro (1,
466-567).
Strani, questi amori delle Metamorfosi, spesso impossibili o
abnormi. Di
Eco, innamorata di Narciso, non resterà che una voce, ma anche
Narciso,
invaghito di se stesso sino a lasciarsi morire, si ridurrà a un
fiore (3,
359-510). Sono, in prevalenza, amori fatti sopra tutto di
sensazioni, di
attrazione per le forme, più che di turbamenti dell'anima:
cosi è di
Pigmalione, incantato da una statua d'avorio che egli stesso ha
scolpito,
una statua che sotto le sue mani diviene a poco a poco realtà
palpitante di
donna viva (10, 243-294); cosi è della ninfa Salmacide che
nell'acqua
avvinghia con febbrile trasporto le sue membra a quelle
dell'amato
fanciullo, sino a divenire un'unica, anomala realtà che mai
potrà
sciogliersi: l'Ermafrodito (4, 288-388). Accanto ai toni
torbidi
dell'episodio di Salmacide, O. sa affiancare, nella sua
variegatissima
'sinfonia', l'amore innocente di Piramo e Tisbe, due giovani
babilonesi che
intensamente si amano, nonostante l'opposizione dei genitori.
Muoiono
entrambi a causa di un tragico equivoco e, per il sangue uscito dai
loro
corpi le bacche del gelso (l'albero del loro fatale incontro) da
bianche
divengono scure (4, 53-166).
*I Fasti. Anche i Fasti sono opera
narrativa, che vuole illustrare il
calendario romano (fasti vale appunto
"calendario"). Composti
contemporaneamente alle Metamorfosi, i Fasti dovevano
comprendere 12 libri
(uno per ogni mese), ma furono interrotti, a causa della
relegazione a Tomi,
ai primi 6 libri, quelli cioè relativi ai mesi che vanno
da gennaio a
giugno. Durante l'esilio, il poeta rivide l'opera, in
particolare il I libro
che, dopo la morte di Augusto, dedicò a Germanico,
figlio adottivo di
Tiberio. Torna al sommario
I Fasti intendono dunque
cantare, in distici elegiaci, le tradizioni romane
nell'ordine in cui
compaiono nel calendario latino. Opera organica, nei
disegni del poeta, a
differenza delle 'Elegie romane' di Properzio, che
avevano selezionato
soltanto alcuni tra i miti antichi; e opera eziologica,
come gli Aitia di
Callimaco, dal momento che intento di O. e' quello di
spiegare le lontane
origini di una festa, di un culto, di un nome. A tale
scopo, il poeta
utilizza sopra tutto l'opera erudita di Varrone e di Verrio
Flacco, nonchè la
storia di Livio (da notare che i Fasti, per la loro
documentazione, restano
testimonianza preziosa di antiquaria latina).
Per la composizione di un'opera
che voleva cantare la religione romana, in
sintonia col severo programma
augusteo di restaurazione, O. mancava tuttavia
di autentiche motivazioni
interiori. Quanto c'è di vivo e vero nei Fasti è
in contrasto con quelli che
dovevano essere gli impegnativi intenti
programmatici. Ai riti, alle feste,
alle sacre istituzioni di Roma antica,
O. s'accosta con spirito disincantato,
ancora con quel gusto di raccontare
che abbiamo visto dominante nelle
Metamorfosi, e con una curiosità tutta
sorridente nei confronti del
divino.
II poeta ha avuto il merito di aver come fissato e trasmesso ai
secoli
un'immagine concreta e verace di quella che a lui appariva la
religiosità
romana. Sono squarci di vita, come la descrizione della festa in
onore di
Anna Perenna, una vecchia dea di Roma (3, 523-542), che trasmette
con vivace
immediatezza l'atmosfera di una festività paesana. 0, ancora,
sono
rievocazioni di antichi personaggi della tradizione, vicende sopra tutto
di
donne, presenti anche nei Fasti col loro fascino tipicamente ovidiano:
può
essere Lucrezia, ritratta nell'incanto che le deriva dalla sua onestà,
bella
sino alla fine, sino al suo suicidio di signora oltraggiata (2,
761-836); o
Silvia, la vestale che commette l'errore di abbandonarsi
sull'erba e di
addormentarsi mentre un dio bramoso la compromette senza
rimedio (3, 11-48);
la naiade Lotide, che pur s'addormenta dopo una festa
dedicata a Bacco
(descritta con toni carichi e sensuali): al chiaro di luna
il dio Priapo le
si avvicina con inequivocabili intenti, ma il raglio di un
asino, svegliando
tutti, pone indecorosamente fine al suo lubrico tentativo
(1, 390-440).
Ancora una volta il mito è avvertito dal poeta in maniera
cordiale, con un
senso di confidente familiarità coi culti, i riti, gli dèi
di Roma che è poi
la dimensione più vera dell'O. dei Fasti. Basterebbe a
documentarlo il
gustoso colloquio che, all'inizio del IV libro, il poeta ha
con Venere,
condotto con spregiudicata grazia alessandrina (4,1-16).
*Le
opere dell'esilio. La produzione ovidiana dell'esilio comprende 5 libri
di
Tristia e 4 libri di Epistulae ex Ponto (tutti in distici elegiaci).
I
Tristia furono scritti tra l'8 e il 12 d.C.; la composizione dei primi
3
libri delle Epistulae ex Ponto risale al 12 (il IV libro, più lungo,
fu
pubblicato postumo).
Le due raccolte differiscono nel fatto che nelle
Epistulae O. nomina
espressamente i destinatari delle 'lettere', che invece
son quasi sempre
taciuti nei Tristia. Per il resto, i contenuti sono in
sostanza identici: la
solitudine e i lamenti dell'esule, la desolazione che
lo circonda, il
rimpianto di Roma e della vita mondana, rimpianto che,
rinnovato, non fa che
acuire lo strazio, l'adulazione, spesso insistente, nei
confronti del
principe nella speranza, inutile, che possa finalmente
richiamarlo da una
terra lontana quanto barbara, ove la vita è sempre
ugualmente grigia e le
giornate interminabili. Il poeta canta e ripete le
stesse cose, con una
monotonia che traduce il devastante disagio di un gran
signore trapiantato
d'un tratto in un ambiente di bruti.
Certo, sono
elegie, queste dell'esilio, disuguali, che troppo spesso
ripiegano su stanchi
luoghi comuni. Eppure, lo stesso O. era conscio dei
difetti di questi suoi
componimenti. In un passo toccante (trist. 4, 1,
1-18) invita il lettore a
volerli comprendere e giustificare, considerando
le circostanze che ne
avevano accompagnato la composizione: solo per un
conforto egli si dedica
alla poesia, e non per trarne gloria (è cosi che O.
sottolinea il potere
consolatorio che ha per lui il canto poetico). Nella
lontananza da Roma,
separato ormai da quella società e da quel pubblico che
gli avevano col loro
plauso riempito la vita, O. scopre l'essenzialità del
dolore, mentre la sua
stessa esperienza umana e poetica si scarnifica. E' un
O. rimasto solo con se
stesso, che piange e ricorda un passato di
spensierate eleganze e di sorrisi
di donna che mai più gli avrebbero
trasmesso il brivido di sentirsi
vivo.
L'espressione poetica accompagna questo processo di scavo interiore
che, col
tempo, si fa sempre più asciutto, sconsolato, sino alla gelida
disperazione
dell'epistola a Flacco (Pont. 1, 10), tristissimo punto d'arrivo
di colui
che, una volta, era stato il celebre cantore di teneri amori
(tenerorum
lusor amorum: tris. 4, 10, 1), ridotto ora a rodersi il cuore in
un affanno
che mai l'abbandona. Alla desolazione interiore s'affianca quella
del
paesaggio, immerso in uno strano torpore, che la lontananza da Roma
rende
ancora più intollerabile.
Nella fantasia di O. resta Roma,
splendida, ricordo monumentale e carissimo,
quale la vide nella notte del
distacco, quando, addolorato e stupito, fu
strappato a quel mondo che era
suo, ai suoi affetti. L'elegia III del I
libro dei Tristia, rievoca quegli
ultimi, fatali momenti: lo smarrimento del
poeta, le lacrime della moglie,
gli amici, pochissimi, che gli restano
vicini, il saluto all'Urbe immersa nel
silenzio notturno, illuminata dal
chiarore lunare. Confinato ormai in un
paese ove anche la primavera è triste
(trist. 3, 12), non gli resta che
chiedere notizie della moglie lontana alle
stelle dell'Orsa, unico punto di
collegamento con un mondo per lui
irrimediabilmente perduto (trist. 4,
3).
Ridotto ormai, poeta che aveva scandagliato in ogni senso l'intimo delle
sue
eroine, a scavare entro se stesso, O. ci ha lasciato, con la X elegia del
IV
libro dei Tristia, prima di morire, una confessione che è anche bilancio
di
tutta una vita e di una esperienza artistica. Torna al sommario
*Altre
opere di O.. Al periodo dell'esilio risale pure il poemetto Ibis, in
distici
elegiaci, rivolto contro un ignoto avversario del poeta, che a lui
augura
ogni male, attingendo da esempi tratti dal mito e dalla storia. Il
titolo,
che allude a un uccello egiziano cui gli antichi attribuivano
immondi
costumi, riprende quello, identico, di un poemetto da Callimaco
diretto
contro Apollonio Rodio.
Possediamo un lungo frammento di 134 esametri di un
poemetto sulla pesca e
sui vari tipi di pesci, ricordato da Plinio il Vecchio
col titolo di
Halieutica (cioè Piscatoria). Sopra tutto per motivi metrici si
dubita possa
essere autentico.
Di O. a noi restano 5 esametri di un poema
astronomico (Phaenomena) e 2
versi di una tragedia, Medea, che ebbe enorme
fortuna nel I sec. d.C.
Niente ci rimane di altre opere, come il poema epico
Gigantomachia, composto
in gioventù, un epitalamio per le nozze di Paolo
Fabio Massimo, un carme in
onore di Augusto scritto in lingua getica.
Non
possono essere attribuiti a O. nè il poemetto Nux (un albero di noce
si
lamenta delle sassate che riceve) nè la Consolatio ad Liviam, composta
in
occasione della morte di Druso (9 a.C.).
Tito Livio
(Padova,
59 a. C. - 17 d. C)
VITA.
Proveniva da nobile famiglia, ma non
partecipò alla vita pubblica: tuttavia,
venuto a Roma, si guadagnò notevole
prestigio fu amico di Augusto e poi
precettore di Claudio, di cui intese gli
interessi storiografici. I suoi
interessi si rivolsero dapprima alla
filosofia, ma ben presto (27-25 a.C.)
si concentrarono interamente sulla sua
opera storica.
OPERA E CONSIDERAZIONI.
*L. compose qualche dialogo
filosofico e una monumentale opera storica in
142 libri: "Ab Urbe condita
libri" ("Libri dalla fondazione di Roma", dallo
stesso autore chiamati
"annales" o semplicemente "libri"), che prendeva
appunto le mosse dalla
fondazione di Roma fino al 9 a. C. o, forse, al 9 d.
C.
*Il lavoro venne
successivamente diviso per decadi (tale scansione forse
rispettava le fasi di
pubblicazione), delle quali sono a noi pervenute:
la I (dalla venuta di Enea
alla III guerra sannitica, 293 a.C.);
la III (sulla II guerra punica, 218-200
a.C.);
la IV (fino alla morte di Filippo il Macedone, 179 a.C.);
la prima
metà della V (fino al trionfo di Paolo Emilio sulla Macedonia,
167
a.C.).
Ossia in tutto 35 libri. Il contenuto della parte perduta è
noto attraverso
brevi estratti e riassunti (le "Perìochae") e commenti (fra
cui quello di
Floro).
*La narrazione di L., non priva di difetti dal punto
di vista storiografico,
si raccomanda per il vivo senso drammatico e per il
colorito poetico: egli,
in effetti, sembra realizzare in sé, abbastanza
esattamente,
quell'equilibrio fra scienza e retorica che costituisce il vero
ideale
dell'epoca augustea: preoccupazione, persino passione della verità, ma
anche
desiderio di comporre opere in grado di competere, in quanto a
bellezza, con
i prodotti della poesia e dell'arte.
*L'opera, tesa a
glorificare la "virtus" romana e l'ideale della "pax
augusta", attraverso il
punto di vista di un nostalgico degl'ideali
repubblicani (solo il grande
passato di Roma indica per lui la via a chi
intendesse rinnovare i fasti
dell'Urbe), si presenta invero, più che come un
'opera storica in senso
stretto, piuttosto come un grande poema epico in
prosa, in quanto concede
largo spazio agli elementi epici, come l'eroismo,
la volontà degli dei, la
missione di Roma, a scapito dell'esame puntuale dei
fatti.
Ciò non vuol
dire che L. non fosse uno storico fondamentalmente "onesto", e
tanto meno -
almeno per quanto già detto - che svolgesse una propaganda di
sostegno
acritico al regime augusteo: anzi, se con esso vi erano punti di
contatto (ad
es., nel culto della "res publica"), L. se ne allontanava
decisamente
rispetto all'ideologia "carismatica" e assolutistica (lo stesso
Augusto gli
rimproverava, amichevolmente, di essere rimasto, in fondo al
cuore, un
"partigiano di Pompeo"). Ciò nonostante, l'impero è
storicamente
"giustificato", come frutto della cooperazione tra la
"fortuna"
provvidenziale e la "virus" del popolo romano, e la stessa crisi
attuale -
pur riconosciuta come "epocale" e non episodica - non viene
astratta dal
quadro generale della storia di Roma.
Insomma, ciò che dà
vita all'opera di L. è, più che una fede politica, un
patriottismo profondo,
un amore dappertutto sensibile per Roma. Sotto questo
riguardo, egli è uno
degli scrittori che più efficacemente hanno contribuito
a diffondere e a far
accettare, nelle province di lingua latina, un'immagine
"romana" di Roma,
esaltante e, per ciò stesso, unificante.
*Inoltre, appare quantomeno
superfluo attardarsi a sottolinearne i difetti
metodologici e scientifici
dell'opera: innanzitutto, l'acriticità nell'uso
delle fonti (ci si è
dilettati, in altri tempi, a cercare quale fosse la
fonte di questo o quel
libro, che si presumeva unica), dagli annalisti
romani a Polibio (come lui,
il nostro è, si potrebbe dire, un "filosofo
della storia"). Ma L. non è,
fondamentalmente, un erudito, ed impiega fonti
già letterarie, e non
"documenti grezzi".
Egli, in effetti, riprende la struttura annalistica, e
tratta ogni anno in
maniera sinottica, dilatando l'ampiezza della narrazione
man mano che si
avvicinava all'epoca contemporanea, secondo le aspettative
dei lettori.
Il piano della sua narrazione è sì impostato sull'ordine
cronologico, ma
egli seppe introdurre, in quello che poteva risultare un
andamento monotono,
varie parentesi drammatiche, episodi che formano quadri
naturali.
Il filo narrativo è spesso interrotto da discorsi, ed è difficile
dire se
sono un prodotto di pura fantasia o se trovano sostegno in qualche
fonte
documentaria più o meno fedele. Si può ipotizzare che la proporzione
fra
verità e invenzione varia secondo le date dei discorsi. Le opere
più
antiche, probabilmente, non si fondano su documenti davvero
autentici,
mentre è probabile che le orazioni più recenti, pronunciate da
questo o
quell'illustre personaggio del II o anche del III secolo a.C.,
fossero
conservate più fedelmente. Lo stesso vale per gli avvenimenti. Il
quadro dei
primi secoli di Roma è più "restaurato", ma è anche più semplice
e, in una
certa misura, più direttamente epico di quello riguardante la
storia più
vicina.
*Infine, nella scrittura, L. si contrappone alla
tendenza di Sallustio,
avvicinandosi piuttosto allo stile vagheggiato da
Cicerone per la
storiografia: la "lactea ubertas" - come la definì
Quintiliano - consisteva
così in una prosa ampia, fluida e luminosa, senza
artifici e restrizioni, di
limpida chiarezza ("candor"). Un periodare,
insomma, destinato alla lettura.
Ma L. sa conferire al proprio stile anche
un'ammirevole duttilità e varietà:
dal gusto arcaicizzante della I decade
(dettato dalla vetustà degli eventi)
ad una sempre maggiore coloritura
poetica e drammatica del racconto, se non
addirittura "tragica", soprattutto
nella descrizione dei personaggi
(Lucrezia, Virginia, Sofonisba, Coriolano,
Camillo, Fabio Massimo,
Scipione.) e "impressionistica" nella presentazione
degli avvenimenti, verso
cui spesso L. tradisce sentimentale
partecipazione.
STORICI MINORI DOPO LIVIO
Gaio Asinio
Pollione
(Teate, 76 a.C. - Roma? 4 d.C.)
Console nel 40 a.C., homo
novus nato da ricca famiglia, fu un convinto
sostenitore di Cesare; dopo la
morte del dittatore appoggiò tiepidamente
Antonio, trattò per lui la pace di
Brindisi ma non lo segui nello scontro
finale con Ottaviano. Durante il
regime augusteo si ritirò a vita privata,
in posizione di larvato
dissenso.
Intellettuale di notevole spessore, fu legato in gioventù ai
neòteroi (Elvio
Cinna gli dedicò un Propempticon Pofilonis) e compose opere
poetiche; fu
oratore di stile attivista (un atticismo quasi esasperato: uno
stile "secco"
fino a rasentare l'oscurità) e storico di indirizzo tucidideo:
scrisse
un'apprezzata storia ("Historiae", 35 a.C. in poi) delle guerre
civili dal I
triumvirato alla battaglia di Filippi, in 17 libri (terreno
dunque
scottante, scandagliato con una certa indifferenza, che però
-
probabilmente - non prendeva forma di aperta opposizione).
Per primo
istituì una biblioteca pubblica (39 a.C.); animò un "circolo" di
letterati e
introdusse l'uso delle recitationes (letture davanti a un
pubblico di
invitati).
Fu amico di Virgilio e di Cornelio Gallo e corrispondente di
Cicerone, nel
cui epistolario sono comprese alcune sue lettere (unici testi
pervenutici
con pochi frammenti delle opere).
Pompeo Trogo
(sec. I
a. C.)
Originario della Gallia Narbonense, scrisse in età augustea alcuni
trattati
scientifici, zoologici e botanici, e una storia universale in 44
libri,
intitolata "Historiae Philippicae".
Con uno stile elaborato e con
tendenze moraleggianti, T. andava dalle
antichissime vicende di Babilonia
fino ai tempi a lui contemporanei, con una
maggiore attenzione alla storia
della Macedonia (libri 7-40), mentre solo i
2 ultimi libri si occupavano
della storia di Roma e delle regioni
occidentali.
Rispetto a Livio, è
cambiata la prospettiva: Roma non è più il punto di
vista privilegiato e
l'attore principale della storia: la sua, per T., è
solo una delle numerose
egemonie succedutesi nei secoli (non a caso, l'
autore come fonte si avvaleva
largamente di Timagene, storico contemporaneo
notevolmente ostile a Roma e al
principato).
Insomma, per T. solo la "fortuna" ha permesso a Roma di
sopraffare l'
"aretè" greca.
Caio Velleio Patercolo
(19 ca a.C. -
dopo 30 d.C.)
Di famiglia campana, fece una discreta carriera pubblica:
questore nel 7 e
pretore nel 14 d.C., non raggiunse il consolato forse perché
coinvolto nella
caduta di Seiano (31 d.C.).
Di lui ci è giunto un
compendio di "Storia romana", in 2 libri, con qualche
lacuna nel I libro:
l'opera inizia con un breve sommario della storia
orientale e greca e si fa
poi più ricca per le vicende recenti.
E' un testo che ben rappresenta quel
tipo di storiografia filo-imperiale
(nella fattispecie, sotto Tiberio)
condannato da Tacito. Interessanti,
comunque, alcune caratterizzazioni di
personaggi (talora "paradossali"),
anche minori, e gli excursus sulla
colonizzazione romana, sulle province,
sull'antica letteratura latina, su
quella del periodo ciceroniano e su
quella augustea. L'artificiosità retorica
ne caratterizza, infine, lo stile.
Valerio Massimo
(sec. I
d.C.)
Dopo aver accompagnato nel proconsolato in Asia il suo protettore
Sesto
Pompeo, scrisse un manuale di esempi retorico-morali, "Factotum et
dictorum
memorabilium libri IX", dedicato all'imperatore Tiberio (le aspre
critiche a
Seiano contenute nell'opera fanno pensare ad una pubblicazione
subito dopo
la sua caduta).
Il materiale, tratto da storici latini e greci
(Livio, Trogo, Varrone.) è
ordinato secondo criteri filosofico-morali (in
primo luogo, l'esaltazione
dei valori tradizionali), ma con un piano non ben
definito: un prontuario di
modelli di vizi e di virtù dove si susseguono
"exempla" romani e stranieri
(soprattutto greci) di moderazione, gratitudine,
castità, crudeltà, ecc.
Dal punto di vista stilistico, sono da rilevare la
ricchezza degli artifici
retorici (tipici dell'età argentea) e il tono
sentenzioso.
Curzio Rufo
(sec. I d.C.)
Compose delle "Historiae
Alexandri Magni" (di tormentata datazione) in 10
libri, di cui sono perduti i
primi 2 e parti del V, del VI, del X.
Sensibile al clima letterario
ellenistico, R. vi rievoca - con ingenua e
fantastica ammirazione - le
imprese del macedone, ponendone in evidenza più
l'aspetto esotico che
l'importanza politico-sociale: facendone, quindi, un
vero e proprio eroe da
romanzo.
L'autore, che ha come modello di stile Livio e che trae spunto da
fonti
greche (Clitarco, Timagene, Aristobulo.), ha quindi certamente inteso
far
opera di narratore - con l'occhio attento al lettore - più che di
vero
storico.
AUTORI DI OPERE SCIENTIFICHE.
Marco
Manilio
(sec. I a.C - I d.C.)
Scrisse, sotto Augusto e Tiberio, un
poema didascalico in esametri,
"Astronomica" (interrotto al V libro), in cui
espone le vicende delle
costellazioni e l'influsso degli astri sul destino
degli uomini.
Di orientamento stoico, è ovviamente in polemica con Lucrezio -
che tuttavia
rimane il suo modello letterario - credendo, di contro, che
l'universo sia
retto e governato dalla divina ragione.
L'opera rivela
abilità tecnica e talento letterario.
Continua>
|
|
|
|
|
|
 | |